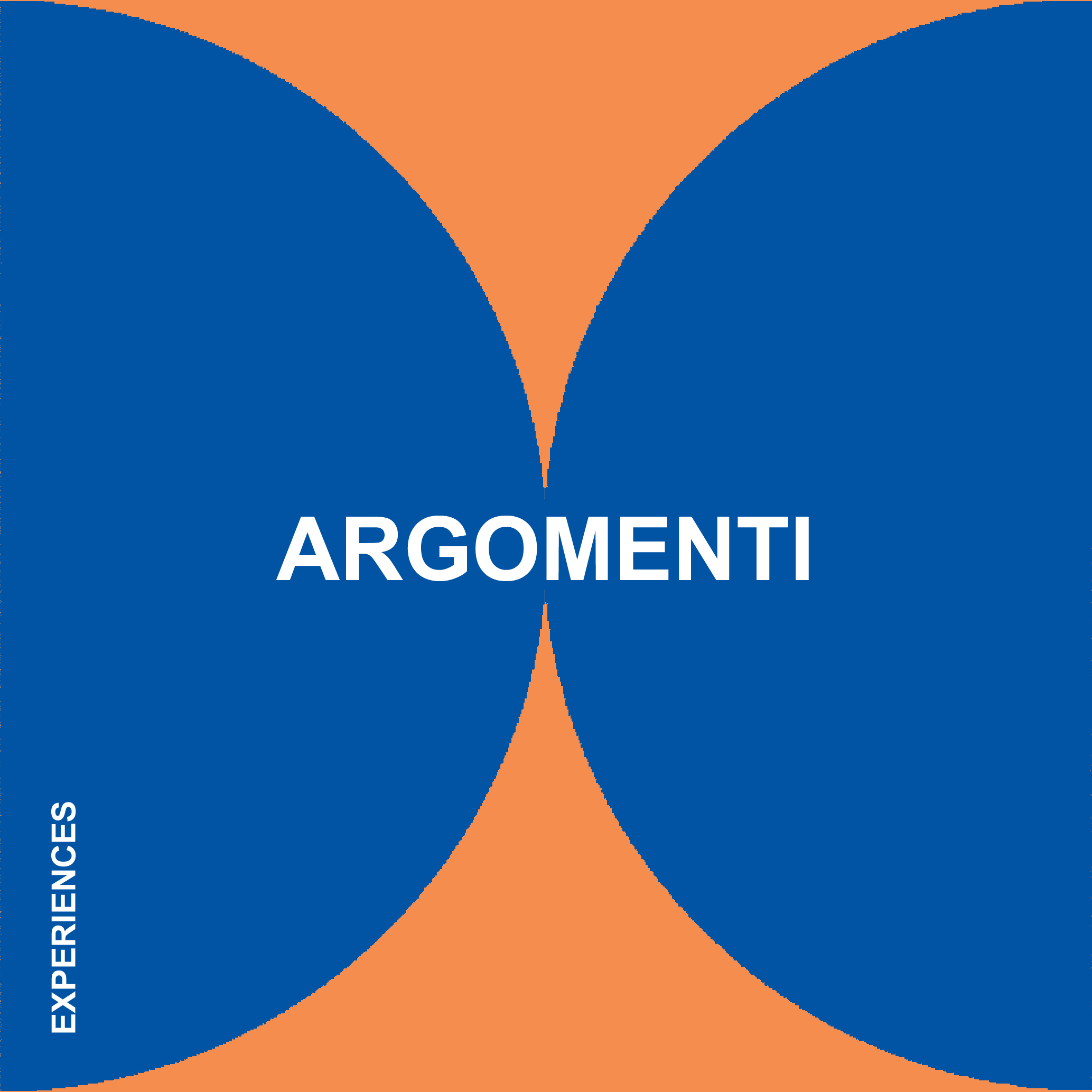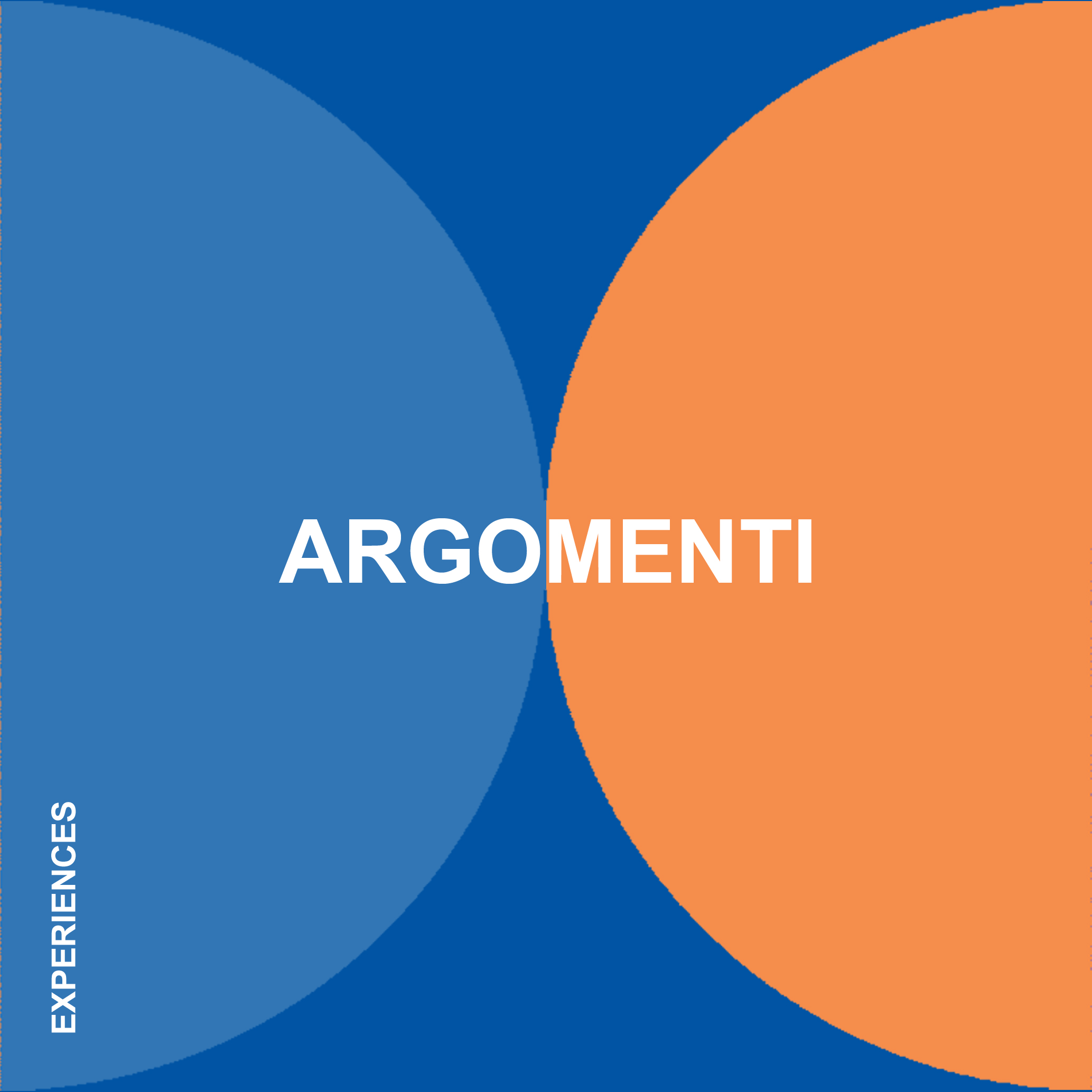I maccheroni di Napoli e Genova
Bisogna dire, con grande semplicità, che la produzione della pasta in gran parte proveniva da Napoli e Genova. Scarsa anche la concorrenza dagli altri pastifici nazionali od esteri, a parte i pastifici della Provenza e dell’Alsazia, dove esisteva una lunga tradizione nella produzione di pasta, in particolare in Alsazia, di quella fresca. Bisogna dire che la regione di lingua tedesca fu tra le prime a passare ad un sistema industriale.
Precedentemente, anche i pastai romani controllavano una buona fetta del mercato, tanto che, vi fu un periodo del Settecento (per la precisione nel 1752) in cui la pasta romana veniva esportata anche verso le stesse Napoli e Genova, e da lì nei paesi europei. Tuttavia, poco dopo, i vermicellari romani persero la loro supremazia, a vantaggio dei napoletani, con pasta più a buon prezzo e più buona. Addirittura, la corporazione della capitale, nel 1764, chiese alle autorità capitoline di vietare l’importazione di pasta da Napoli. Cosa che non accadde.
La parabola discendente registrata dalla pasta romana, si replicò anche per la produzione della Sicilia e della Sardegna. Le due regioni, che avevano fatto la storia della pasta nel medioevo, divennero da esportatrici ad importatrici. Persi i mercati, a causa della concorrenza napoletana, la produzione non si sviluppò adeguatamente e si bloccò a livello locale. Questo, nonostante la pasta fosse di qualità ottima (la pasta sarda è lodata allora da padre Labat).
I pastai pugliesi ressero la concorrenza di Napoli, solo perché, dal 15º secolo, avevano stipulato accordi con la Repubblica veneziana, che commercializzava la loro pasta in Europa, nell’Adriatico e verso Oriente. Questo canale si manterrà vivo fino al XIX secolo, quando la distribuzione della pasta pugliese regredì a livello regionale, come per Sicilia e Sardegna. Tuttavia, se le tre regioni persero gran parte delle esportazioni, l’aumento della domanda interna ne perdurò l’efficacia commerciale. La pasta pugliese è presente anche nel libro L’arte della cucina, di Don Felice Libera, autore del ‘700. Molto lodata la pasta di Brindisi.