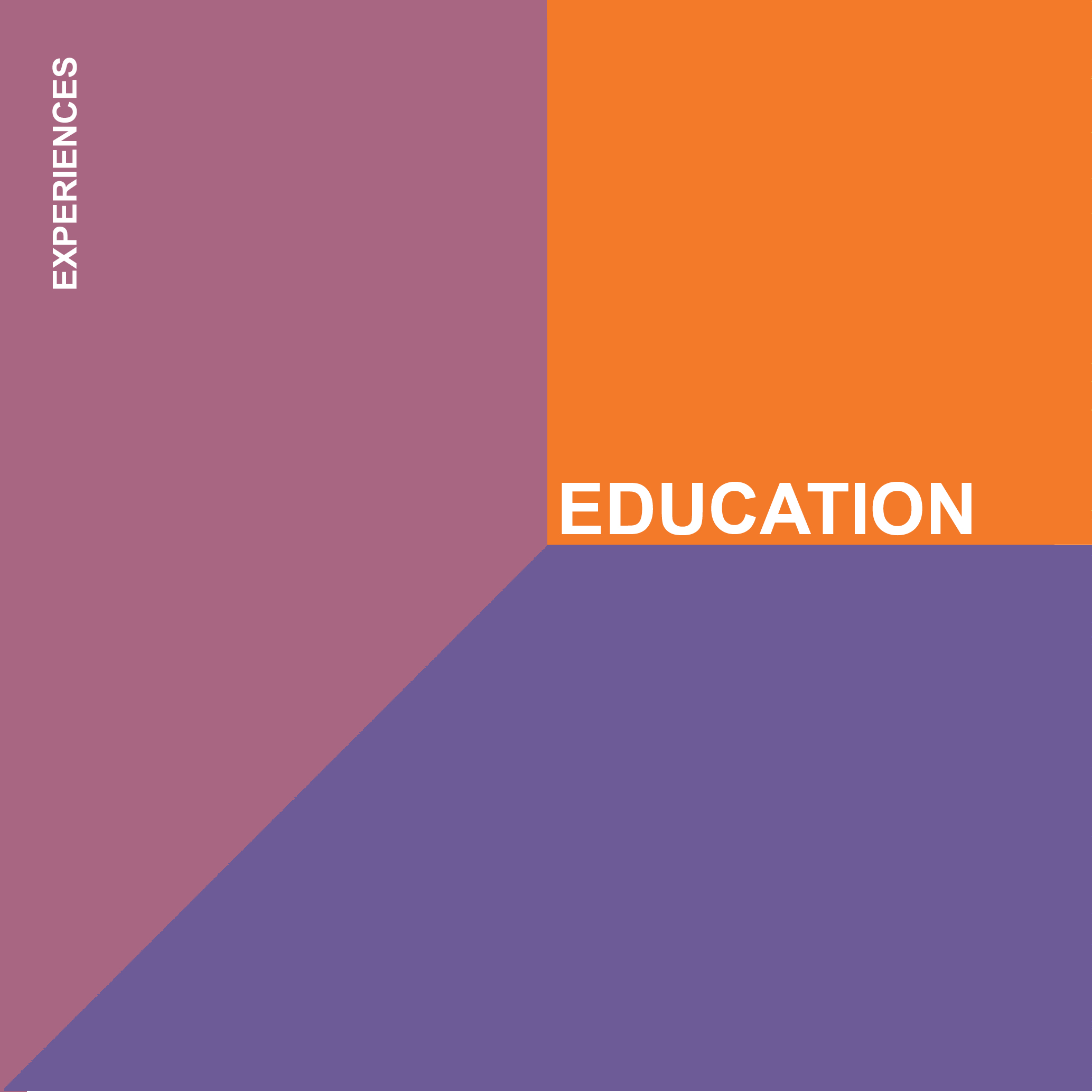In queste pagine presentiamo alcuni degli interventi al Convegno del 7 settembre 2018 presso la Stazione Marittima del porto di Napoli in occasione della presentazione del libro “Per la Macroregione de Mediterraneo occidentale” dei professori Renato D’Amico e Andrea Piraino (Franco Angeli, editore). L’appuntamento è stato organizzato da Paolo Pantani, presidente emerito di Acli Beni Culturali, Stanislao Napolano, presidente dell’Associazione Carlo Filangieri, Giordano Editore e quotidiano online Il Denaro.it.
>>> Intervento di Pietro Spirito*
Nel ridisegno delle connessioni internazionali e nella costruzione della nuova mappa dei poteri tra i principali blocchi del mondo, il convitato di pietra è l’Europa. L’indebolimento della sua capacità politica è cominciato proprio quando, con la nascita della unione monetaria, pareva invece che dovessero essere poste le premesse per un processo federale capace di far affermare sulla scena internazionale un soggetto destinato a pesare sempre più sulle scelte. Per parafrasare il titolo del libro di un politologo americano, Richard N. Haas, “la politica estera comincia a casa”. E quando la casa europea ha cominciato a vacillare nelle sue fondamenta, il peso dell’Europa sugli affari mondiali è diventato via via meno influente.
L’Unione Europea è stata la prima ad intuire che il disegno della integrazione delle reti di collegamento era parte strategica per recuperare competitività sul piano internazionale. A metà degli anni Ottanta del secolo passato Jacques Delors lancio l’iniziativa delle reti transeuropee, con l’ambizione di connettere i Paesi comunitari con infrastrutture maggiormente adeguate ed efficienti.
Ci sono stati due limiti in questo programma comunitario: da un lato i finanziamenti del programma provenivano per larga parte dagli Stati nazionali, ed hanno subito tagli nel periodo della grande crisi, e dall’altro questo disegno di rete non era concepito anche come un modello per connettere l’Europa agli altri principali mercati limitrofi, se escludiamo una proiezione verso Est e verso la Russia.
Anche chi oggi parla di una “Via europea della seta” concepisce un disegno di allargamento e potenziamento delle infrastrutture verso oriente, senza ipotizzare alcuna reale connessione verso la sponda meridionale del Mediterraneo, in qualche modo assecondando un disegno di integrazione solo parziale. E’ mancata, ed ancora manca, una visione comunitaria del disegno delle connessioni che ponga anche il Mediterraneo al centro di un ragionamento di sviluppo.
Questo ragionamento vale anche per la questione delle scelte logistiche che hanno sempre più caratterizzato la definizione delle gerarchie strategiche, sia all’interno della Unione sia sul piano internazionale. Sino ad ora la partita portuale comunitaria è stata caratterizzata da una contrapposizione tra sistema portuale del Nord Europa e sistema portuale mediterraneo, in una concorrenza per attrarre traffici destinati al mercato europeo. Va sottolineato che, come dice Abulafia, “nell’Unione Europea all’inizio del nostro secolo, il centro di gravità dell’Europa si trova ancora al Nord”.
E’ come se si fosse cristallizzato un potere di influenza sancito molto tempo addietro, a partire dalla costruzione della Lega Anseatica, sin dal dodicesimo secolo. L’Europa settentrionale marittima, sin da allora, ebbe la capacità di federare le proprie forze per affermare un progetto egemonico, con una alleanza che coinvolgeva sino a cento città marittime. Il Mediterraneo non è mai riuscito ad esprimere un modello federale che valorizzasse le specificità dei differenti scali, ed è stato caratterizzato invece più da singole temporanee egemonie che da modelli cooperativi.
Va poi sottolineato che – successivamente alla conclusione della seconda guerra mondiale – il Mediterraneo è entrato nella sfera di influenza statunitense, come avamposto della lunga stagione della guerra fredda tra i due grandi blocchi contrapposti delle economie di mercato e delle economie pianificate. In una certa misura la Comunità Economica Europea nasce anche per l’esigenza di non delegare a Stati Uniti e Unione Sovietica la sicurezza europea, non prestare il fianco alle offerte disgregatrici di Mosca, rafforzare la coesione dell’Europa sul piano politico, economico e sociale. Non si riesce a perfezionare anche la Comunità Europea della Difesa, in particolare per la rigida posizione francese, ma nasce una forte integrazione dei mercati che consente di consolidare la ripresa economica dei Paesi europei.
Il Mediterraneo come spazio geografico e politico è parte integrante del processo di integrazione europea sin dal suo avvio. Nella conferenza di Messina, che ha preparato i Trattati di Roma del 1957, tale aspetto politico è al centro della discussione tra i Paesi che daranno vita alla CEE. Tuttavia, politiche mediterranee hanno poi stentato ad emergere nella agenda comunitaria. La rilevante diversità degli interessi e nelle relazioni degli Stati membri nei confronti della sponda sud fu la causa principale del sostanziale fallimento nella creazione di una politica comune.
La costruzione europea è stata sin dall’inizio un edificio sofisticato di sperimentazione istituzionale, un contenitore che ha sapientemente mescolato più ingredienti politici e sociali: Lo spirito di complessità è lo spirito d’Europa. Questa complessità si è nel tempo inaridita di fronte alla difficoltà di arricchire i contenuti di cooperazione, che si sono focalizzati essenzialmente sulla costruzione di un mercato unico governato da una moneta unica. La latitanza delle altre politiche ha reso molto più difficile il bilanciamento con i fattori fondanti di una politica federale, che sono essenzialmente la politica estera, l’armonizzazione delle politiche economiche e fiscali, le politiche di indirizzo strategico su una visione condivisa del futuro.
C’è stata una breve fase, nella storia del processo di integrazione comunitaria, nella quale si è tentato di spostare l’asse dell’attenzione sul baricentro mediterraneo, vale a dire quando, da metà degli anni settanta del secolo passato, si è avviata, ed è poi giunta a conclusione positiva, la trattativa per accogliere Spagna e Portogallo nel disegno di integrazione europea: Si riteneva che la cooptazione di Spagna e Portogallo nella CEE avrebbe riequilibrato il baricentro della Comunità verso il Sud Europa.
Quella illusione è durata sino alla metà degli anni Ottanta, quando il tentativo di riforma istituzionale verso una maggiore integrazione politica, con l’Atto Unico, si è poi infranto con la diluizione delle ambiziose riforme proposte. Subito dopo, a distanza di qualche anno, il crollo dell’Unione Sovietica e delle economie pianificate ha cambiato completamente le carte in tavola.
L’unificazione tedesca prima, e l’espansione comunitaria verso Est poi, è stata la cifra dominante che, da allora in poi, ha caratterizzato prima l’asse, e poi la crisi, della integrazione comunitaria. La stessa costruzione della moneta unica è stata più un modo per imbrigliare la Germania unificata in un disegno di cooperazione obbligata che non una azione di rilancio per rafforzare la costruzione di una Europa federale.
Poi, per quei paradossi che spesso la storia presenta, il disegno di una moneta unica che doveva originariamente servire ad arginare il potenziale eccessivo potere di una Germania unificata, è piuttosto servito ad amplificarne la portata, non per effetto di un destino cinico e baro, ma per le debolezze delle soluzioni istituzionali adottate.
Nel tempo più recente, a partire dalla caduta del muro di Berlino e dallo sgretolamento delle economie pianificate che gravitavano attorno all’orbita sovietica, l’attenzione dell’Europa si è spostata verso Oriente, per allargare la propria sfera di influenza politica e l’ambito dello spazio economico comunitario. Inevitabilmente le risorse finanziarie e le energie politiche si sono direzionate verso questo obiettivo primario, ed ancora una volta è sfumata l’attenzione verso le regioni dell’area mediterranea.
Insomma, il Mediterraneo sembra costituire la promessa costantemente mancata delle politiche comunitarie: sembra sempre sul punto di entrare più volte nelle agende degli impegni della Unione Europea, per poi invece essere superato da altre questioni che incalzano tra le priorità che vanno effettivamente percorse.
Quella del partenariato euromediterraneo è in realtà una storia di un bambino morto nella culla. Da una parte infatti il riacutizzarsi della tensione nel conflitto arabo-israeliano ma anche il tramonto del clima di trionfo neo-liberale successivo alla fine della Guerra fredda, finiscono per far venire meno le condizioni ambientali affinchè l’ambizioso progetto possa realizzarsi.
Dalla prima conferenza euro-mediterranea tenutasi a Barcellona alla fine di novembre del 1995, si sono susseguiti tanti altri vertici e tante altre conferenze su questo tema, senza tuttavia generare quel salto di qualità nel modello di cooperazione capace di determinare una centralità effettiva della politica euro-mediterranea.
Si può registrare una parabola discendente della politica mediterranea della UE, che è passata dall’ambizioso approccio multilaterale proposto dal partenariato euro-mediterraneo del 1995, che nutriva la visione forse utopistica di modernizzare la regione, al ritorno alla pratica degli accordi bilaterali con la politica europea del vicinato e l’Unione per il Mediterraneo. Insomma, mentre si provava a mettere in campo una seria iniziativa euromediterranea, mancava poi il carburante politico per metterla in pratica, e al più si mantenevano in vita simulacri di cooperazione che ne indebolivano ulteriormente la portata.
Romano Prodi, attento osservatore della geopolitica internazionale, doversi anni fa ha sottolineato che “il Mediterraneo è ancora periferia del sistema economico mondiale e non è un sistema anche perché le relazioni marittime o aeree tra l’Italia e l’Africa del Nord, ad esempio, sono ridicole: pochissimi sono i collegamenti, quelli aerei sono recentissimi e sporadici, e manca persino una tradizione. Si è proprio interrotto un fatto storico, ma che dobbiamo e possiamo ricomporre”.
Mentre resta questa gravitazione settentrionale ed orientale delle politiche comunitarie, l’asse dei cambiamenti si sta spostando verso l’orizzonte mediterraneo, ma sembra che la Comunità non se ne sia accorta, salvo che per l’emergenza dell’immigrazione. Dopo la crisi finanziaria del 2007, i cui effetti sono ancora visibili, sono stati proprio i Paesi dell’Europa mediterranea ad entrare in crisi, e sono mancate risposte adeguate per baricentrare in modo più equilibrato le scelte di politica economica e di assetto geostrategico.
L’indirizzo delle politiche fiscali è stato guidato dal solo principio delle politiche monetarie, consistente in un approccio restrittivo alla finanza pubblica, proprio quando sarebbe stato necessario rispondere alla crisi con scelte anticicliche. Una Unione Europea a trazione tedesca ha scelto di controllare rigorosamente solo i parametri del deficit e del debito pubblico, mentre sono stati del tutto trascurati i parametri dell’avanzo eccessivo di surplus nella bilancia commerciale, che pure avrebbero dovuto dar luogo a provvedimenti correttivi secondo le regole di Maastricht.
Si sono adottati due pesi e due misure, con l’effetto di segnare ancor di più l’indirizzo recessivo delle politiche economiche, con una conseguente crisi ancor più dura dei debiti sovrani e con un indirizzo recessivo che ha assecondato il ciclo della crisi, piuttosto che contrastarlo.
Sono così emerse spinte centrifughe dall’euro, che hanno assecondato e sostenuto l’ondata populistica emergente per effetto di una crescita delle diseguaglianze e per un forte incremento della disoccupazione, soprattutto giovanile. L’Europa ha perso così una occasione di rinsaldare una dimensione federale che sarebbe stata assolutamente necessaria, in una fase nella quale il mondo ha avviato un ridisegno degli scenari competitivi tra grandi blocchi economici.
Proprio nell’area mediterranea sarebbe stata necessaria – ed ancora lo è – una iniziativa politica di rilancio della presenza europea. Ed invece si è andati in ordine sparso. All’indirizzo recessivo delle politiche economiche su scala comunitaria si è affiancata l’assenza di una politica estera comune per affrontare la stagione delle primavere arabe ed i grandi riassetti di potere che si sono accompagnati a questo fenomeno.
Nel caso della crisi libica si è raggiunto l’apice di questa contraddizione. Francia e Gran Bretagna si sono contrapposte all’Italia per conquistare spazi di iniziativa economica. Poi, quando è stato ribaltato il regime di Gheddafi, l’Europa ha continuato a balbettare senza essere in grado di esprimere una propria iniziativa per rivitalizzare un Paese strategico, per la sua potenziale rilevanza economica e per il suo ruolo sociale nella crisi della immigrazione. Ed ancora successivamente, in una situazione di balcanizzazione tribale dell’architettura istituzionale, libica, l’Europa non è riuscita a darsi una linea comune per mettere ordine in un Paese strategico per tante ragioni nel gioco degli equilibri mediterranei.
Non si è insomma colta la trasformazione in corso negli assi geostrategici di cambiamento. Per molto tempo, effettivamente, il Mediterraneo è stato marginale nella formazione degli equilibri economici e politici internazionali. Sino alla seconda metà del XIX secolo il Mediterraneo è ancora lo scenario dei grandi viaggiatori, del Gran Tour, di una visione superficiale, estetica di una élite europea in cerca di evasione, in una parola: l’esoterismo di tutta una generazione di artisti e di scrittori.
La stessa fondazione originaria del mercato comune europeo non riesce a generare quell’equilibrio necessario tra orizzonte nordico ed orizzonte mediterraneo dell’Europa: l’unificazione commerciale viene generata dalla necessità di garantire un equilibrio di pace franco-tedesco, dopo due guerre mondiali che erano maturate nel cuore dell’Europa. Il Mediterraneo era stato oggetto nella prima metà del Ventesimo secolo di un processo di colonizzazione subordinato alle visioni egemoniche occidentali.
ll processo di allargamento della Unione Europea ha poi visto protagonisti sostanzialmente la Gran Bretagna prima, ed i Paesi dell’Est Europa poi. L’orizzonte mediterraneo si è allontanato ulteriormente, ed anzi è stato più occasione di confronto e conflitto tra Paesi comunitari che non occasione di politica esterna comune: basti tra tutti l’esempio della crisi di Suez del 1957.
Nella portualità e nella politica marittima, i fronti del Nord e del Sud Europea si sono sviluppati in maniera separata ed antagonistica, più vivendosi come sistemi in competizione che parte di un disegno logistico integrato in uno spazio economico comune.
Ma, mentre il sistema portuale del Nord Europa non conosce concorrenza extra-comunitaria per servire i mercati comunitari, i porti europei della sponda sud subiscono la competizione che viene dalla sponda nord-africana. Stenta ancora ad affermarsi una strategia mediterranea dell’Unione Europea.
Tra gli anni sessanta e la metà degli anni settanta del secolo passato, la strategia europea verso il Mediterraneo è risultata frastagliata e non unitaria, guidata soprattutto da accordi bilaterali poco coerenti e coordinati. Successivamente, nel 1975, è stata definita una “politica globale per il Mediterraneo”, basata su tre tipologie di cooperazione: commerciale, finanziaria ed economica, sociale.
Da quel punto in avanti, non sono stati fatti grandi progressi sotto il profilo della integrazione, che si è sostanzialmente limitata a ribadire i principi definiti precedentemente, con la “rinnovata politica mediterranea”, il “partenariato euro-mediterraneo”, o l’”Unione per il Mediterraneo”.
Quest’ultima iniziativa, partita nel 2008 sotto il forte impulso del Presidente francese Nicolas Sarkozy, è immediatamente ripiegata su se stessa, senza segnare particolari discontinuità rispetto ad una linea originaria che non corrisponde più ai bisogni di una più stretta integrazione dettati dalla agenda internazionale e dalle crisi che si sono succedute nell’area mediterranea.
La Commissione Europea preferisce affidarsi a strumenti più affinati, come i partenariati strategici, le azioni comprese sotto l’ombrello della politica europea di vicinato e gli accordi di associazione. Tuttavia, si è avvertita fortemente la mancanza di un approccio strategico alla questione mediterranea, che ha lasciato spazio per l’iniziativa di altri, a cominciare dalla Cina.
Solo di recente si stanno cominciando a disegnare percorsi istituzionali di cooperazione e di intervento che cercano di porre rimedio ad un vuoto intanto riempito dal disegno egemonico cinese. Qualche segnale si comincia finalmente a muovere. Il 30 novembre del 2017, a Napoli, è stata sottoscritta una dichiarazione per la partnership con la Commissione Europea e l’Unione del Mediterraneo sottoscritta dai ministri degli affari marittimi dei dieci Stati che partecipano alla iniziativa per lo sviluppo sostenibile della blue economy nel Mediterraneo Occidentale. Si tratta di Algeria, Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marocco, Portogallo, Spagna, Tunisia.
La strategia macroregionale costituisce una modalità di cooperazione territoriale elaborata nell’ambito del potenziamento delle politiche regionali dell’Unione Europea. Sinora sono state istituite quattro macroregioni a partire dal 2009 (Baltica, Danubiana, Adriatico-Jonica, Alpina), mentre si discute sulla possibile di istituirne una quinta, quella del Mediterraneo Occidentale. Tuttavia, non è chiaro il livello di istituzionalizzazione e di autonomia funzionale che l’Europa intende assegnare a tale forma di cooperazione.
Esiste oggi una triplice restrizioni ai poteri delle macroregioni: non si possono approvare nuove normative, non si possono creare nuove istituzioni, non si possono ottenere risorse finanziarie addizionali. Insomma, gli spazi di manovra sono molto ristretti, e la forma con la quale le macroregioni possono dare il proprio contribuito alle politiche regionali consiste più nella articolazione di un maggiore coordinamento delle linee politiche già assunte, che non nella formazione di nuovi indirizzi. Le macroregioni non sono dunque veri e propri enti territoriali ma settori di cooperazione funzionale, localizzati in aree territoriali omogenee.
L’”Iniziativa per lo sviluppo sostenibile della blue economy nel Mediterraneo occidentale”, approvata con comunicazione del 19 aprile del 2017 dalla Commissione Europea, si propone le seguenti finalità:
- incrementare la sicurezza marittima;
- promuovere la crescita sostenibile della blue economy e lo sviluppo dell’occupazione;
- preservare l’ecosistema e la biodiversità della regione del Mediterraneo occidentale.
A questi obiettivi occorre cominciare a dare gambe concrete: da un lato servono finanziamenti infrastrutturali per il potenziamento delle reti e delle tecnologie e dall’altro occorre incrementare le connessioni marittime.
Sinora i flussi hanno riguardato prevalentemente il tragico fenomeno delle migrazioni dall’Africa all’Europa, e le contaminazioni sono più collegate alle terribili vicende del terrorismo islamico che mina la sicurezza. Il Mediterraneo adesso è una parola che fa paura, che ci divide e che ci indigna. Non importa più la sua storia millenaria: importano i disperati che vi affogano ogni giorno, importa la crisi economica che da anni lo attraversa come una tempesta, importano i pazzi e gli assassini che ne insanguinano le coste.
Se prevalgono approcci legati alla paura ed alla chiusura nei confronti di fenomeni sociali che devono essere invece governati e gestiti, il Mediterraneo smarrisce il suo orizzonte e perde la sua opportunità. Il protezionismo economico, che si staglia all’orizzonte, rischia di incrociarsi con il protezionismo sociale.
A circa sei anni di distanza dalle cosiddette primavere arabe, il Mediterraneo continua ad essere al centro dell’attenzione internazionale per la forte instabilità che lo caratterizza. E’ quasi un cane che si morde la coda. Il mancato governo delle istanze di cambiamento espresse dai popoli sulla sponda sud del Mediterraneo induce ad altri focolai di incertezza sociale.
Interrotti da meccanismi che riproducono regimi repressivi già precedentemente incapaci di dare risposte ai bisogni sociali, le società arabe e nord-africane si sono trovate anche a doversi confrontare con percorsi di trasposizione forzata delle democrazie occidentali, che si sono rivelati esperimenti anche peggiori rispetto alle autocrazie tradizionali locali. Si è insomma innescata una trappola istituzionale particolarmente intricata da dipanare.
L’assenza di una azione politica per governare i processi di trasformazione che sono ormai ineludibili getta benzina sul fuoco delle tensioni, impedendo uno sviluppo economico che sarebbe l’arma necessaria per traghettare le tensioni verso la sostenibilità sociale ed economica.
Mentre il terrorismo va combattuto con le armi della cooperazione internazionale, per quanto riguarda le dinamiche demografiche siamo in presenza di fenomeni irreversibili. L’Africa è ancora un continente fuori controllo: se nel 2015, con 1,2 miliardi di persone, essa rappresentava il 16% della popolazione mondiale, nel 2050 avrà 2,5 miliardi di uomini e donne, quasi il 26% della popolazione mondiale, e nel 2100 potrebbe raggiungere 4,5 miliardi, il 40% del totale.
Non leggere questi fenomeni di natura demografica destinati a modificare completamente la natura delle relazioni sociali è stato un errore strategico dell’Europa. La morsa dei processi di immigrazione si legge con queste due chiavi di lettura incrociate: da un lato l’inarrestabilità a breve del processo demografico e dall’altro un insieme di conflitti ad alta o a bassa tensione che interessano un vasto scacchiere della intera area mediterranea. Abbiamo così deciso di giocare esclusivamente di rimessa, alimentando le paure dei popoli senza guidare un processo di trasformazione.
Eppure, come spesso accade quando si affacciano alla storia fenomeni di natura fortemente discontinua, essi possono essere guardati secondo prospettive di rischio o di opportunità: saper trasformare in opportunità il rischio potenziale diventa il fattore di vantaggio strategico determinante nella competizione internazionale. Le grandi trasformazioni storiche avvengono perché il solito andazzo non funziona più. I potenti sono usi restare aggrappati alle strategie secolari persino quando la realtà cambia radicalmente.
Si legge nella poesia di Costantino Kavafis (Aspettando i barbari): “E adesso, senza barbari, cosa sarà di noi? Era una soluzione, quella gente”. In fondo, gli Stati Uniti d’America hanno costruito la propria potenza e la propria crescita economica proprio nella capacità di accoglienza della immigrazione.
Sarebbe stata necessaria una poderosa organizzazione sociale di accoglienza, selettiva e rigorosa al tempo stesso, su base comunitaria con principi condivisi. Si è invece andati in ordine sparso, giocando a scaricabarile. L’esito è sotto gli occhi di tutti. L’Europa ha scelto di giocare di rimessa questa partita, alimentando una inconsapevole paura dell’altro che sta orientando i consensi verso opzioni populistiche di chiusura. Quel rischio che si chiamava tanti anni fa “Fortezza Europa” sta diventando realtà, ribaltandone completamente il senso originario.
In fondo è difficile trattare l’argomento mare per un’Europa che si è formata su terra. Le fondamenta stesse della Unione Europea non hanno mai posto la centralità della integrazione marittima, che è rimasta tra le politiche affidate sostanzialmente agli Stati membri, senza una reale volontà di approccio comune.
Con gli scenari internazionali che si stanno delineando, questa assenza di politiche comunitarie marittime costituisce uno dei punti di debolezza strategica di una Europa che si trova oggi in mezzo al guado, e che non riesce ad affrontare la sua crisi di identità, tra volontà di costituire, ormai minoritarie, gli Stati Uniti di Europa e tentazioni, attualmente crescenti, di ridurre i gradi di cooperazione che sono stati consolidati in questi decenni.
Dall’Africa si genereranno flussi migratori di grandissime proporzioni, soprattutto verso l’Europa, a causa sia di fattori climatici, sia ancora di sommovimenti politici. Poco si è fatto per integrare il traffico merci e passeggeri tra le due sponde del Mediterraneo in una logica commerciale. L’Africa del Nord è una frontiera dello sviluppo che costituisce l’opportunità principale non solo per l’Europa del Mezzogiorno ma anche per l’intera Comunità.
Invece di sprigionare una straordinaria iniziativa politica, all’altezza delle sfide che si presentano, è accaduto esattamente l’opposto. Non costituisce reato affermare che le istituzioni comunitarie e unioniste europee, trascinate dal peso economico e diplomatico del motore franco-tedesco e dalle continue spinte entropiche britanniche, abbiano trascurato i vettori di sviluppo, le vulnerabilità e le opportunità insite nella regione mediterranea.
Anche i tempi della navigazione indicano l’urgenza e la necessità di occuparsi innanzitutto del Mediterraneo. La rotta tra Shangai e Napoli impiega 21 giorni di navigazione, mentre quella tra Tunisi e Napoli solo 15 ore. Il tempo resta una variabile strategica della competizione. E la geometria variabile della globalizzazione sposterà la frontiera del futuro verso l’Africa. Se saremo in grado di comprendere ed orientare questa sfida, utilizzando il Mediterraneo come asse strategico, potremo cambiare il destino dell’Europa meridionale, e del nostro Mezzogiorno.
Prima ancora della opportunità africana nel suo insieme, che comunque richiede una visione strategica di lungo periodo, il mondo sarà chiamato a rispondere alla sfida della ricostruzione derivante dai conflitti bellici che si sono determinati negli ultimi decenni e da quelli che ancora sono in corso in Siria: L’Africa sarà nel lunghissimo periodo ciò che nel breve sarà la ricostruzione della Libia e della Mesopotamia.
Nell’area che più immediatamente ci circonda sono destinati a svolgersi eventi che cambieranno la configurazione di quello che siamo e di quello che saremo. Se non ce ne occuperemo noi, saranno altri a farlo al nostro posto, con una conseguente subordinazione politica dell’Europa, dell’Italia e del Mezzogiorno. Il presente e, con ogni probabilità, il futuro della UE risiede nella capacità di dar vita ad un nuovo ordine della centralità, restituendo al Mediterraneo il ruolo che la geografia gli ha sempre assegnato.
Non si vedono ancora i segni di questa evoluzione opportuna, ed anzi continuano ad essere presenti i sentimenti di una rimozione collettiva europea, che tende inevitabilmente a valorizzare i rischi di una presenza mediterranea, non comprendendo anche i vantaggi potenziali che si possono cogliere.
Va richiamata e percorsa una caratteristica fondamentale dell’Europa, vale a dire la sua costante incompletezza, che può diventare – da potenziale handicap – leva attorno alla quale costruire una riconfigurazione che superi la crisi attuale: l’Europa è una entità storica in continua metamorfosi che affronta in forme nuove una tensione ricorrente, e mai compiuta, tra unità e molteplicità. E la tensione tra unità e molteplicità, fra identità e diversità, è diventata, attraverso l’Europa, l’esperienza cruciale della condizione umana nel tempo della globalizzazione, nel tempo della complessità.
In particolare l’area MENA (Middle East and North Africa), che racchiude Paesi con i quali è stato storicamente forte il rapporto politico e l’interscambio con l’Europa, richiede la formulazione di una strategia e di una interlocuzione che stenta ad emergere, nonostante che vi sia consapevolezza sulla necessità di operare in tale direzione.
Mentre l’Europa tarda a maturare consapevolezza, almeno il nostro Paese deve necessariamente fare i conti con se stesso, con la sua collocazione geografica, con la necessità di fare leva sul Mezzogiorno per ricominciare a crescere. Il Mediterraneo già oggi gioca un ruolo rilevante nella struttura degli scambi economici per il nostro territorio.
L’area manifesta, pur tra crisi politiche e conflitti sociali, un potenziale di crescita che merita attenzione. I Paesi del Middle East e del Nord Africa sono cresciuti, nel periodo 1995-2016 ad una media del 4,4%, con un tasso decisamente più alto della Unione Europa a 28 Stati (1,9%). La Turchia ha registrato il valore più alto (4,9% anno). La popolazione dell’area arriverà a 730 milioni di abitanti nel 2050, con un tasso di crescita che è meno intenso del PIL.
Le regioni meridionali del nostro Paese non stanno cogliendo le opportunità che possono derivare dalla attivazione di una forte cooperazione commerciale con le regioni limitrofe ed a più alta crescita del Mediterraneo. Sta accadendo anzi l’opposto.
L’interscambio commerciale tra il Mezzogiorno ed il totale dei Paesi dell’area MENA è stato pari a 13,6 miliardi di euro nel 2016, valore molto inferiore a quello registrato dal Nord-Ovest (25,3 miliardi di euro). Nel 2001 gli scambi commerciali tra il Mezzogiorno e l’area MENA ammontavano a 14,6 miliardi. La crisi del 2009 ha determinato un brusco calo nell’interscambio.
Per il Mezzogiorno gli scambi con l’area MENA costituiscono il 15,7% del commercio estero globale: questo dato ha raggiunto il suo picco nel 2005 (26,7%), mentre dal 2012 al 2016 è risultato costantemente in calo, con una tendenza che dovrebbe invertirsi nel corso dei prossimi anni.
Articolare un programma di sviluppo industriale e commerciale del Mezzogiorno è possibile se ci impegniamo a costruire e ad intensificare delle relazioni commerciali e marittimi tra le regioni meridionali del nostro Paese ed il sistema mediterraneo, con il doppio scopo di consolidare da un lato la ripresa dell’industria manifatturiera nel Sud Italia e dall’altro di dare ulteriori slanci di competitività all’economia marittima del Mezzogiorno.
La produttività dei fattori è generata dalla migliore utilizzazione di lavoro e capitale. Troppo spesso ci si concentra sul rendimento del lavoro, mentre si è distratti sulla ottimizzazione del capitale. La rotazione delle navi sul corto raggio nell’arco mediterraneo può generare una intensità di connessioni senza paragoni rispetto alle rotte lunghe della globalizzazione tra Asia ed Europa.
Cinta poi quell’insieme di fattori che non sono né capitale né lavoro, e che gli economisti racchiudono sotto la denominazione di residuo. Nella organizzazione produttiva dei nostri tempi il residuo pesa in modo crescente: mette assieme le innovazioni tecnologiche, l’efficienza dei servizi, la densità delle connessioni, la qualità delle infrastrutture, la dotazione di capitale umano con adeguate capacità.
E’ nella combinazione consapevole ed efficiente di lavoro, capitale e residuo che – ancora una volta – si potrà interpretare e guidare in modo efficace la produttività totale dei fattori, vale a dire quell’indicatore sintetico capace di esprimere la combinazione degli elementi differenti della prodizione che danno vita alla competitività dei sistemi economici.
Su queste basi può esser rilanciata una politica industria e logistica solida, capace di attrarre investimenti e crescita. In questo modo lo sviluppo si avvicina a noi, ed il miglior sfruttamento del capitale lo può rendere ancora più intenso, attraverso una maglia densa di connessioni che valorizzi gli scambi commerciali mediterranei. Nell’epoca della nuova globalizzazione, alle reti lunghe transoceaniche si possono aggiungere anche le reti corte di prossimità, che possono consentire di rimettere in marcia territori ancora non contaminati dalla logica di una crescita economica basata su industrie ad alto contenuto tecnologico. Serviranno sempre meno braccia e sempre più cervello per produrre valore.
Insomma, lo sviluppo tende a fiorire laddove si generano quegli “ecosistemi innovativi” spesso trasversali rispetto ai tradizionali settori merceologici. La grammatica industriale alla quale eravamo abituati tende a contaminarsi con una nuova lingua basata su una scrittura più complessa, nella quale i perimetri sono continuamente rimessi in discussione secondo il paradigma della creazione e della costellazione del valore.
Pietro Spirito, Presidente dell’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale. “Il deficit di politiche europee per il Mediterraneo: origini e conseguenze”.