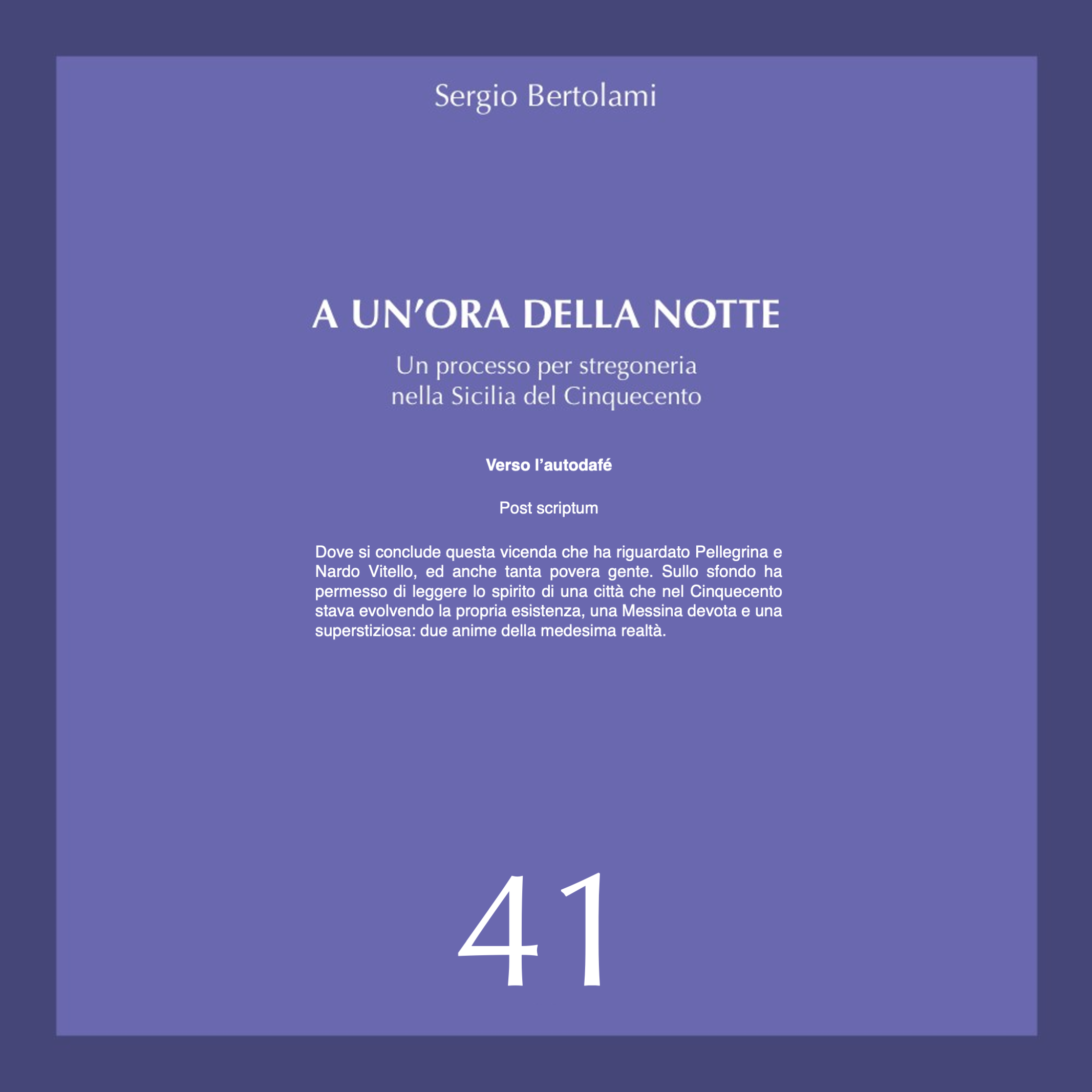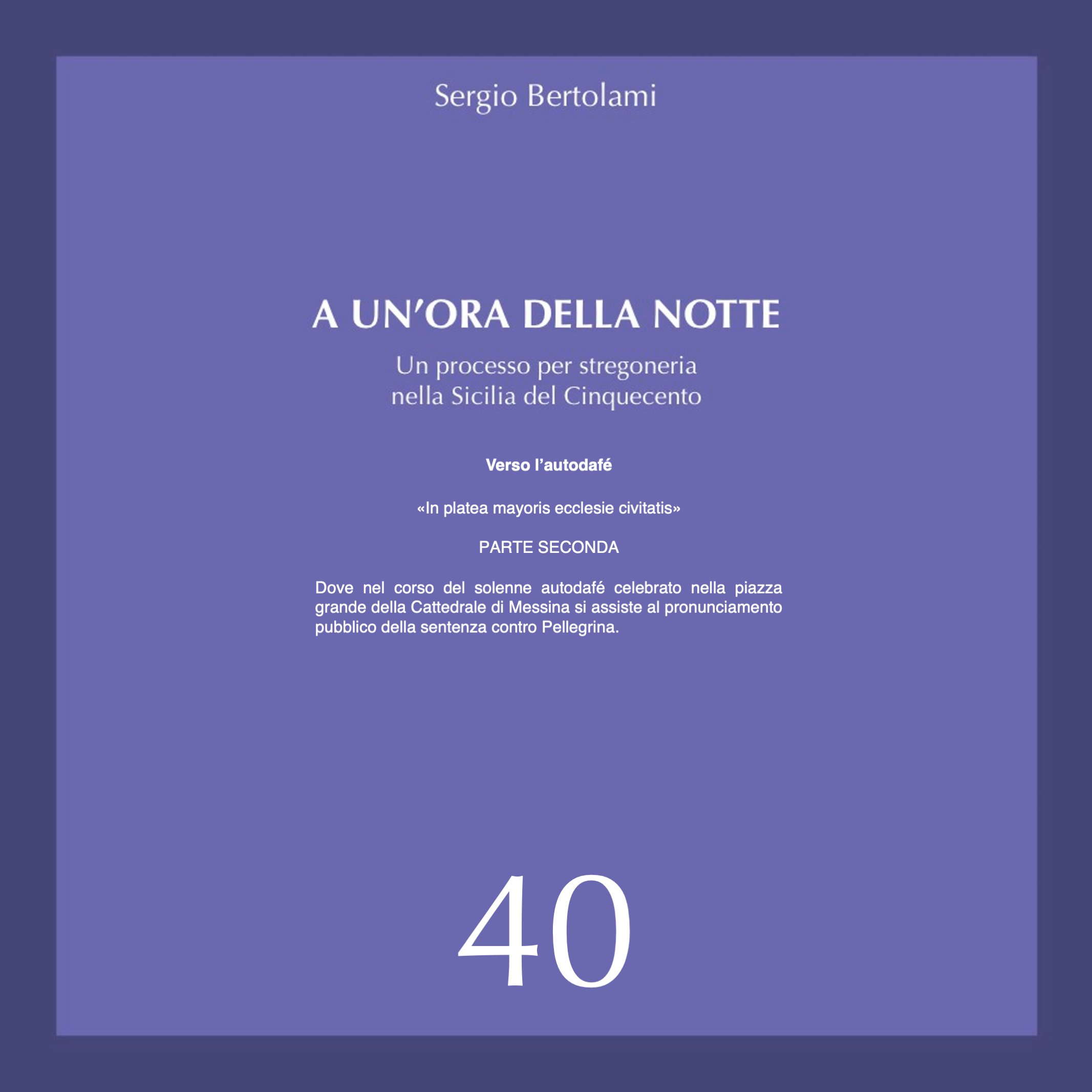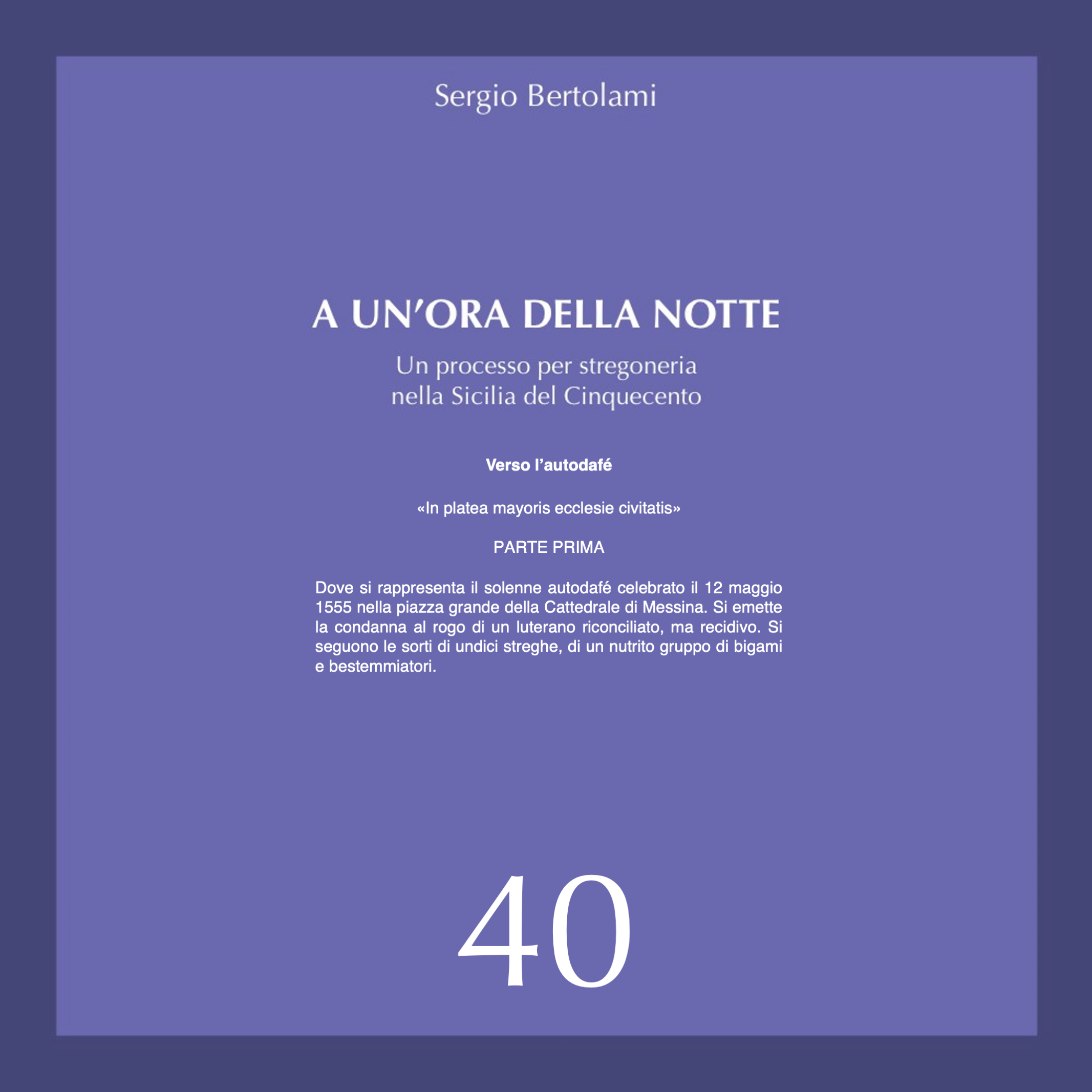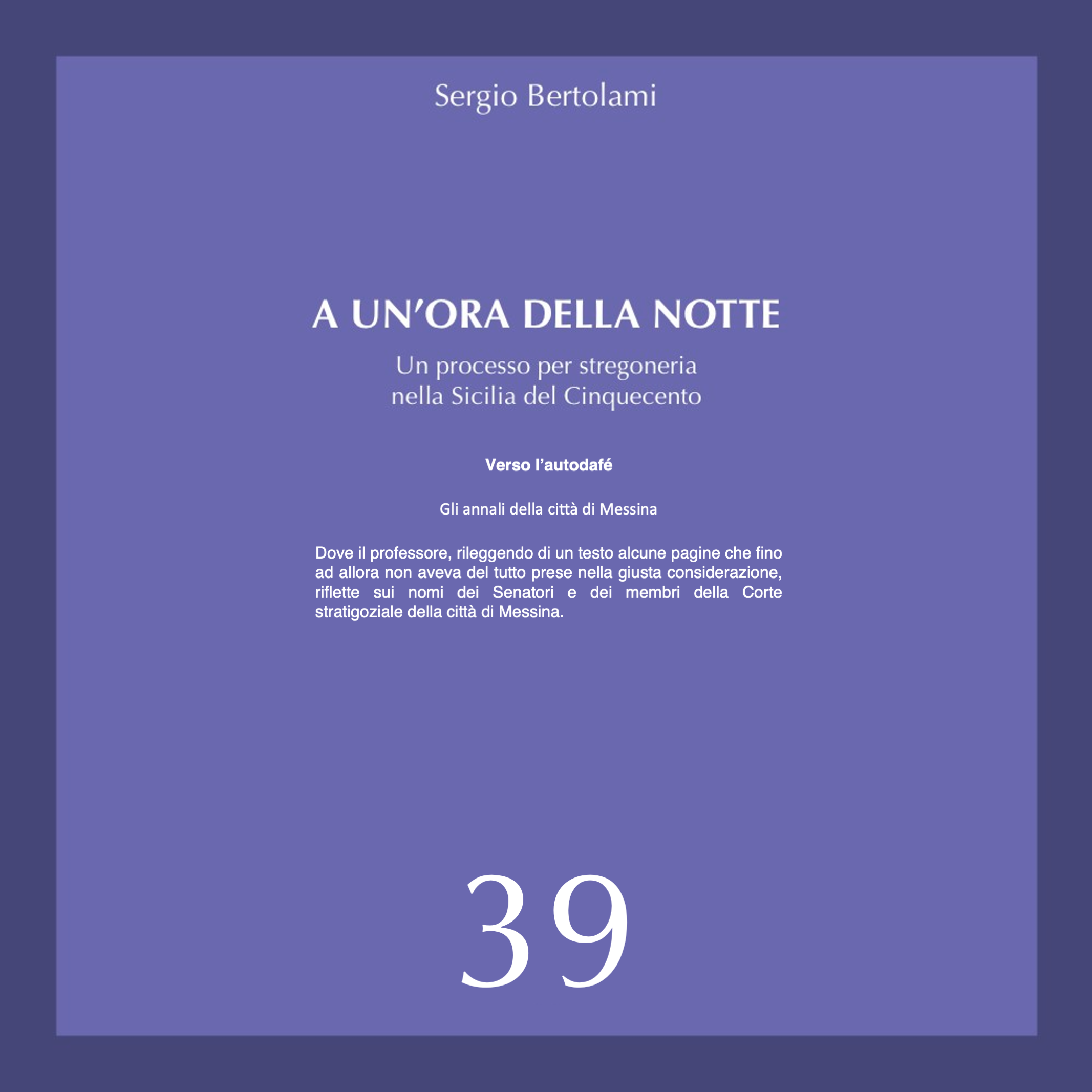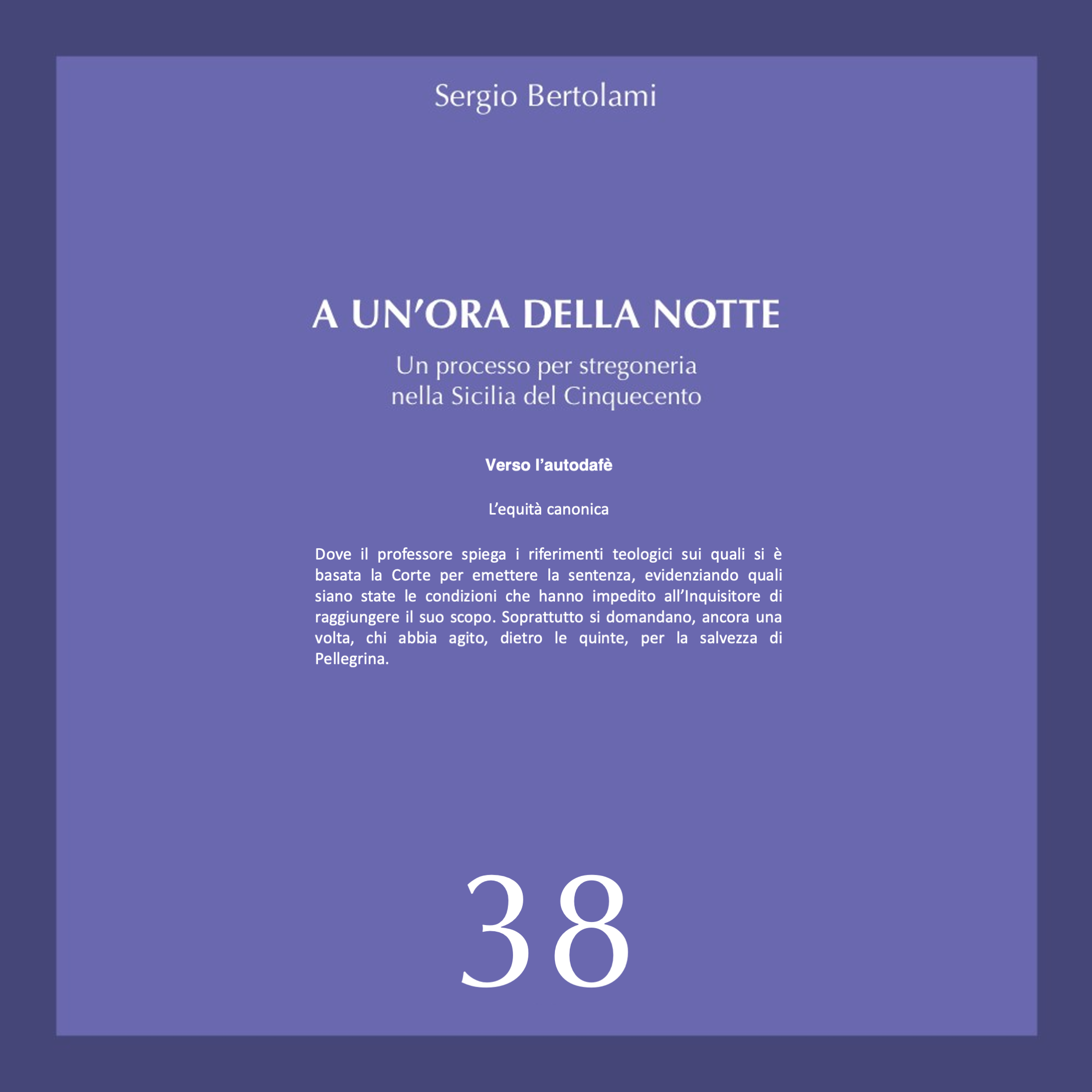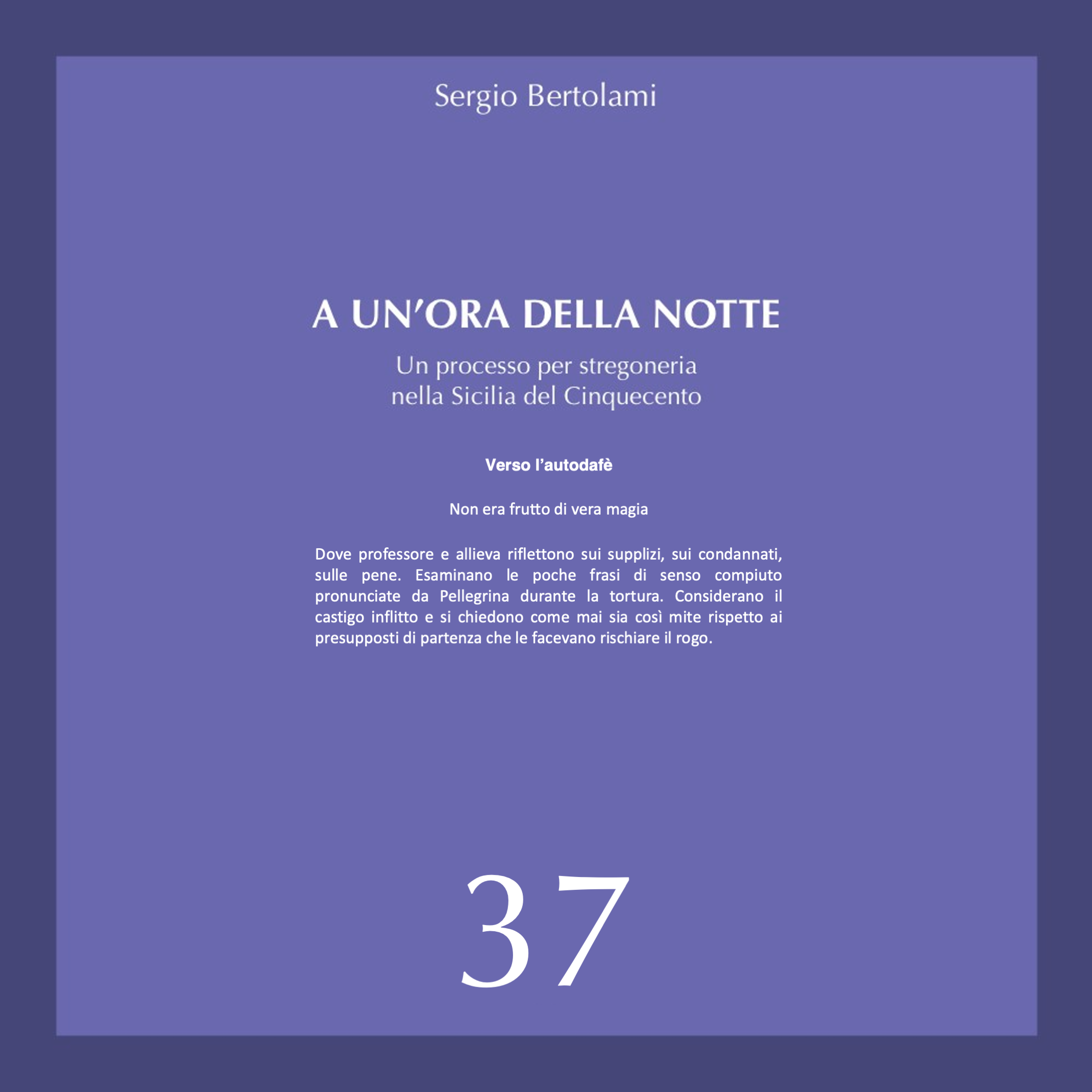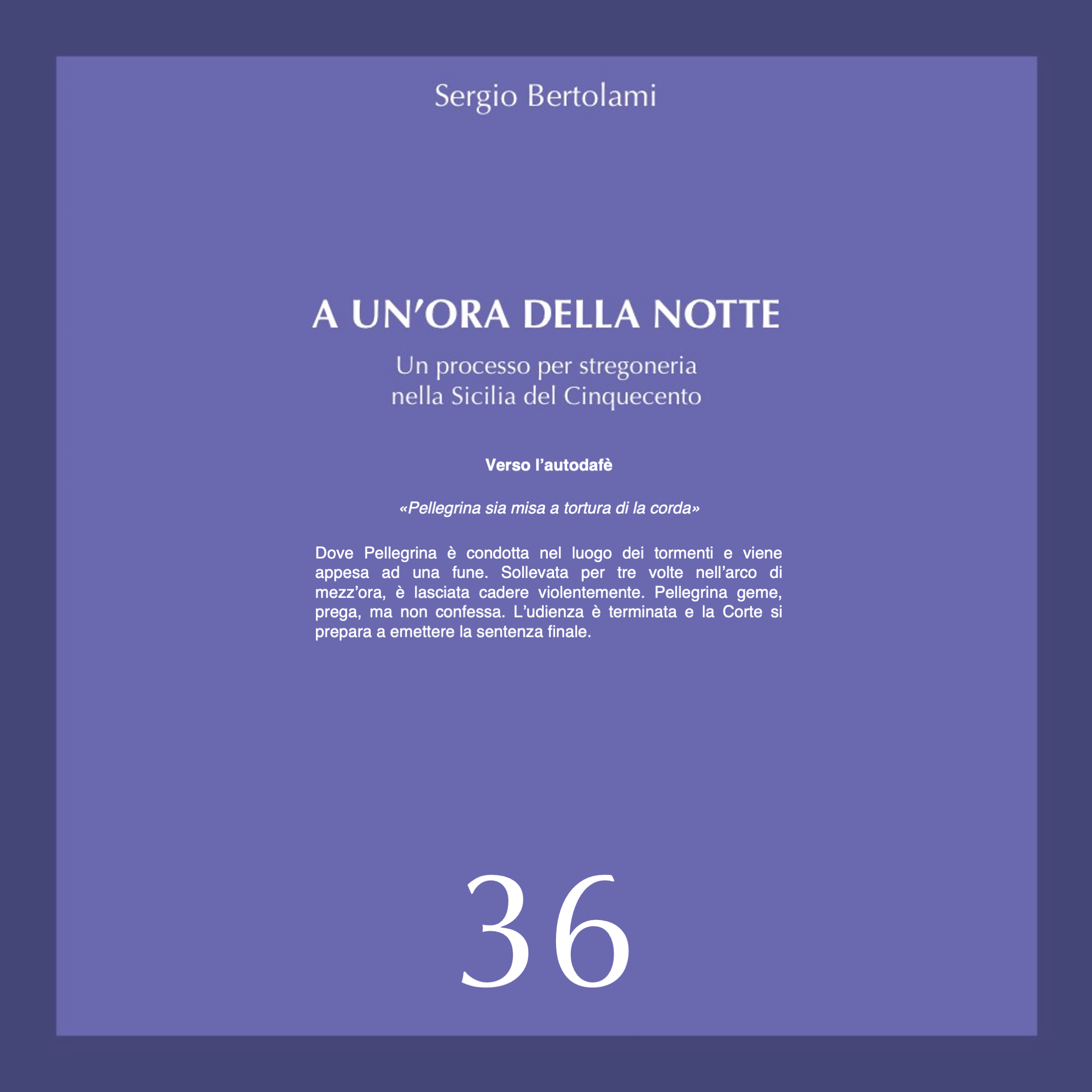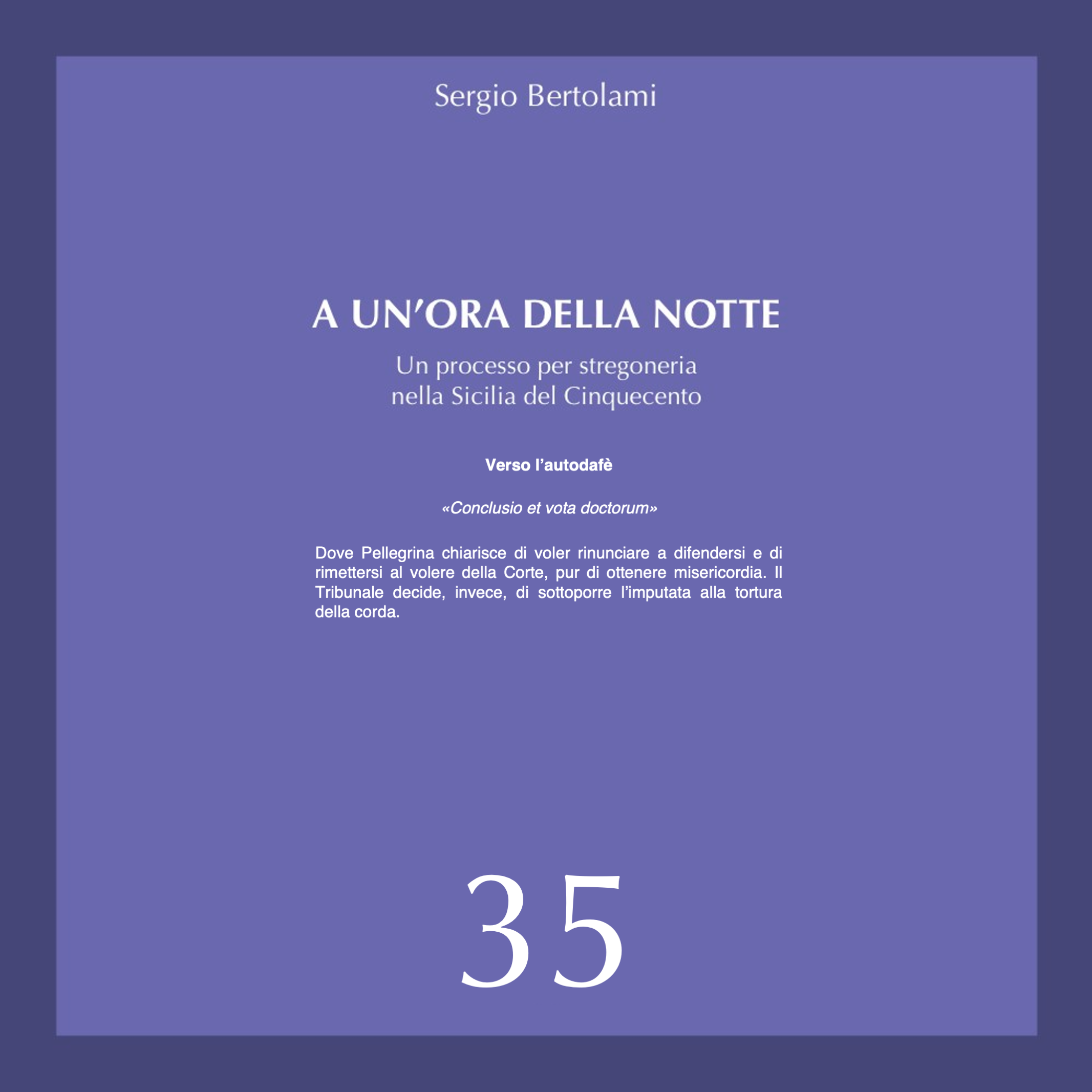Protetto: 5 – Las mugeres de fora, che en España llaman brujas
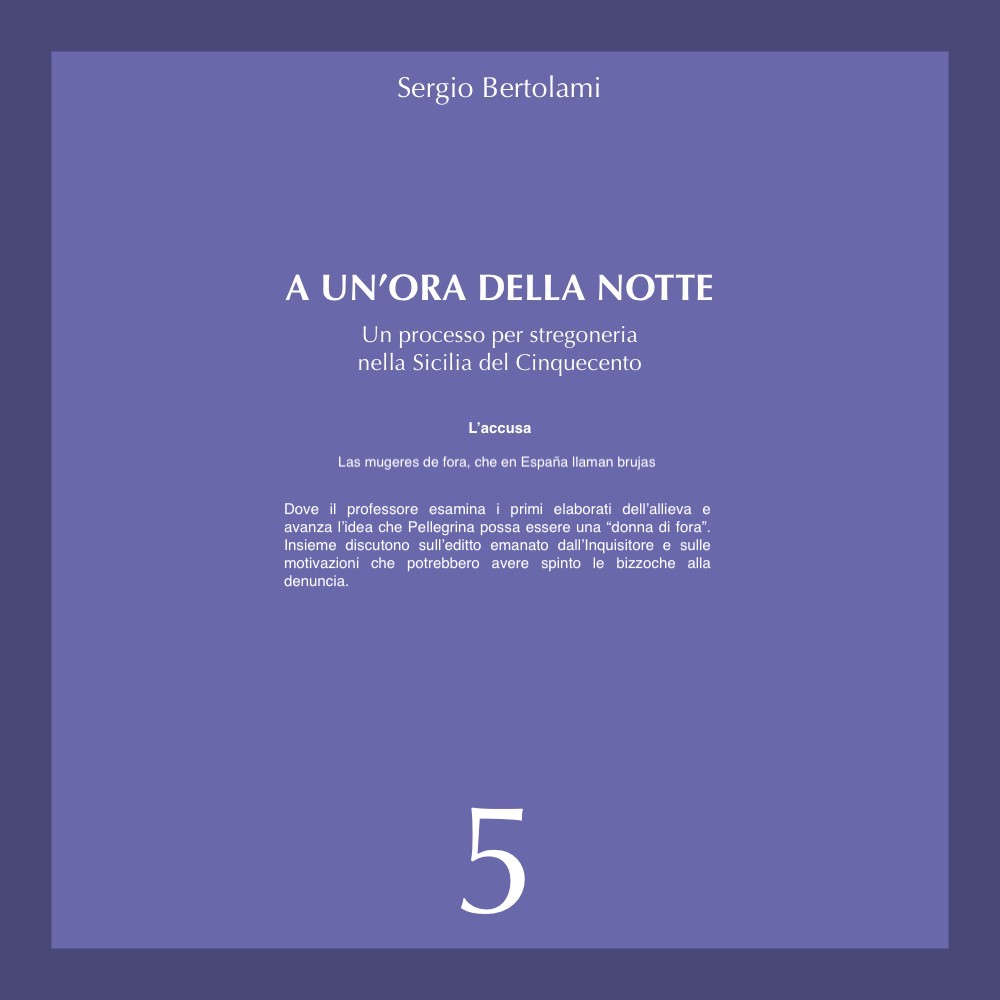
Protetto: 5 – Las mugeres de fora, che en España llaman brujas
Related Posts
Protetto: 41 – Post scriptum
- Apr 30, 2023
- Sergio Bertolami
Protetto: 39 – Gli annali della città di Messina
- Apr 22, 2023
- Experiences
Protetto: 38 – L’equità canonica
- Apr 16, 2023
- Sergio Bertolami