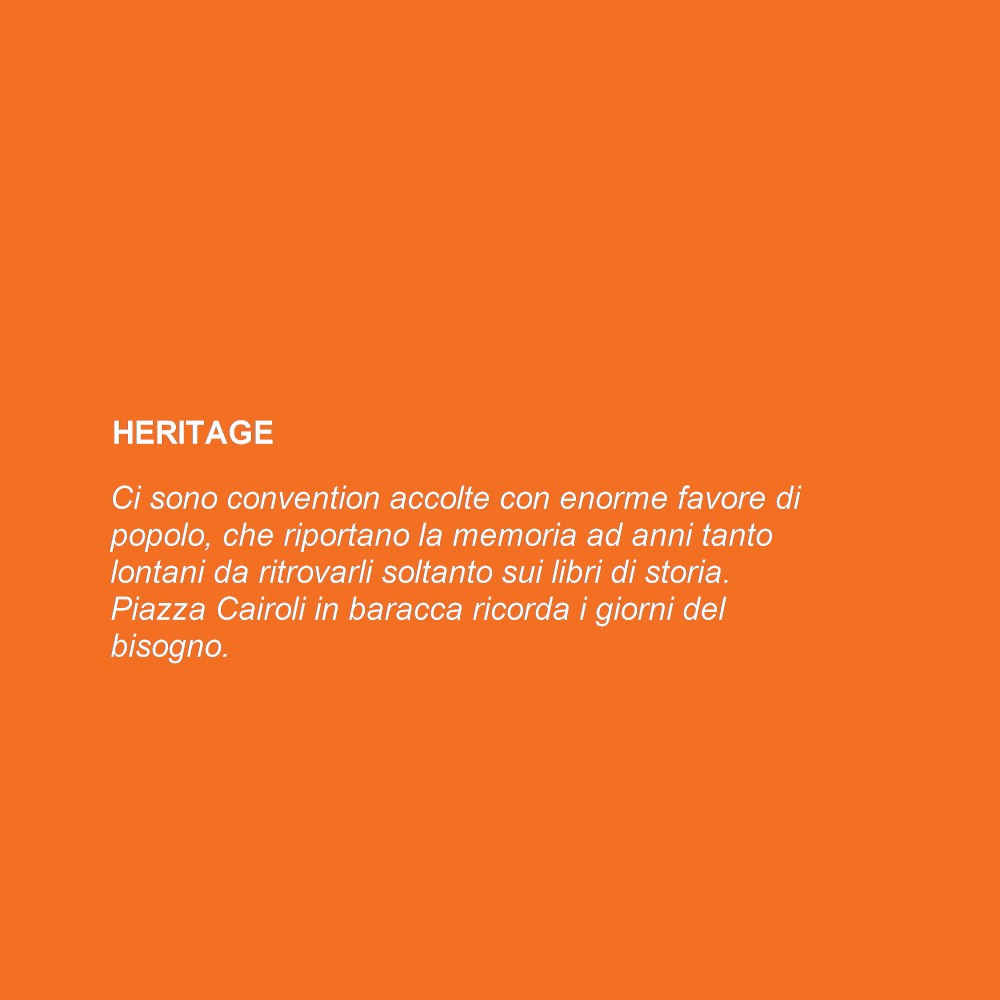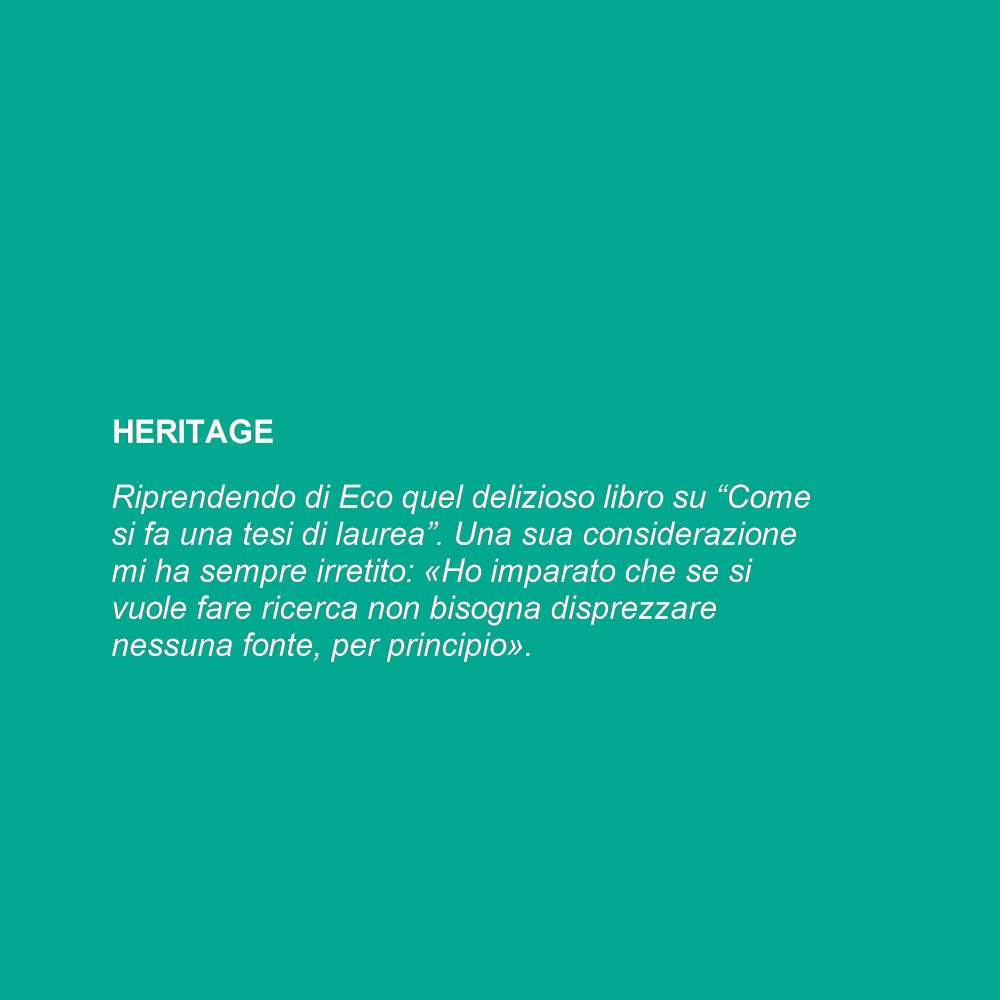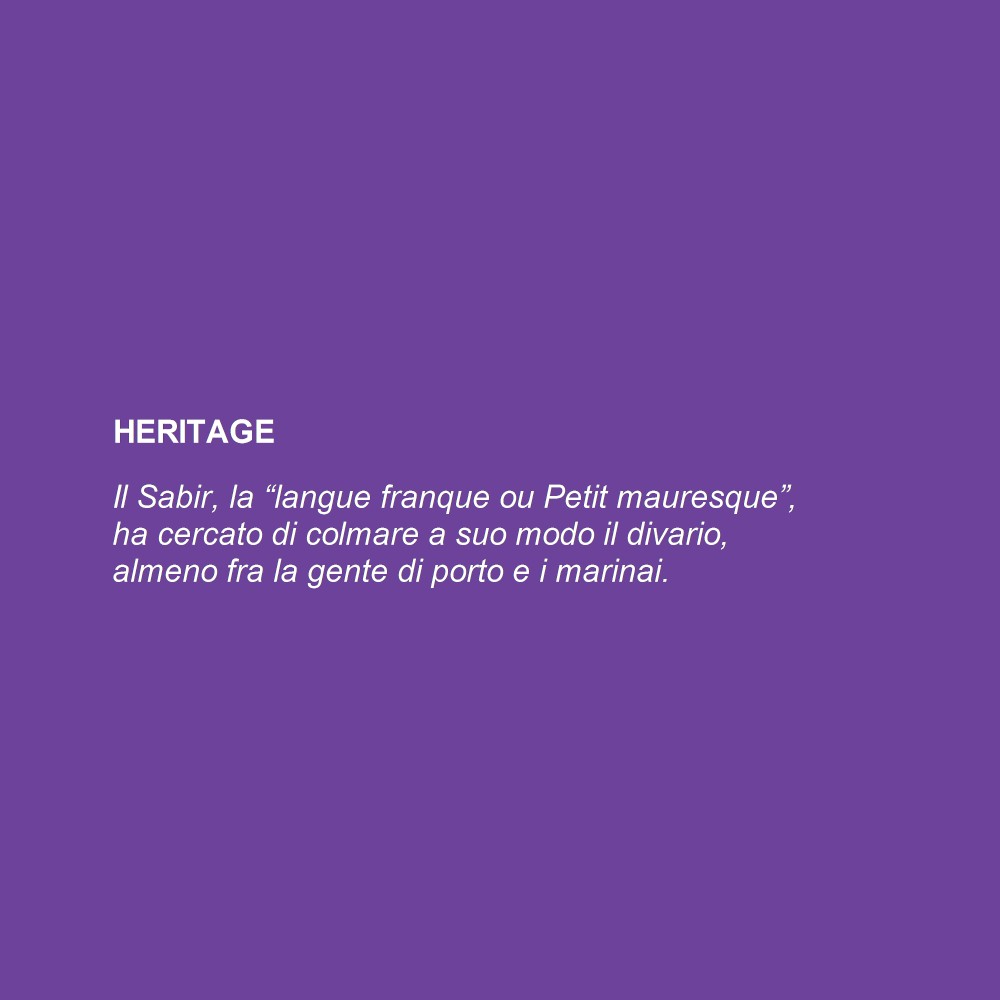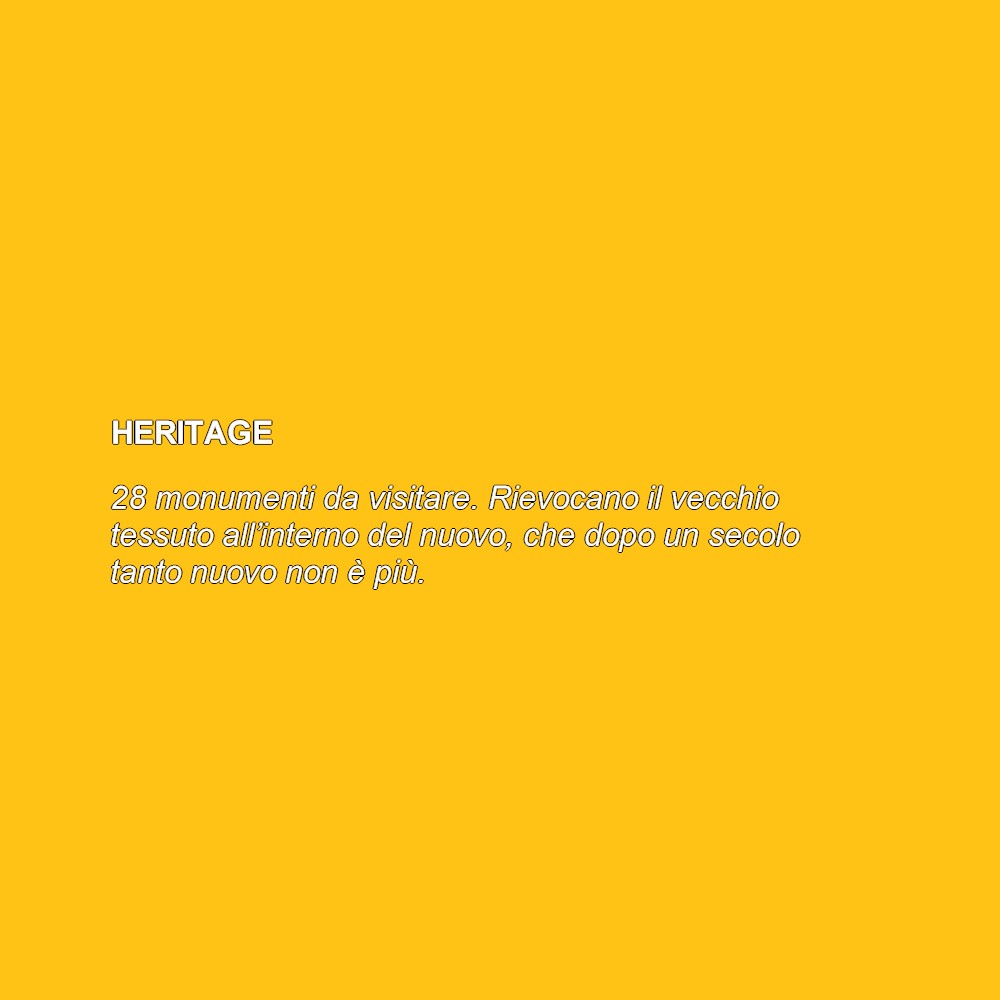SULL’ORATORE. Quanti approdano a Messina, ricevono la benedizione della Madonnina del porto: «Vos et ipsam civitatem benedicimus». Ma pochi di loro sanno che la Vergine parla la lingua della Chiesa e non quella di Cicerone. Lo studente del Classico sa, invece, che il verbo “benedire” regge il dativo e che la sua professoressa correggerebbe “vos” con “vobis”. Lo stesso studente ha imparato che quello insegnato nei licei è il “latino letterario”, che persino Dante usava maldestramente se Petrarca lo bacchettava a dovere. Adoperava il latino della “consuetudo”, che burocrazia, giurisprudenza, scienza, continueranno ad utilizzare. Cioè il latino della “rusticitas”, la rozzezza del campagnolo; mentre Cicerone promuoveva la lingua della città che nella sua “urbanitas” addensava le regole della Roma repubblicana. «Caratteristiche precipue di questo “latino nuovo” sono la regolarità, l’uniformità ortografica, la chiarezza semantica e la complessità sintattica, la cosiddetta ipotassi, in cui il congiuntivo la fa da principe e gli utilizzi di questo sono dettati da criteri convenuti». Chi parla è Nicola Gardini, docente di Letteratura comparata a Oxford. Con “Viva il latino”, spiega come tale lingua, non più parlata, sia testimoniata da una miriade di manoscritti quanto di testi a stampa. Permane nella forma scritta, quella più elaborata e monumentale, «più durevole del bronzo» (Orazio). Per cui, Dante non avrebbe concepito “La Commedia” senza Virgilio e Machiavelli i “Discorsi” senza Livio. Nel “De Oratore” Cicerone affermava: «La lingua deve portare luce alle cose». Scopriremmo quanto è scritto sulla vanità. Impareremmo a misurare le parole e non ci sogneremmo di blaterare a sproposito. Vero Di Maio?