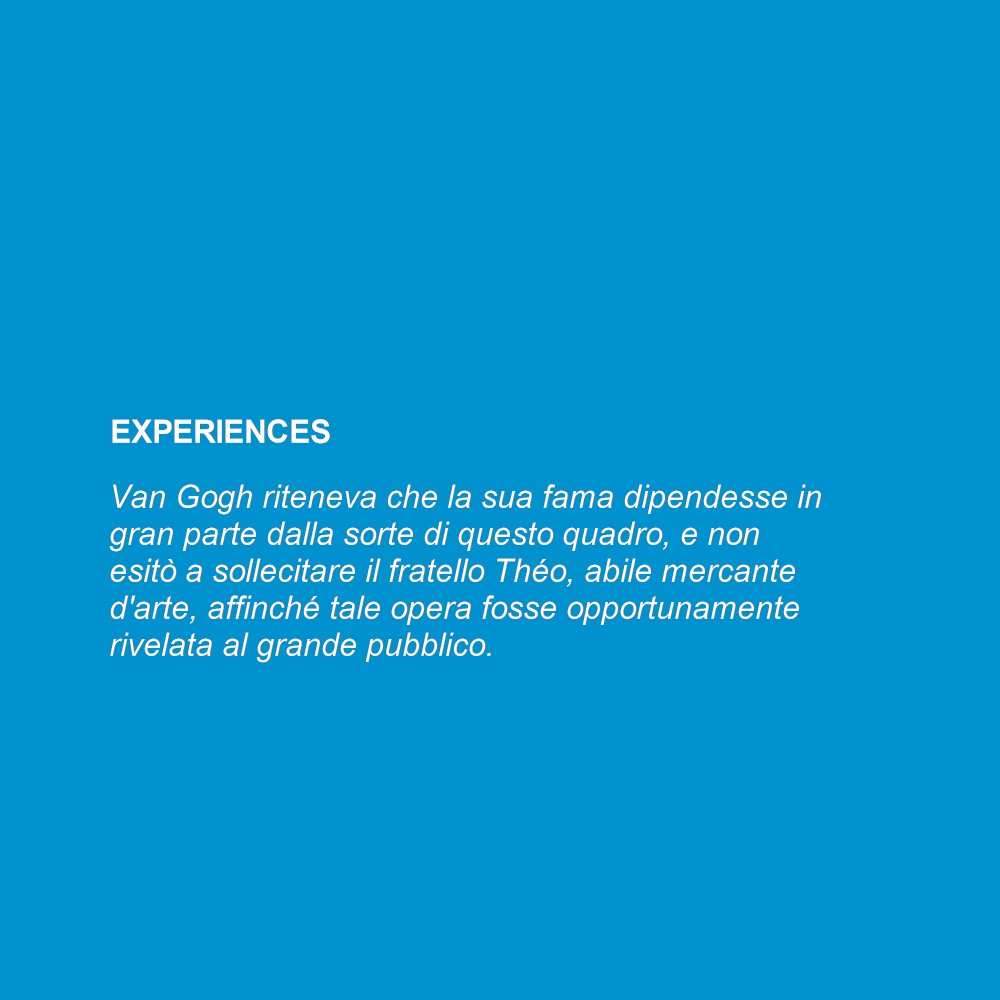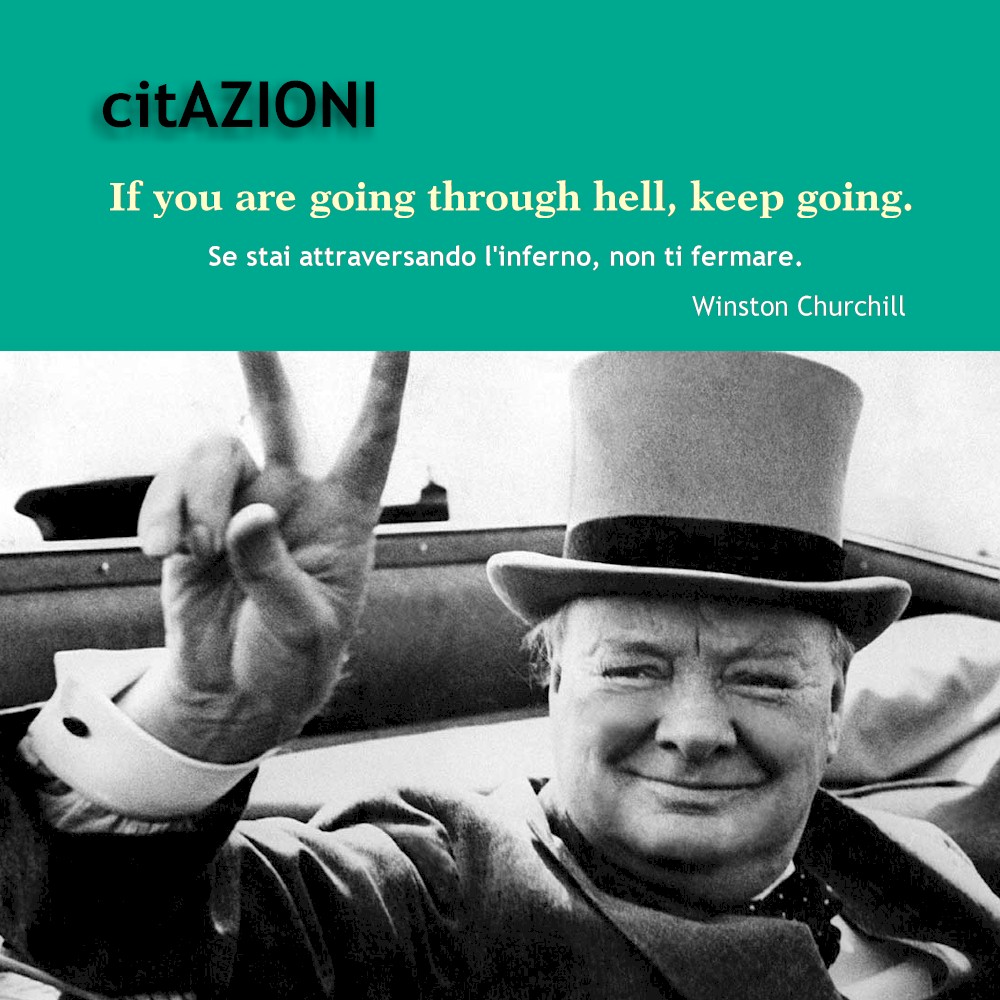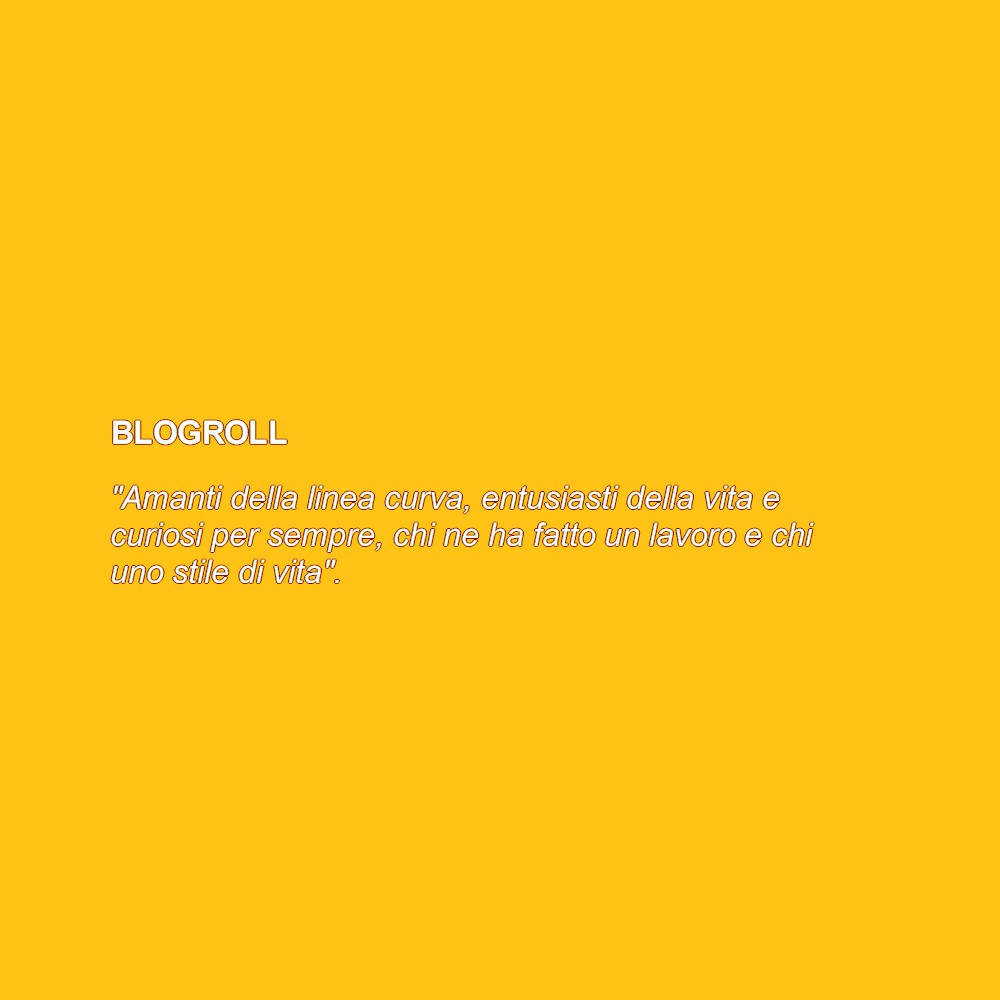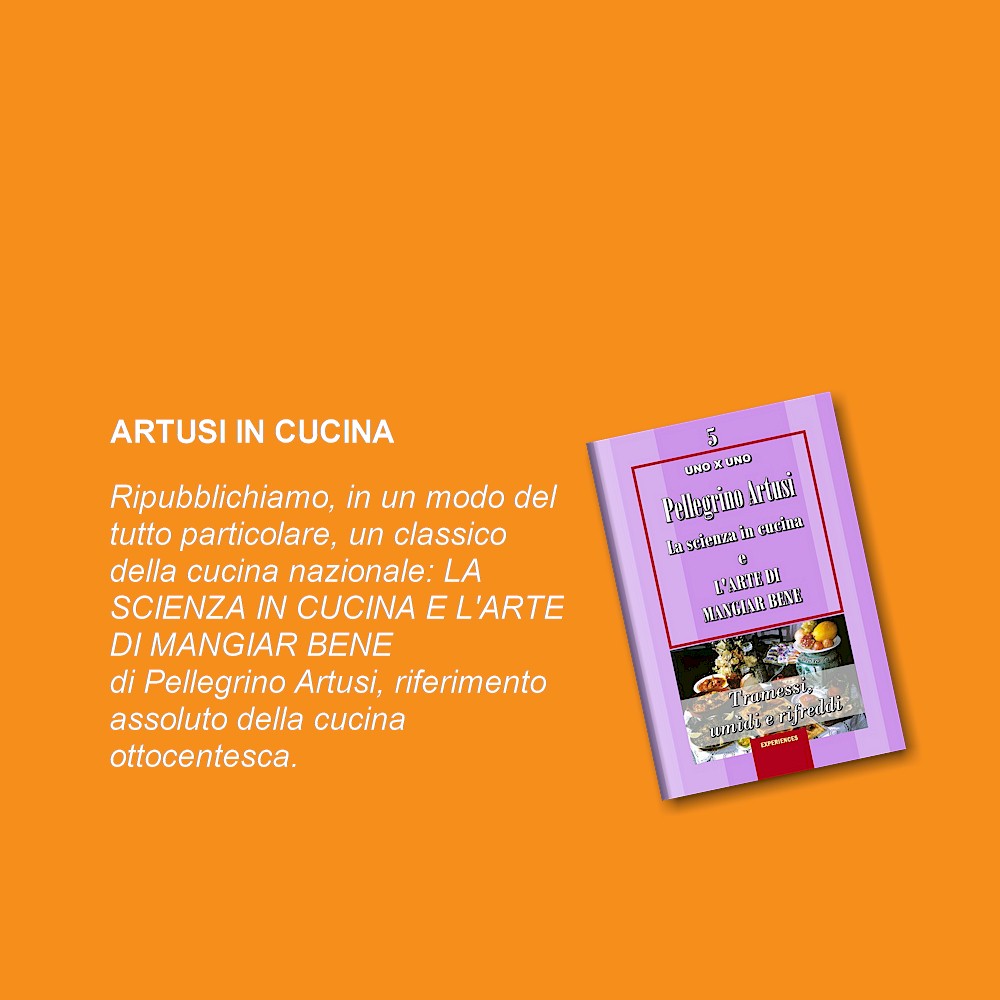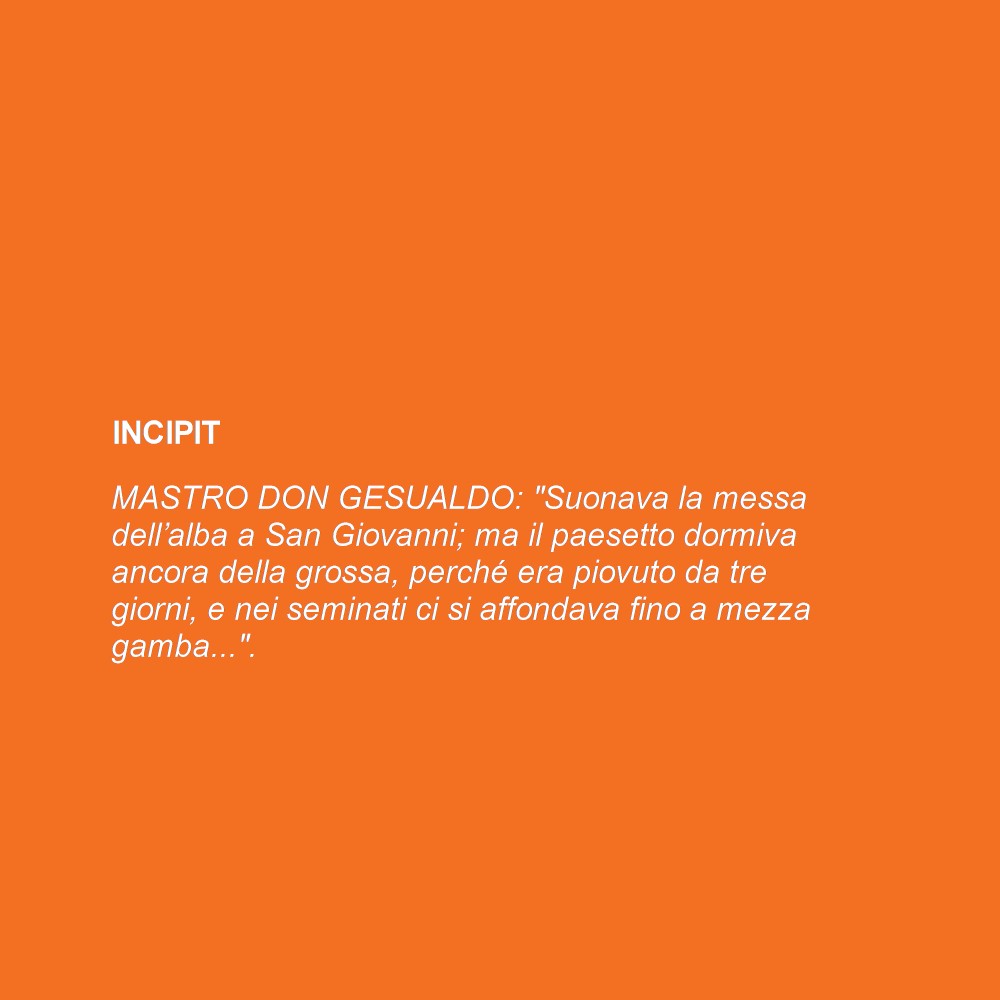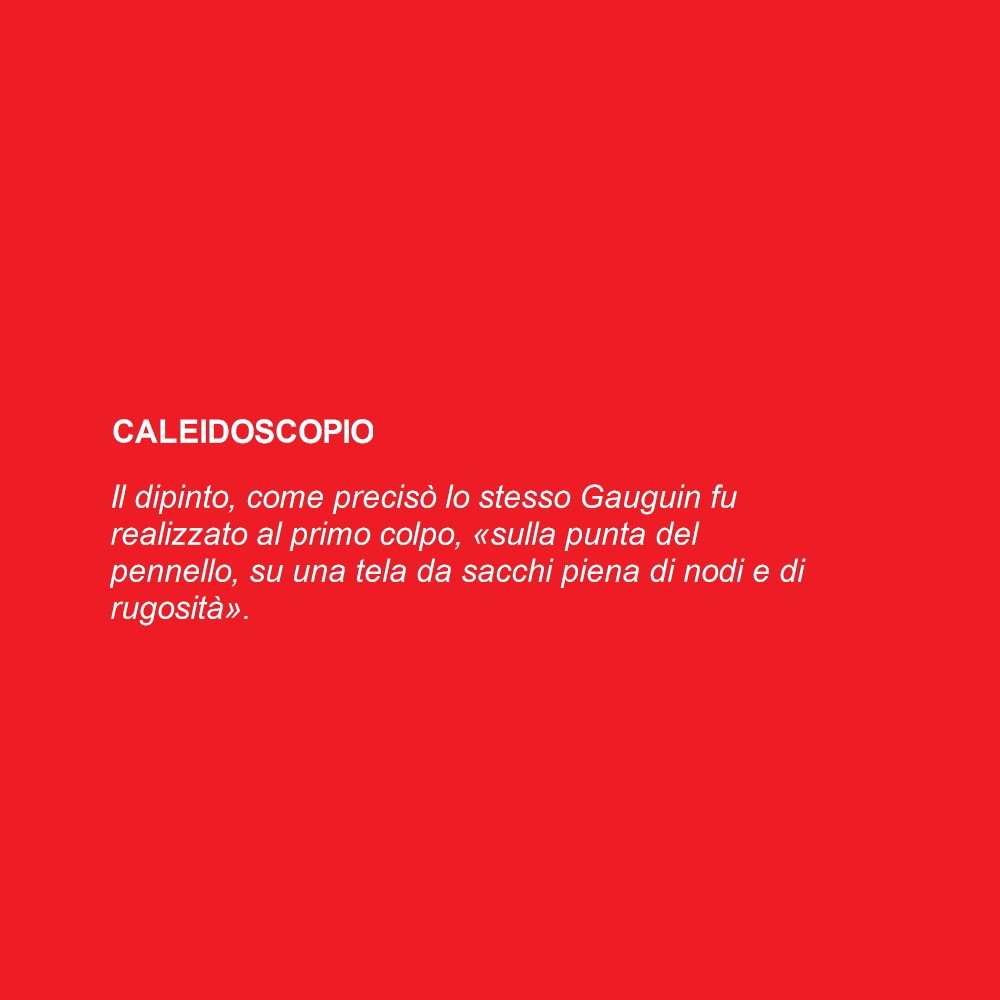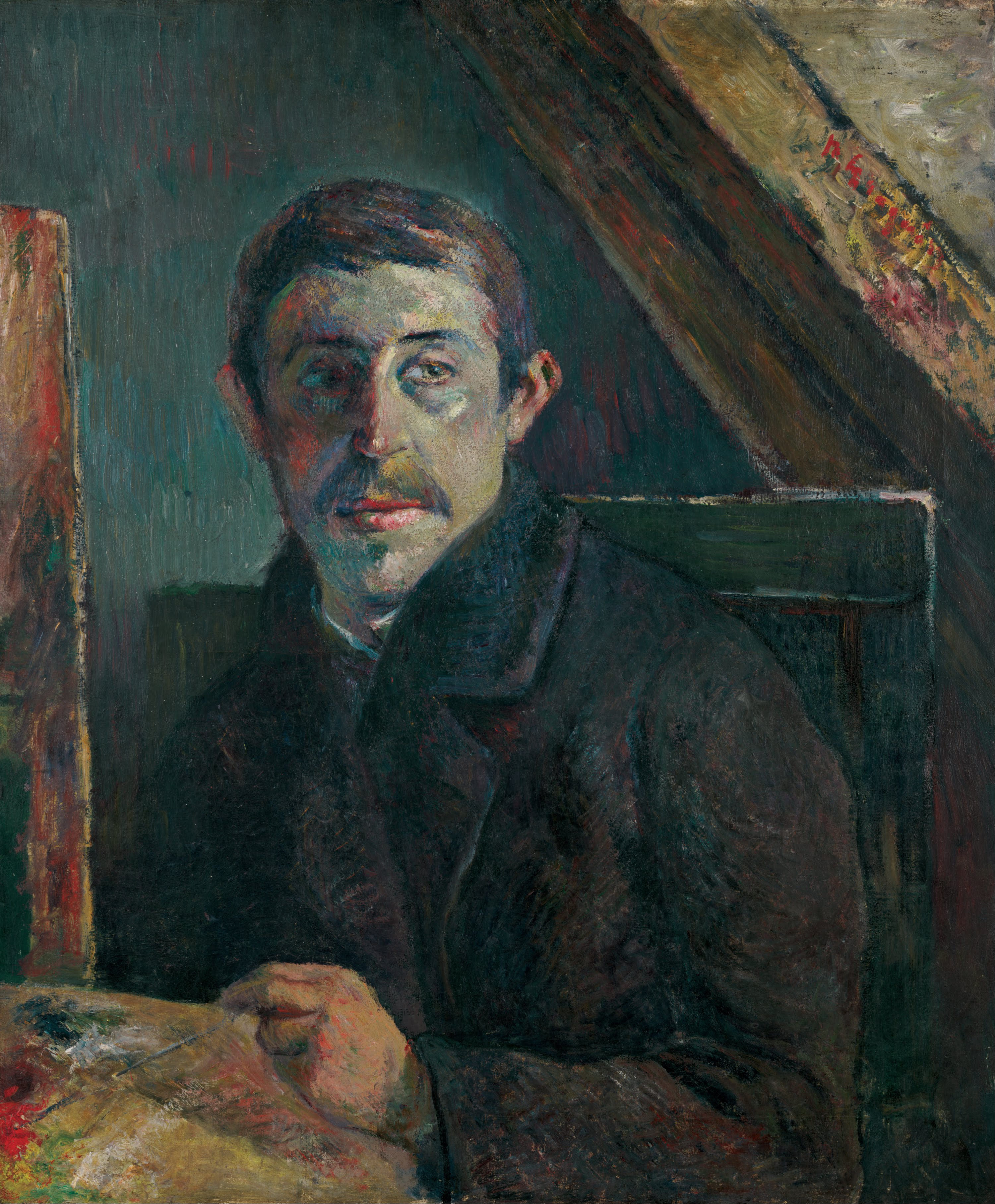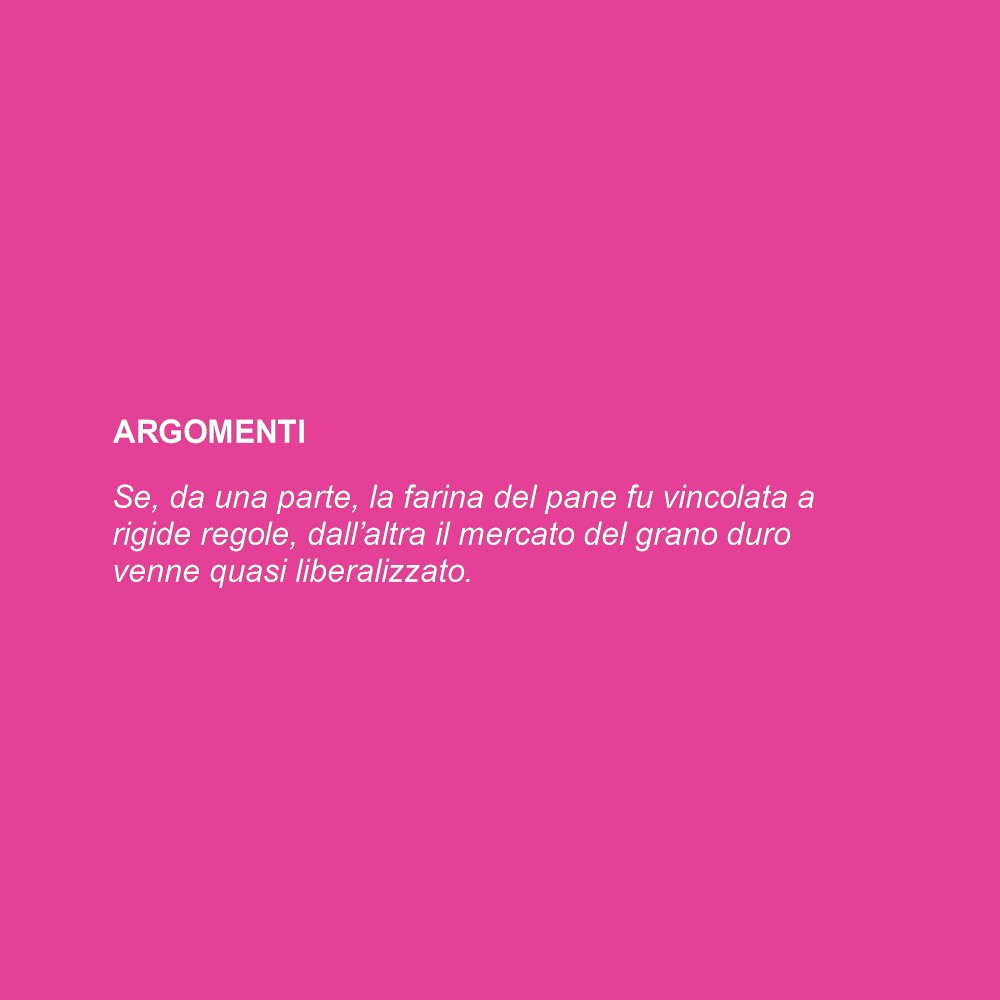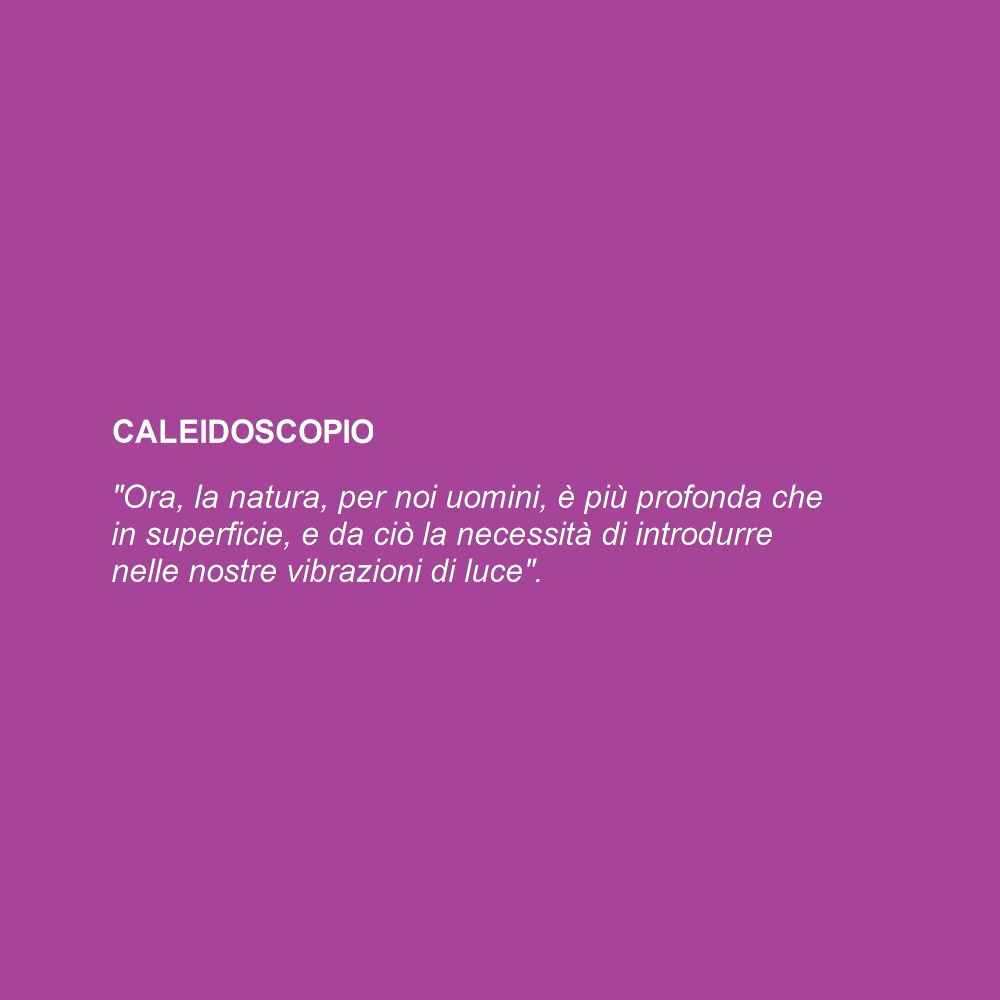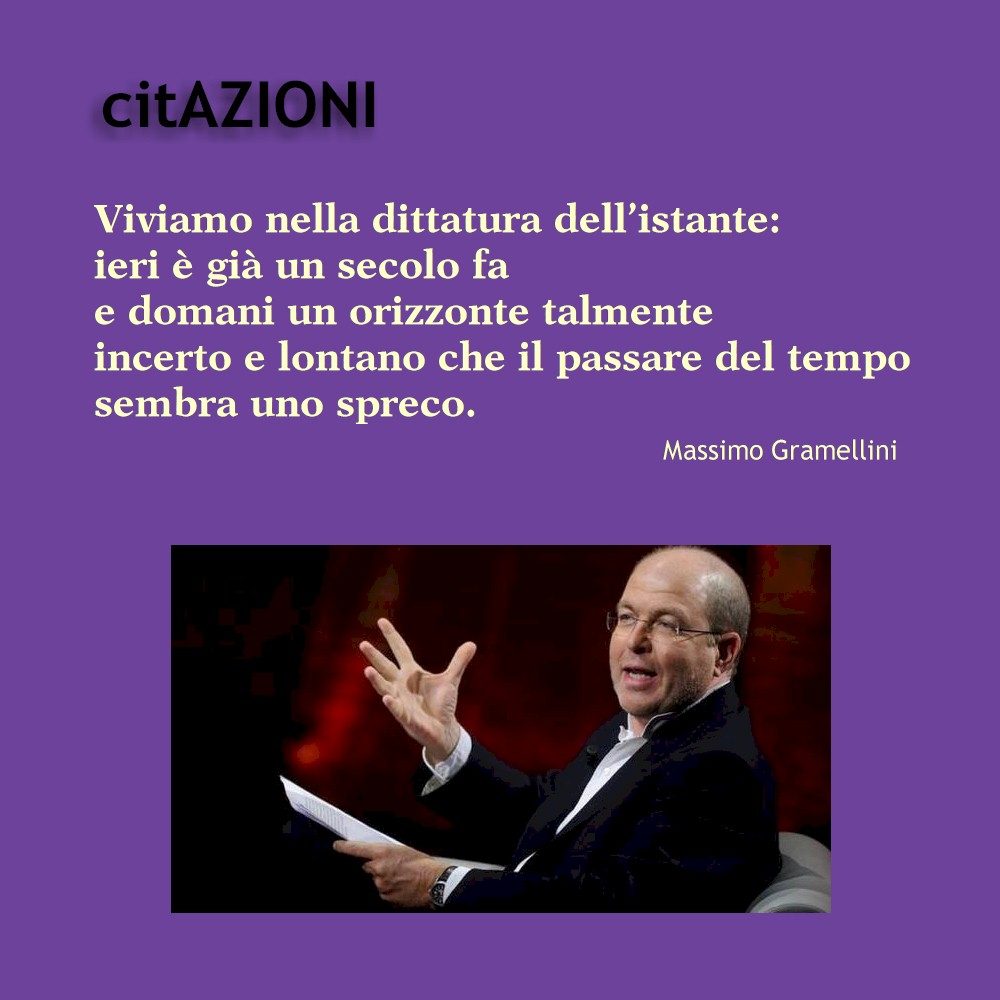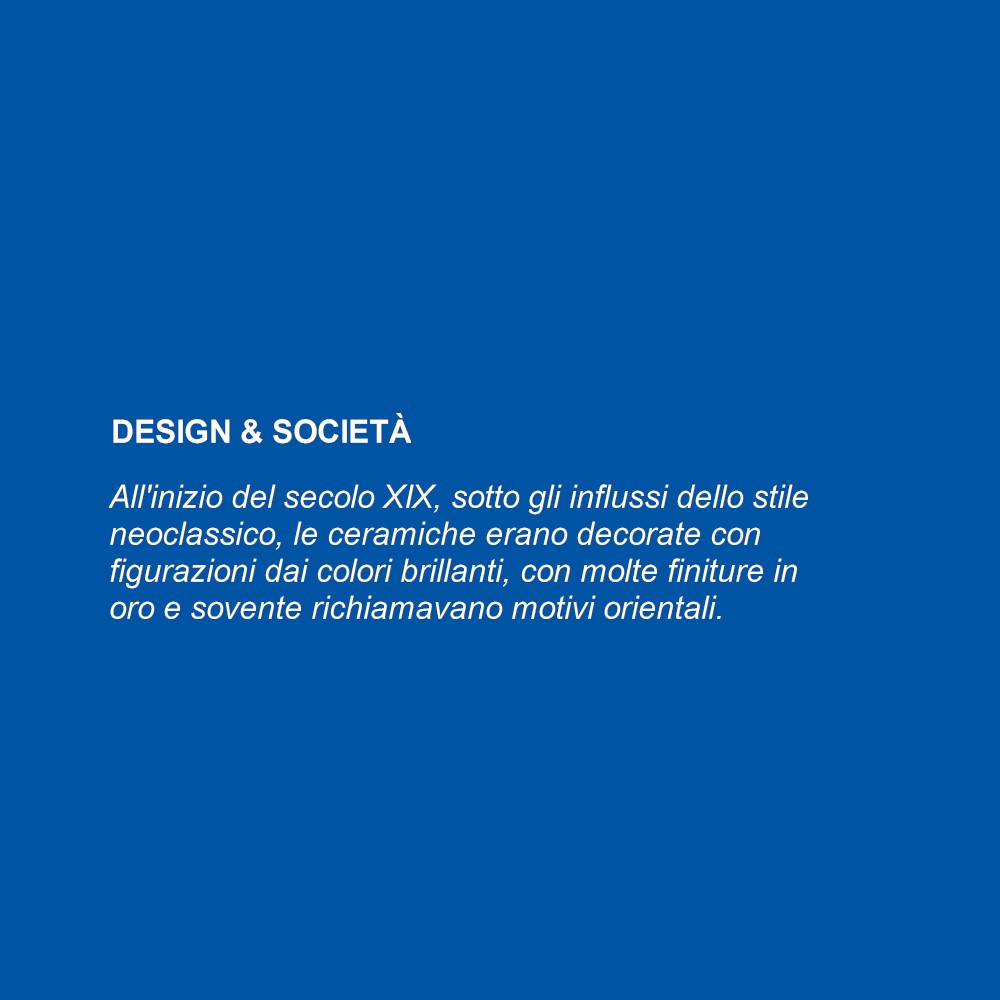I mangiatori di patate
Vincent trattò il soggetto dei mangiatori di patate in altri due cimenti pittorici, i quali sono sì propedeutici alla realizzazione della versione definitiva, ma non per questo poco interessanti: la prima redazione, anzi, presenta una notevole struttura compositiva e viene delineata da pennellate veloci che ricolmano la tela di una autenticità tutt’agreste. Meno spontanea, perché più meditata e monumentale, è invece la seconda versione de I mangiatori di patate, con la figura di tergo che si incunea rigidamente nella disposizione asimmetrica degli altri quattro commensali. La versione conclusiva di Amsterdam, terminato come si è già detto nel 1885, riprendeva e portava ad un maggiore grado di raffinatezza formale quei valori che avevano già reso celebre l’arte di Millet e di Breton e, pertanto, era quello più apprezzato da van Gogh, che la firmò e ne fornì persino un ampio commento letterario. Alla descrizione della tela, infatti, Vincent dedicò un’impressionante quantità di lettere, le quali nella loro intimità sostituivano il manifesto programmatico e, anzi, orchestravano un raffinato sincretismo tra passato e presente, letteratura e pittura, cromatismo e critica sociale.