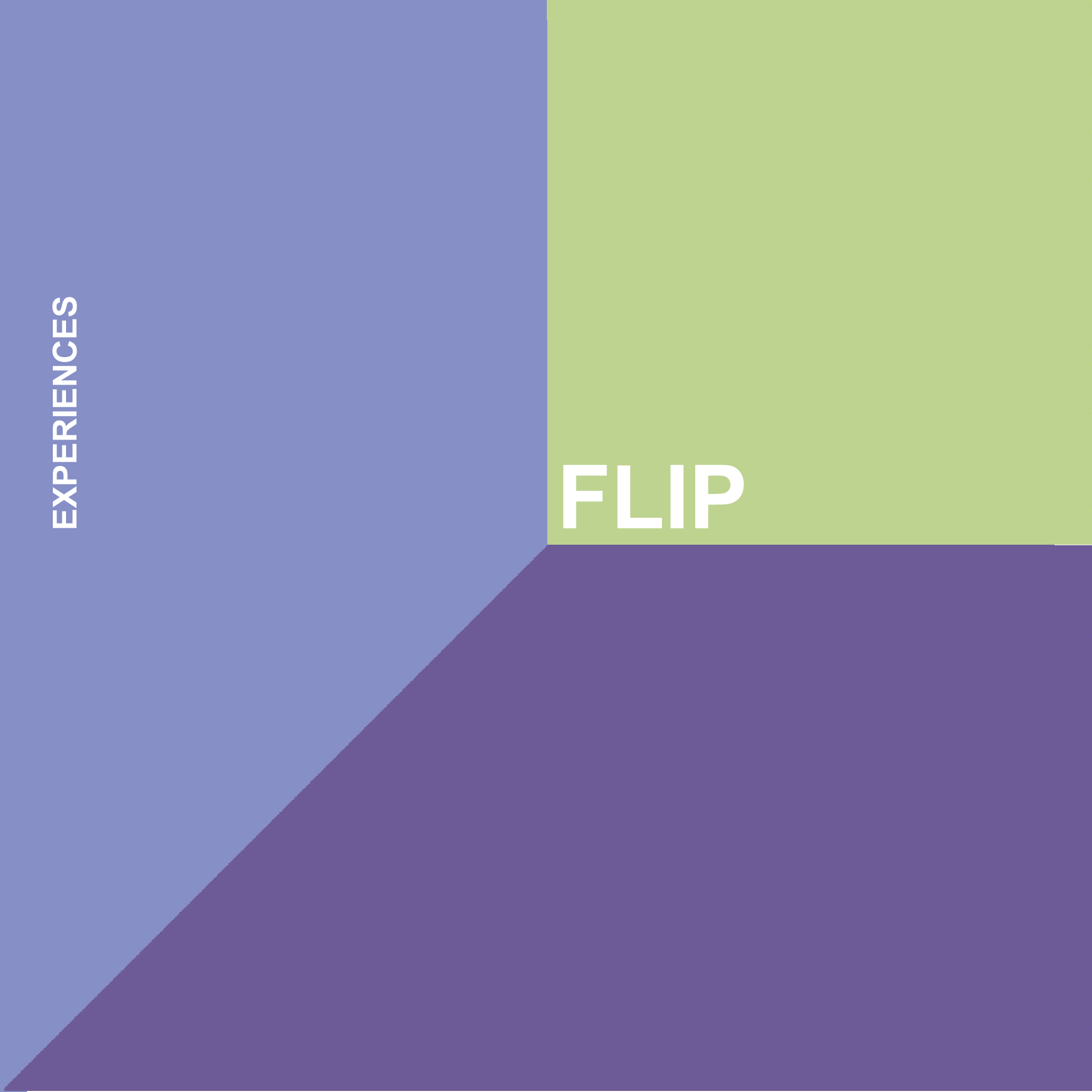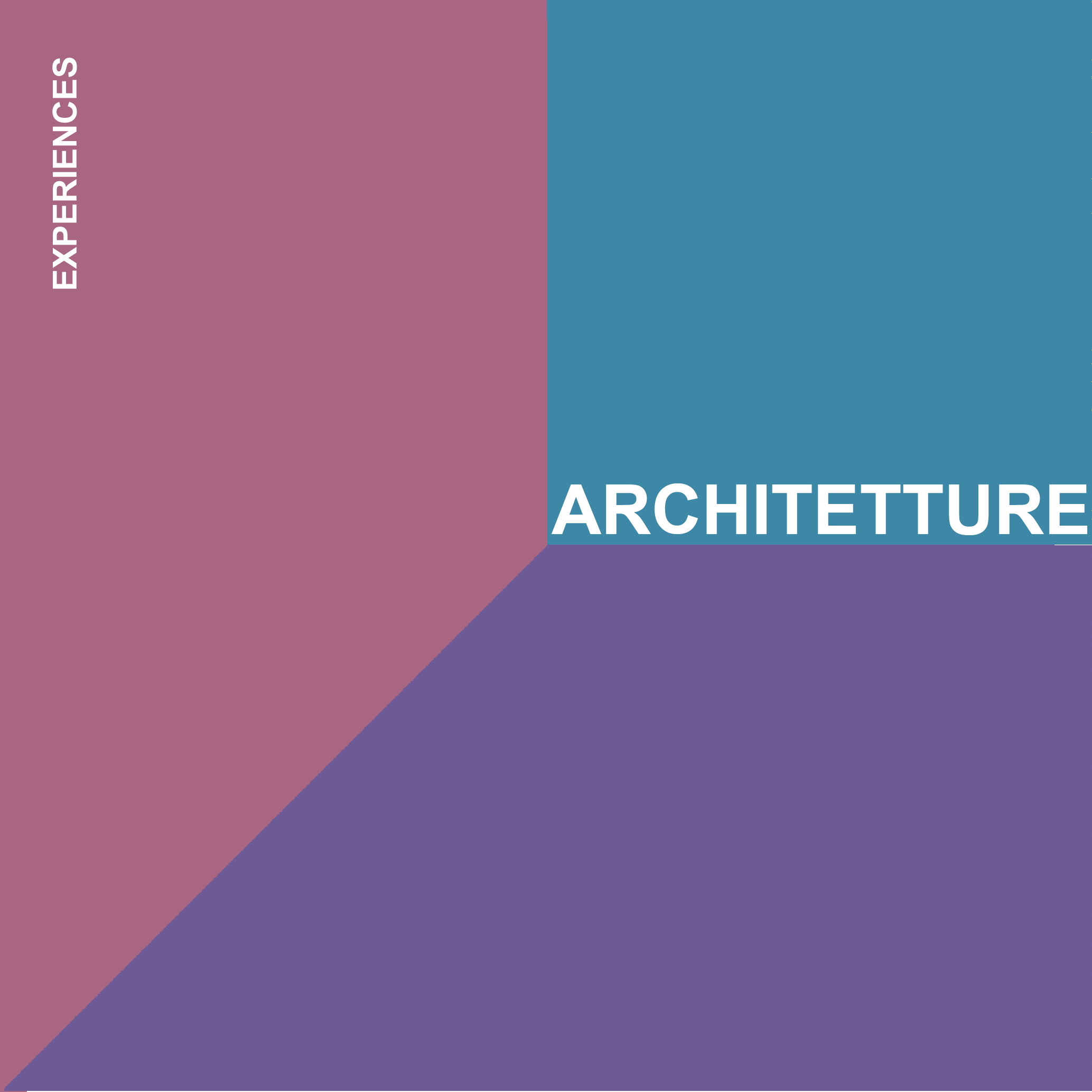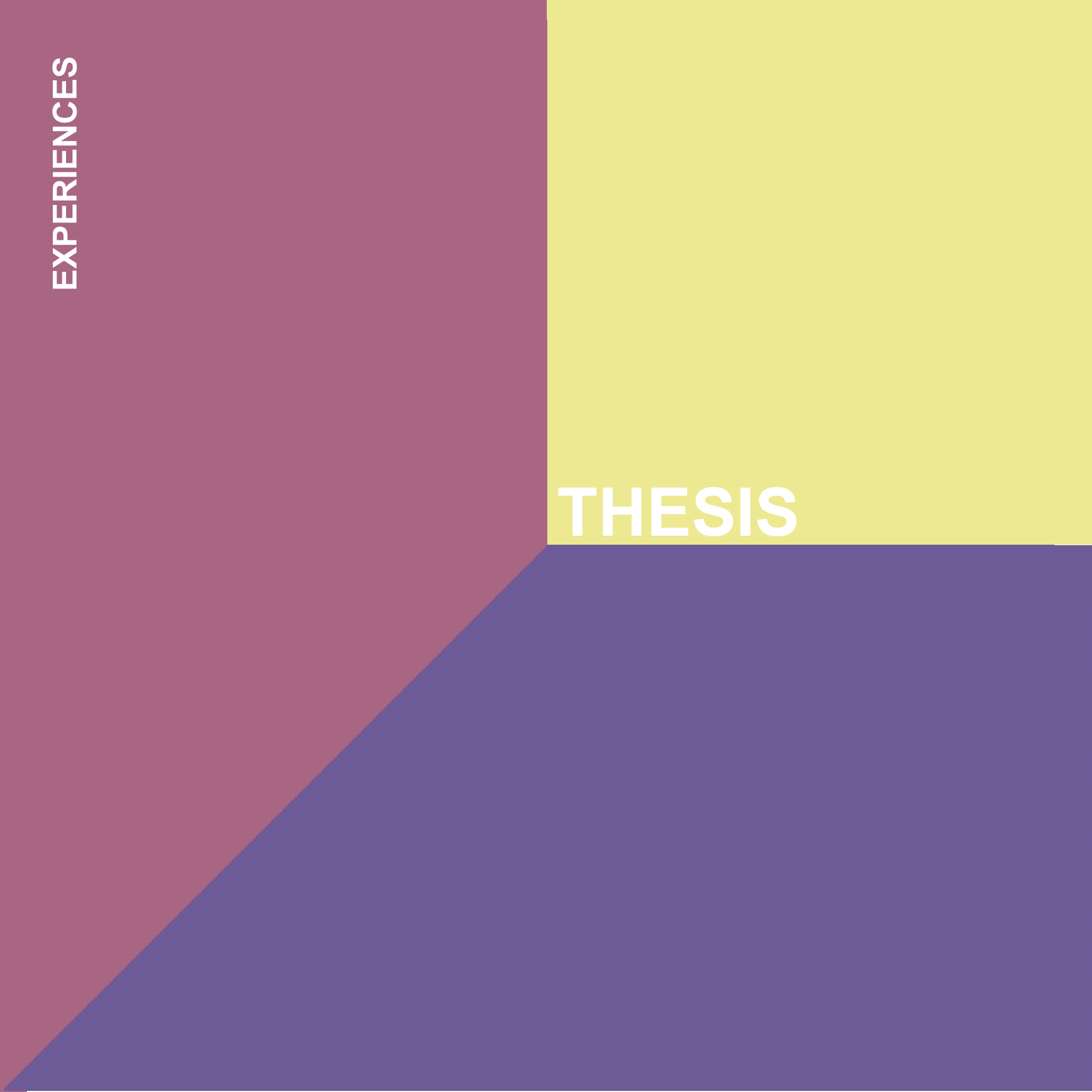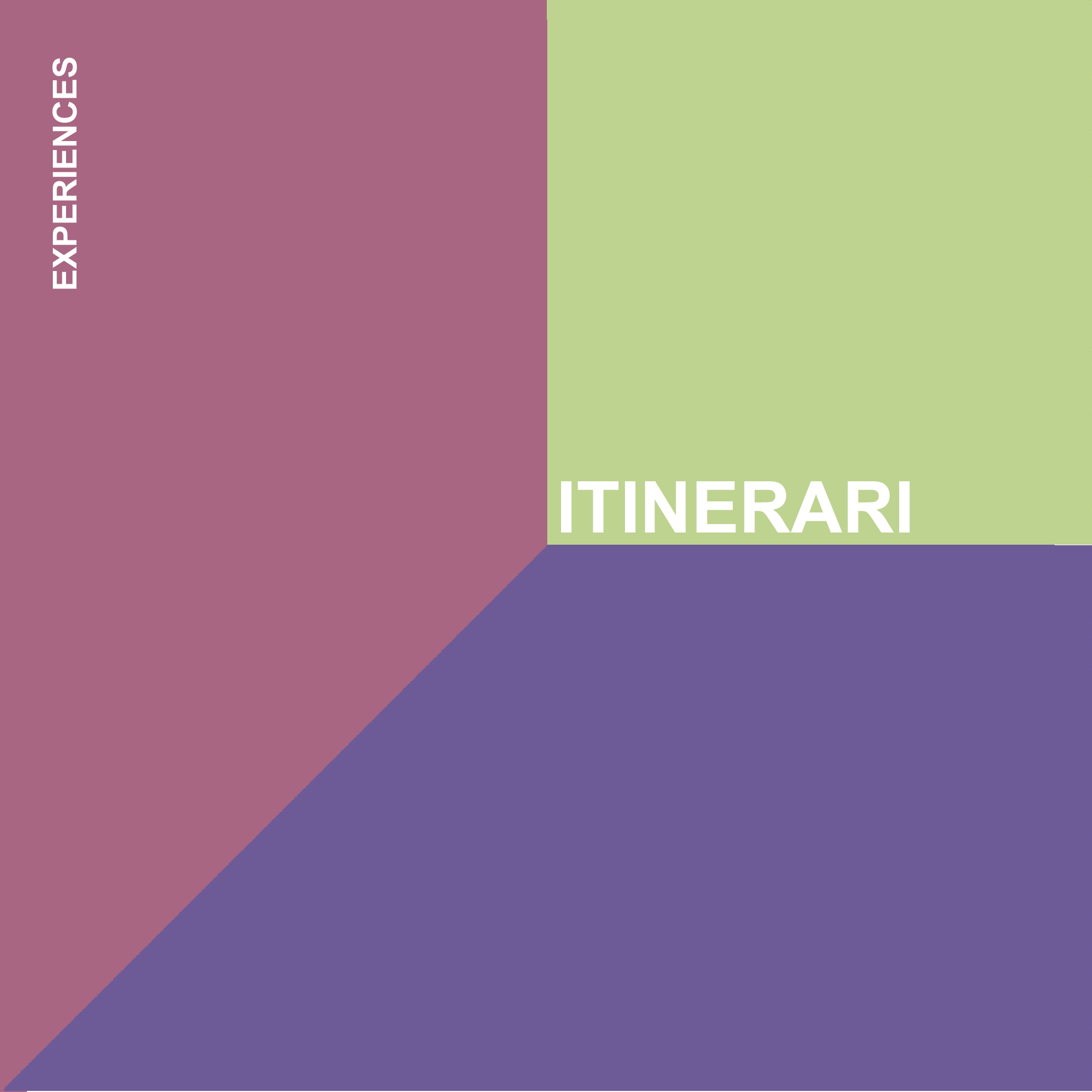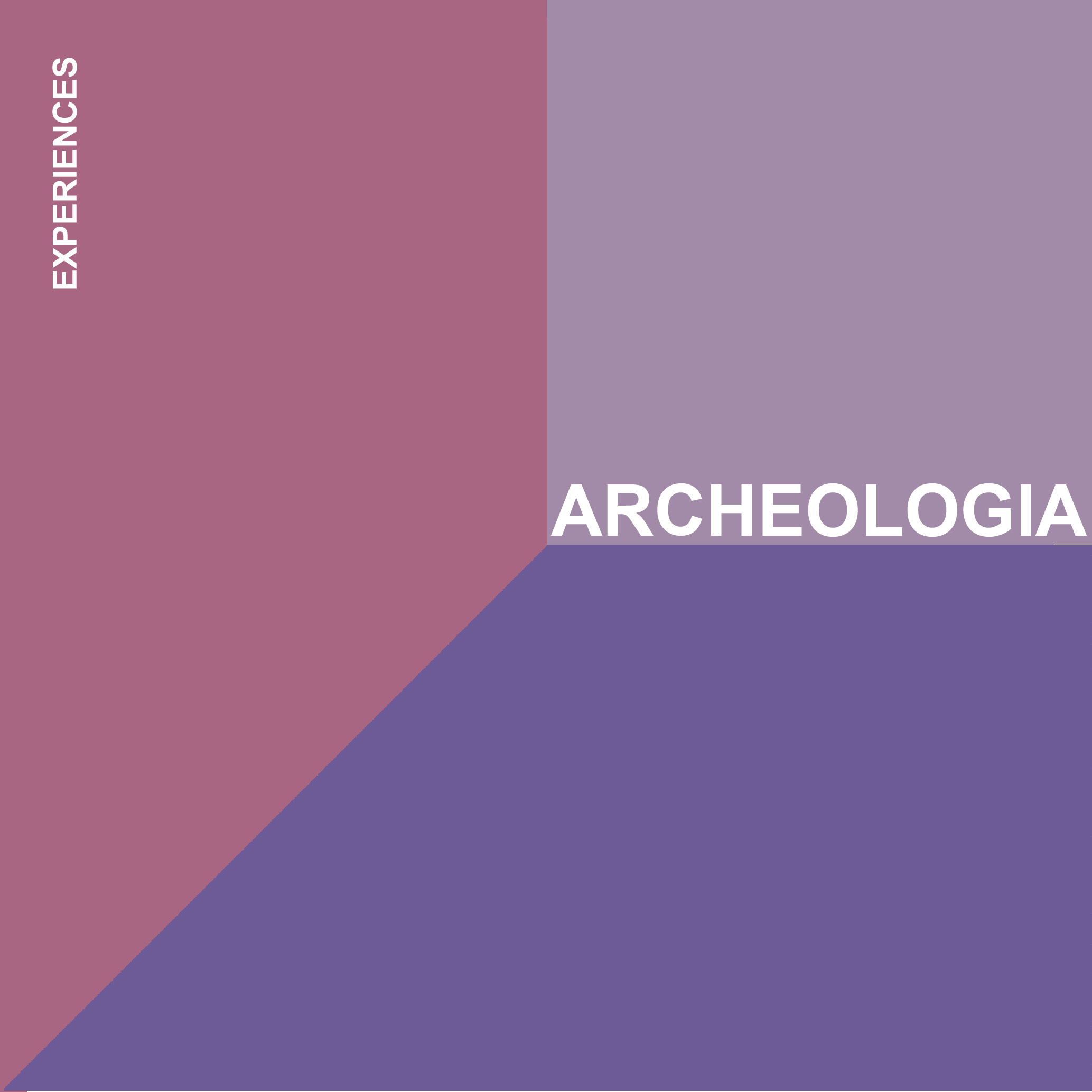Nel FLIP di oggi ricordiamo un personaggio pressoché sconosciuto, salvo agli specialisti della letteratura medica e ad alcuni studiosi di storia. Si tratta delle tristi vicissitudini riguardanti l’ermafrodita Herculine Barbin, che le cronache dell’epoca segnalarono al pubblico per la particolarità del suo sesso. L’Écho rochelais del 18 luglio 1860 scriveva di una ragazzina di ventun anni: «Un’insegnante straordinaria sia per gli alti sentimenti del suo cuore come per la sana istruzione, era vissuta, pietosamente e modestamente, fino ad oggi, nell’ignoranza di se stessa, vale a dire, credendo di essere ciò che appariva nell’opinione di tutti, sebbene ci fossero, per persone esperte, particolarità organiche che avrebbero dovuto generare stupore, poi il dubbio e, con il dubbio, la luce; ma l’educazione cristiana della ragazza era l’innocente benda che velava la verità. Finalmente, abbastanza recentemente, una circostanza fortuita è arrivata a gettare qualche dubbio nella sua mente; la chiamata è stata fatta alla scienza, e un errore sessuale è stato riconosciuto… La ragazza era un giovane uomo». In seguito ad esami medici si venne alla determinazione di riconoscere ufficialmente la Barbin di sesso maschile. Fu così che Alexina cambiò il nome in Abel e il caso balzò sulle pagine dalla stampa. Abel si trasferì a Parigi. Qui visse in povertà e scrisse la propria biografia, dalla quale apprendiamo quasi tutto ciò che oggi conosciamo. A febbraio del 1868, il portinaio del palazzo di rue de l’École-de-Médecine, trovò il giovane esanime nel suo appartamento. Barbin si era suicidato col gas di una stufa. Le sue memorie furono rinvenute accanto al letto. Questo manoscritto è stato trascritto quasi interamente dal dottor Ambroise Tardieu nel suo libro “Questione medico-legale di identità in relazione ai difetti di conformazione degli organi sessuali” (Parigi, 1874). Nella presentazione, Tardieu ricorda le circostanze della scoperta del cadavere e del manoscritto: «In una delle più povere mansarde del Quartiere Latino, a Parigi, all’inizio dell’anno 1868, un giovane si è dato la morte (…) il Dr. Regnier, medico dello stato civile, e il commissario di polizia del quartiere si sono recati a casa del poveretto. Dopo aver constatato il decesso e le anomalie fisiche che presentavano certe parti del corpo, hanno rinvenuto su di un tavolo una lettera autografa indirizzata alla madre in cui il suicida chiedeva perdono (…) Oltre a questa lettera, il giovane ha lasciato un manoscritto in cui racconta la sua triste esistenza. Le pagine che seguiranno sono estratte testualmente … Riporterò qui il manoscritto quasi nella sua interezza e come mi è stato trasmesso. Escluderò solo passaggi che allungano la storia senza aggiungere interesse, ma ovunque rispetterò la forma che ha un particolare timbro di sincerità e di impressionanti emozioni». La triste vicenda ha ispirato molti saggi ed opere letterarie. Se ne è occupato, fra l’altro, anche Michel Foucault, del quale riportiamo di seguito la traduzione italiana della prefazione all’edizione americana del libro “Herculine Barbin, dite Alexina B” edito da Gallimard. Nel 1985 un film è stato presentato al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard ed oggi, come troviamo nell’articolo de LA STAMPA va in scena fino al 27 aprile lo spettacolo teatrale scritto da Olivia Manescalchi: «Una strana confessione. Memorie di un ermafrodito». Una storia angosciante che rispecchia il clima di un’epoca, ma che ancora oggi fa riflettere su come occorra rendere onore a qualunque diversità.
LEGGI ANCHE I SEGUENTI TESTI:
HERCULINE BARBIN (Saint-Jean-d’Angély, 8 novembre 1838 – Parigi, 13 marzo 1868) è stato uno pseudo-ermafrodito francese, a cui era stato attribuito alla nascita il sesso femminile a causa di una variazione dei genitali, ma al quale fu imposto per sentenza di tribunale di assumere sesso e nome maschile dopo la pubertà. Al momento di suicidarsi lasciò un celebre memoriale, tradotto in molte lingue. Il suo caso è stato studiato in anni recenti, a partire da Michel Foucault, per la luce che getta sulla questione della formazione dell’identità di genere e della sua importanza nell’equilibrio psichico dell’individuo. (Da Wikipedia, l’enciclopedia libera).
LEGGI LA SCHEDA SU WIKIPEDIA
LA STAMPA
Per il lieto fine il coraggio non basta: a teatro il dramma dell’ermafrodita Herculine
ARTICOLO di Silvia Francia sul caso di Herculine Barbin