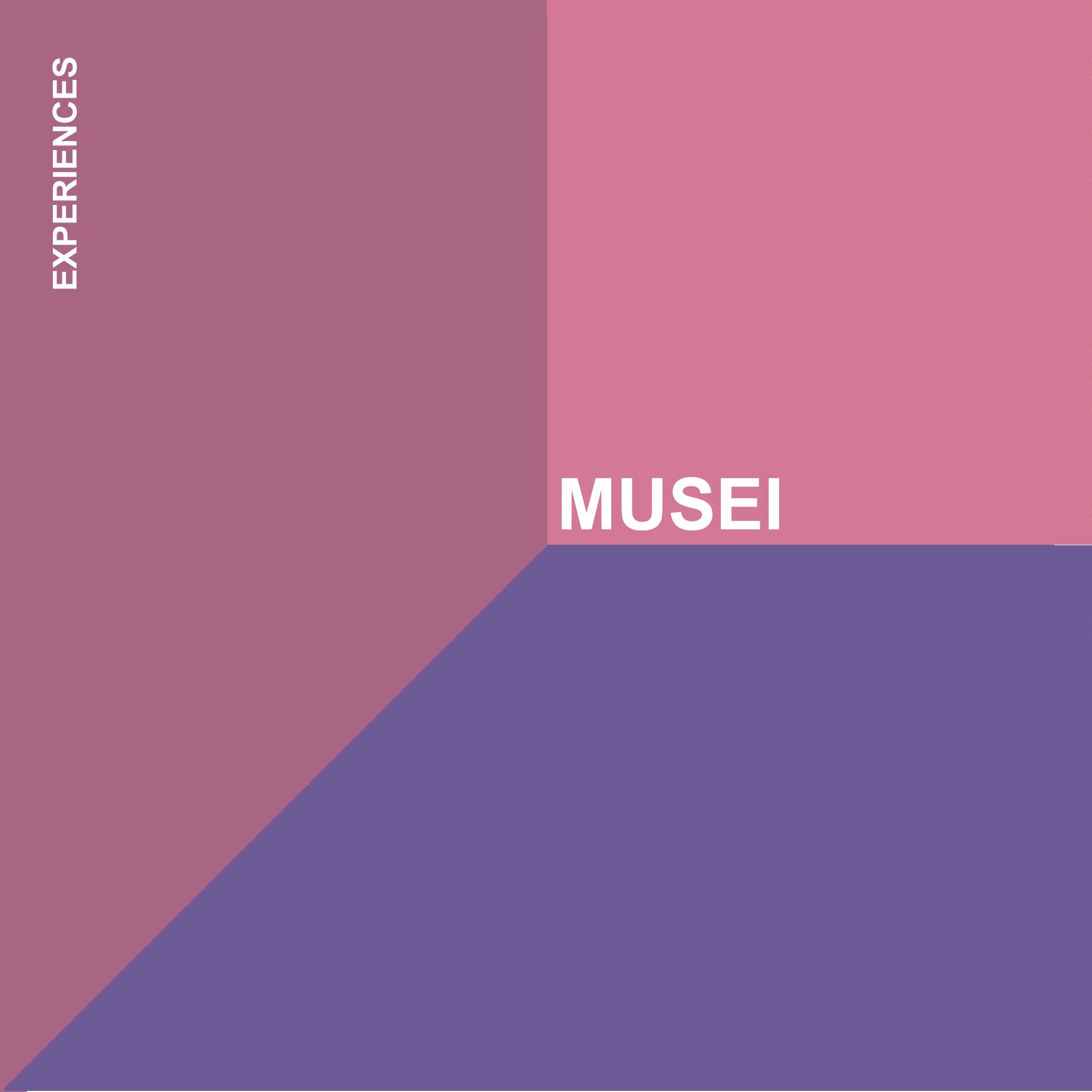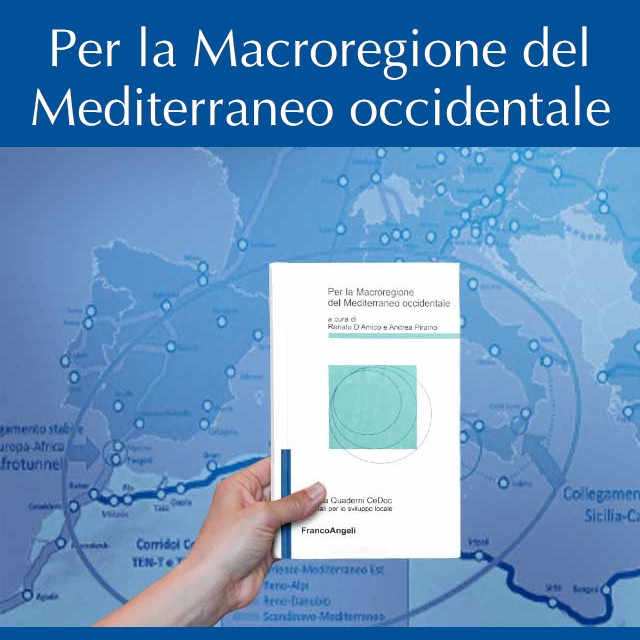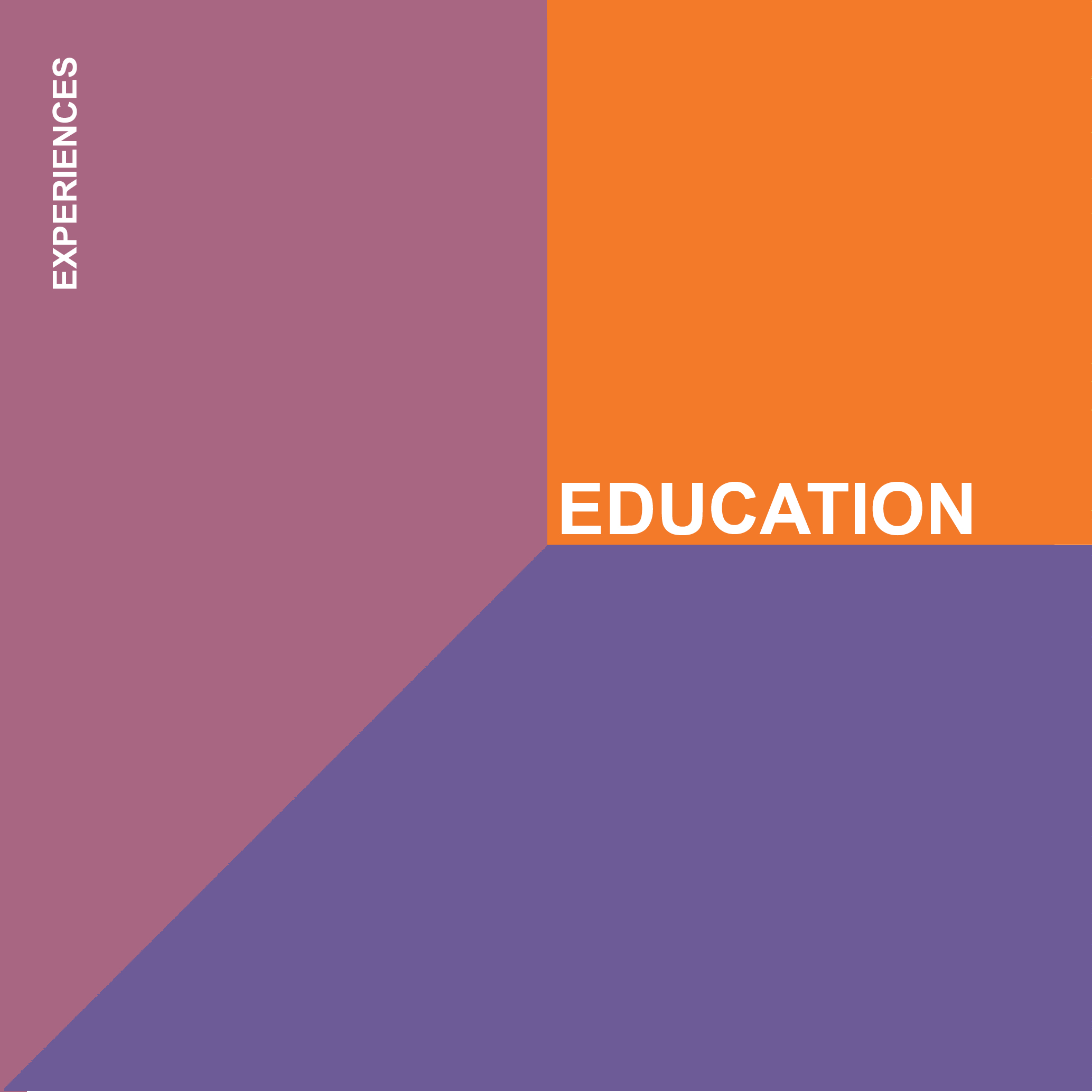In queste pagine presentiamo alcuni degli interventi al Convegno del 7 settembre 2018 presso la Stazione Marittima del porto di Napoli in occasione della presentazione del libro “Per la Macroregione de Mediterraneo occidentale” dei professori Renato D’Amico e Andrea Piraino (Franco Angeli, editore). L’appuntamento è stato organizzato da Paolo Pantani, presidente emerito di Acli Beni Culturali, Stanislao Napolano, presidente dell’Associazione Carlo Filangieri, Giordano Editore e quotidiano online Il Denaro.it.
>>> Intervento di Renato D’Amico
Ringrazio, innanzitutto, gli amici napoletani che hanno ritenuto che questo volume curato da me e da Andrea Piraino meritasse una presentazione. Ma li ringrazio, soprattutto, e con essi ringrazio tutti coloro che sono stati presenti a questa iniziativa, spesso apportando un loro prezioso contributo di riflessione, per il fatto che nonostante le innumerevoli e ben note difficoltà di un processo tanto complesso, continuano da anni, ormai, e con lodevole impegno nella proposta di istituzione della Macroregione del Mediterraneo centro occidentale. Ed è in piena sintonia con la loro invariata passione che oggi colgo l’accelerazione che negli ultimi mesi ha interessato questo processo istitutivo
Come è stato sottolineato sin dagli interventi di apertura di questa mattina, il senso di questo processo è quello di voler procedere dal basso, secondo quell’approccio bottom-up suggerito dall’UE e nel quale il “Territorio” è chiamato ad assumere un ruolo di assoluto protagonista. Ne è prova l’ampia partecipazione a questa iniziativa degli attori territoriali privati, dei principali stakeolders, dei quali ho potuto apprezzare gli interventi. Né sarebbe potuto essere diversamente: è tra i principali obiettivi della Strategia Europea delle Macroregioni quello di prendere le mosse da una visione condivisa dei «punti di forza» e di «debolezza» – ma anche le «opportunità» e le «minacce», come richiede l’analisi SWOT – che accomunano le regioni che decidono di aderirvi, così come essi vengono rappresentati dagli attori (pubblici e privati) che vivono ed operano in quel territorio, al fine di pervenire ad una strategia comune ispirata non già alla mera “rincorsa delle emergenze” bensì a quel metodo della programmazione (interventi integrati e coordinati tra loro, e proiettati sul medio-lungo periodo) ahimè troppo spesso trascurato dalle nostre istituzioni pubbliche.
È quasi superfluo dire, inoltre, quanto l’istituzione della Macroregione del Mediterraneo occidentale costituisca un’occasione straordinariamente importante in particolare per il Mezzogiorno d’Italia, e, soprattutto per quelle occidentali che si affacciano sul Mediterraneo. Le cose che ho avuto il piacere di ascoltare questa mattina confermano, in tal senso, quanto scrivono tutti gli autori i cui contributi sono raccolti in questo nostro volume. Le ricadute positive riguarderebbe il protagonismo dei territori meridionali nella valorizzazione del ruolo che essi a fatica si stanno conquistando – anche per ragioni squisitamente geografiche e culturali – nei rapporti con i Paesi della sponda settentrionale dell’Africa. Ma riguarderebbero anche l’elaborazione di una vera strategia volta al superamento di quel dualismo Nord-Sud così duro a morire, a cominciare dalle infrastrutture per la mobilità e delle politiche economiche.
La Strategia Europea delle macroregioni può essere letta su due piani, uno di breve e medio periodo ed uno di lungo periodo. In quest’ultimo caso, in particolare, il punto di approdo sarebbe quello del superamento di un’Europa delle Nazioni a beneficio di un’Europa dei Popoli in prospettiva federalista. Un obiettivo difficile, questo, irto di ostacoli politici, tanto più in un’epoca, la nostra, dominata da “sovranismi” ed egoismi d’ogni genere.
Per questo, sono personalmente più propenso per obiettivi più di breve-medio periodo, forse più modesti ma indispensabili. Mi riferisco – come sostengo nel mio scritto contenuto nel volume – alla Macroregione del Mediterraneo occidentale intesa come spazio strategico e occasione di apprendimento organizzativo, per le istituzioni come per le comunità coinvolte, nel recepire quei mutamenti paradigmatici – di contenuto e di metodo – che contraddistinguono le migliori politiche europee di sviluppo locale. Apprendere tutto questo, farlo divenire un patrimonio comune dei territori che aderiscono alla Macroregione non ha solo un valore in sé in vista di politiche che possano realmente creare sviluppo, bensì significa anche porre su solide fondamenta anche quella prospettiva politica di più lungo periodo che punta all’Europa dei Popoli.
Pur muovendoci in questo percorso bottom-up, di democrazia partecipativa, non possiamo tuttavia tralasciare il fatto che l’istituzione della Macroregione richiede il coinvolgimento delle istituzioni amministrative, Regioni, Province, Città. E qui sorge il primo problema: la permanenza di un disegno istituzionale ancora fondato sulle Nazioni, ciascuna con un proprio assetto amministrativo e regolamentare che rende estremamente difficoltoso quel coordinamento e quella armonizzazione delle politiche più volte rivendicate nei documenti istitutivi delle macroregioni. Perché possano efficacemente funzionare come «spazi funzionali», l’istituzione della Macroregione necessita dunque di una chiara manifestazione di volontà e responsabilità politica, di un impegno non propagandistico bensì costantemente perseguito da parte degli esponenti politici chiamati a governare le Regioni, le Province, le Città, metropolitane e non, che ricadono nel territorio interessato dalla Macroregione del Mediterraneo occidentale.
La stessa volontà della politica è condizione indispensabile sotto il profilo tecnico procedurale. E questo, come insegna l’esperienza, costituisce un secondo problema. Sappiamo, infatti, che la materia dell’istituzione, prima, e del ciclo di vita, poi, delle macroregioni è regolata non da una normativa specifica, bensì da uno schema consuetudinario. Resta però il fatto che sia nella prima fase di questa “procedura” (la piena condivisione da parte degli attori territoriali circa le sfide comuni da affrontare e la strategia da adottare), sia nella seconda (quella delle relazioni inter-governative, orizzontali e verticali, sul piano degli organismi dell’Unione, prima in sede di Consiglio, e poi in sede di Commissione che avvia un ampio processo di consultazione con tutti gli attori territoriali che si conclude con l’adozione del Piano d’Azione e la redazione di una Comunicazione sulla Strategia della Macroregione che dovranno, infine, essere formalmente approvati dal Consiglio europeo. dei passi istituzionali da percorrere), sia, infine, nella terza fase (quella della attuazione della strategia macro-regionale attraverso l’espletamento di ruoli e compiti nel quadro dell’approccio della multi-level governance e della partnership pubblico-privata), fondamentale è la responsabilità delle istituzioni pubbliche (Regioni e Comuni, in primis).
Così stando le cose, in conclusione, la sfida che ci aspetta è quella di impedire il possibile “cortocircuito” tra l’approccio place-based e la tradizionale pervasività della politica (meridionale), con il suo corredo (sempre dietro l’angolo) di disattenzione e paralisi decisionale.