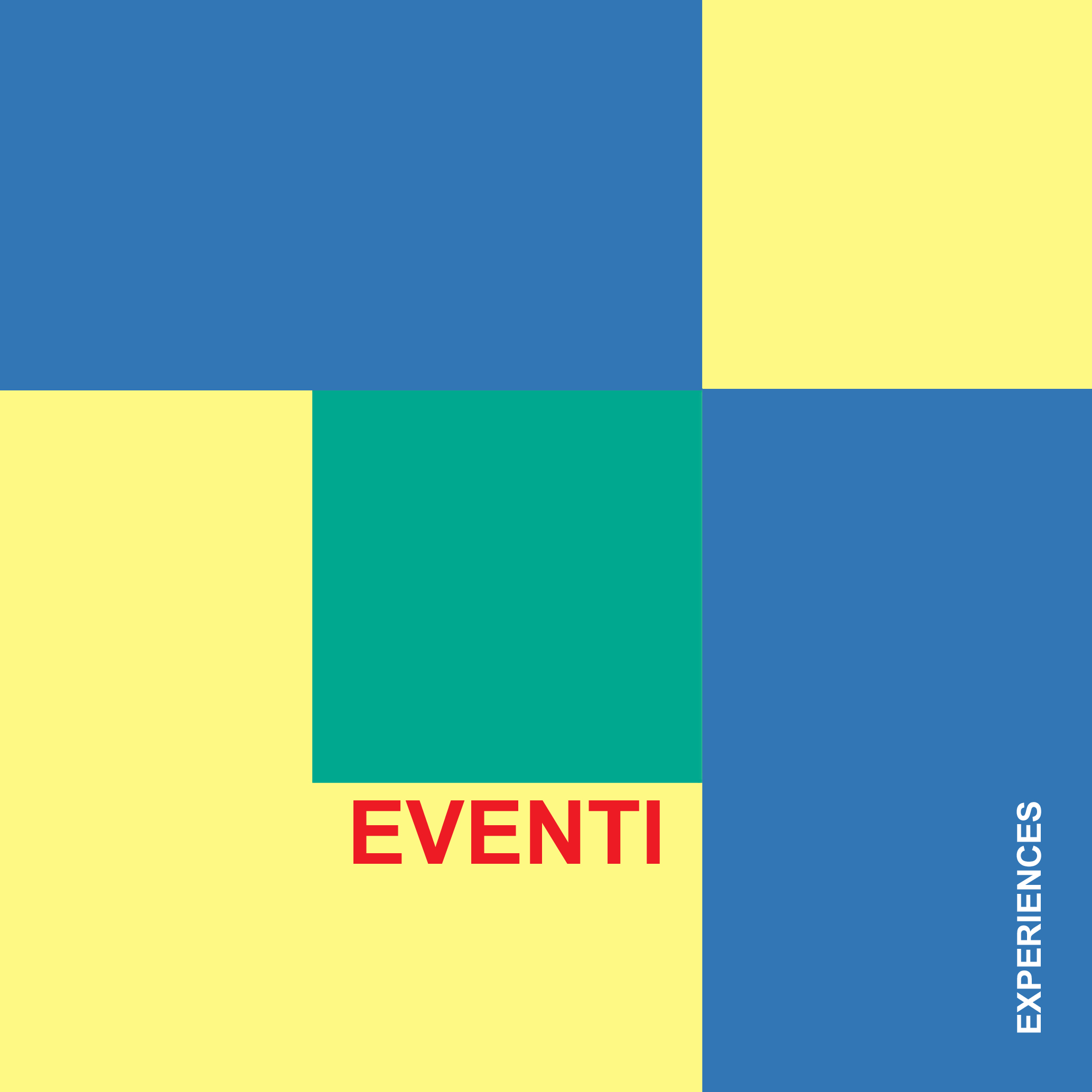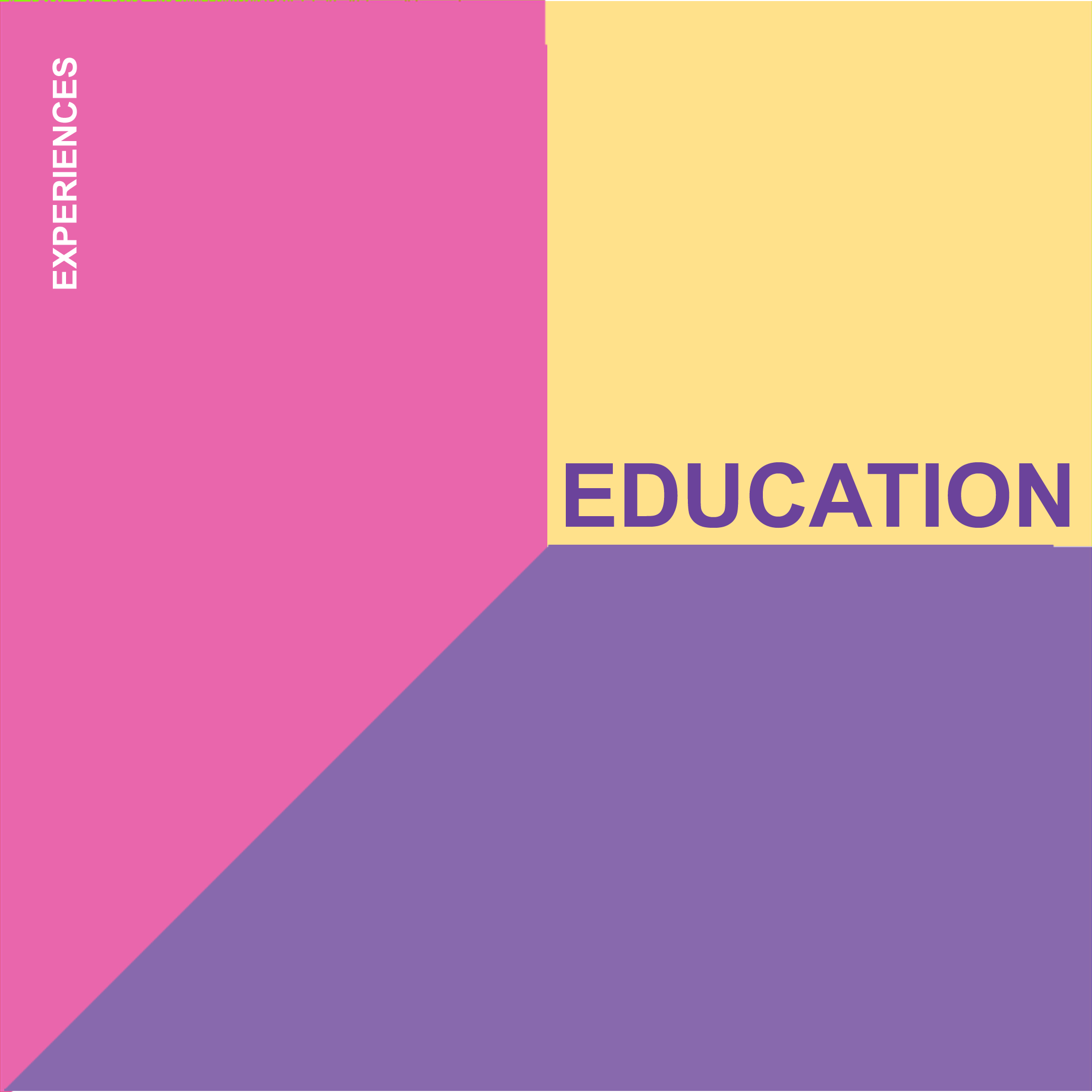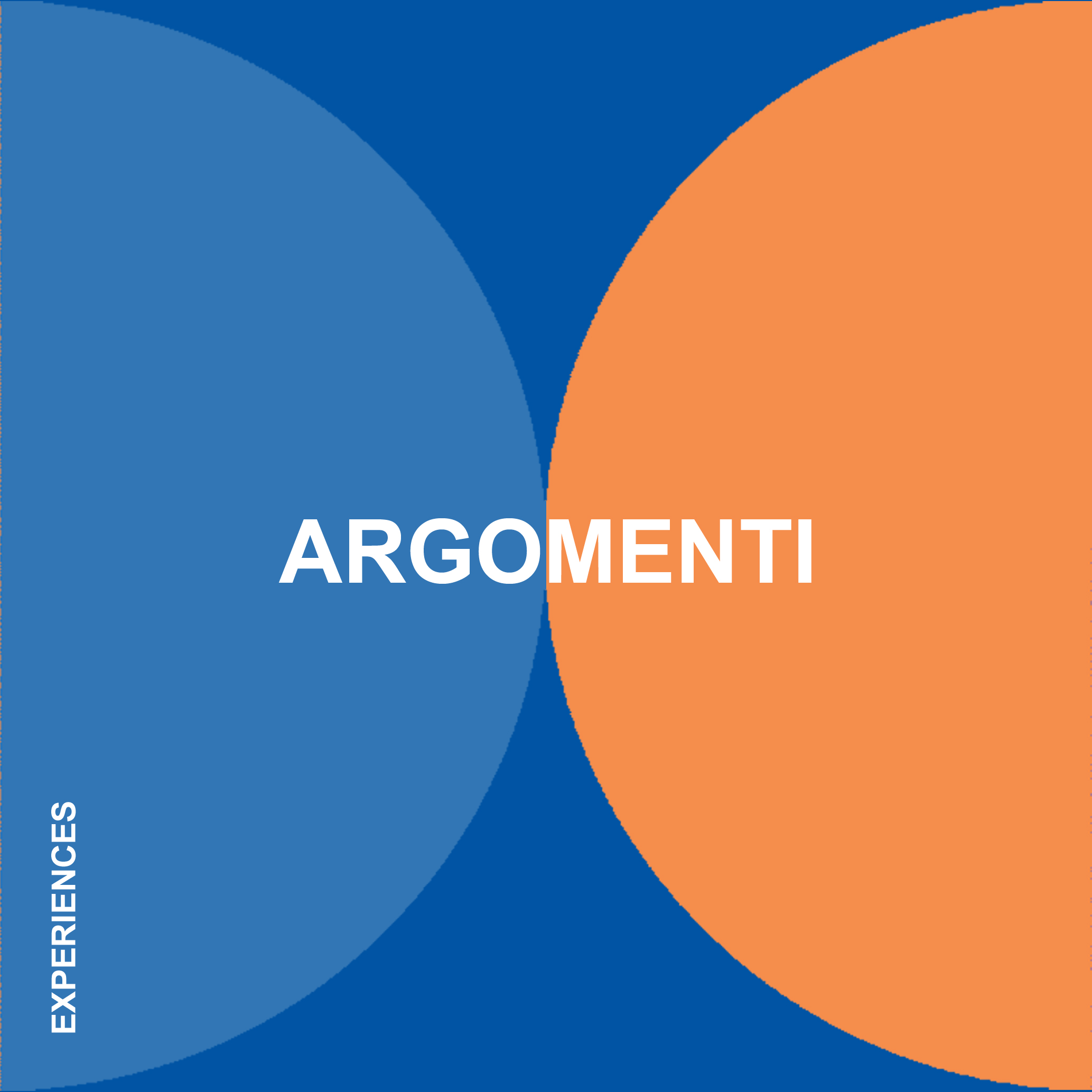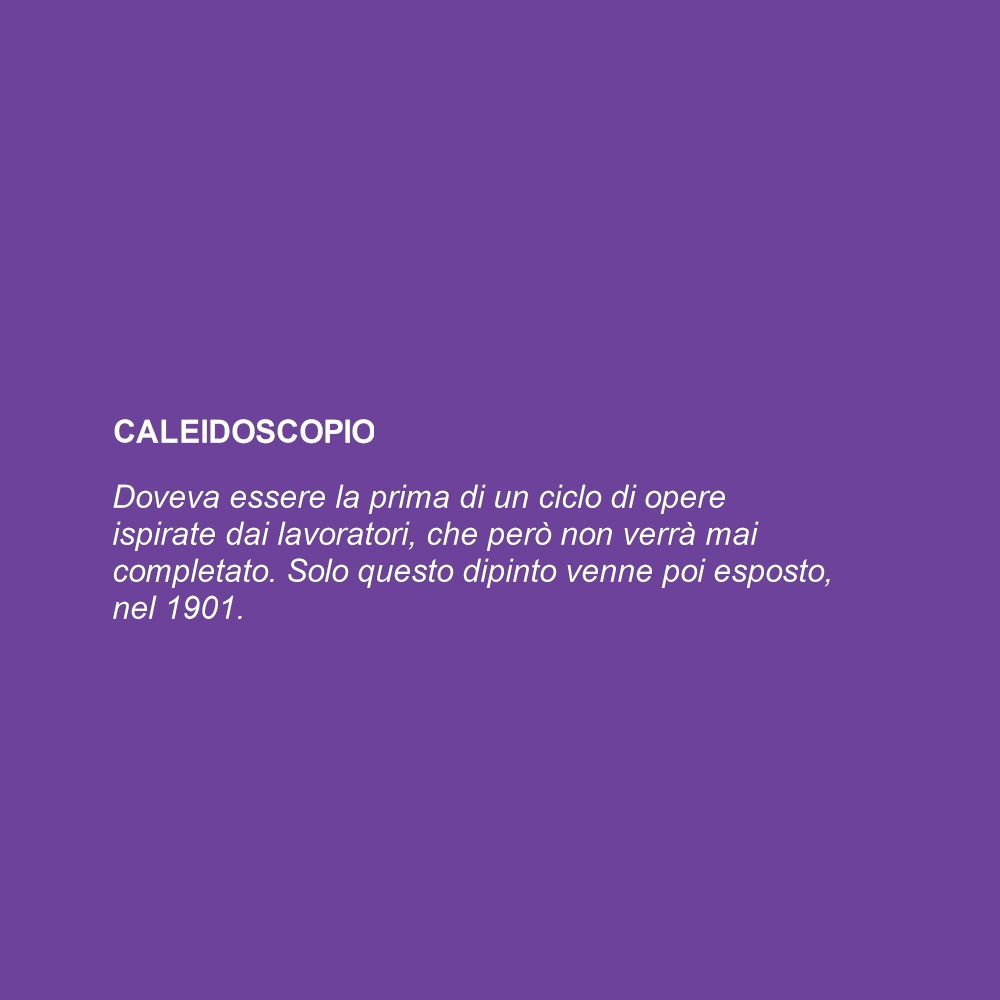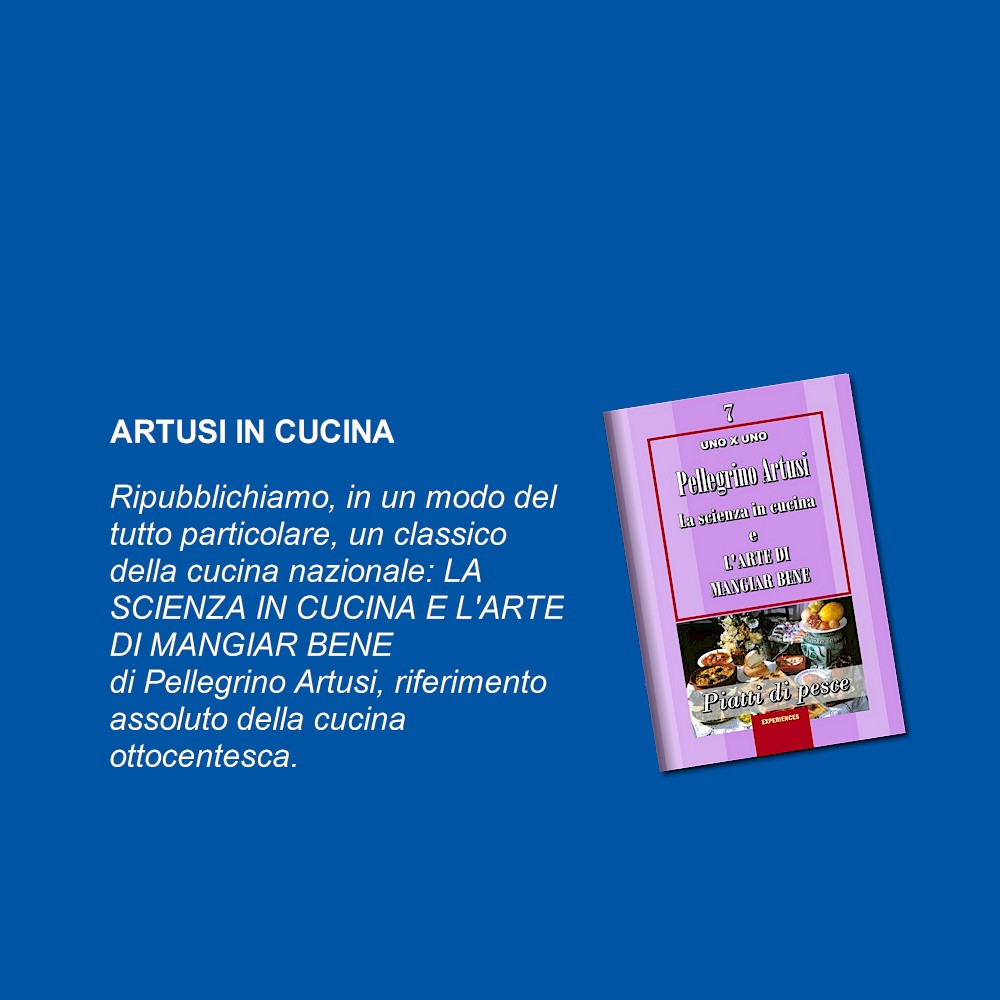Ma chi era il pastaio? Non vi è un profilo unico, date le differenze tra città, regolamenti e leggi, senza contare il tipo diverso di specialità e formati prodotti dal singolo imprenditore. Persino nella stessa corporazione troviamo delle differenze. Tratte dai documenti, vi sono diverse storie di pastai. Tanto per cominciare, si rilevano differenze societarie e tipologie di accordo.

Siamo nel 1620, il pastaio Domenico Russo si mette in società col mugnaio Stefano de Agnino, abitanti ambedue ad Avellino. Il primo mette in comune le sue capacità di confezionare la pasta, mentre il secondo fornisce 100 tomoli di grano, unitamente ai capitali necessari a stipendiare alcuni operai e apprendisti, oltre le eventuali altre spese. Si fa, naturalmente, affidamento sulle vendite, per rientrare nei costi ed ottenere il guadagno da dividersi in parti uguali.
Nel 1636, troviamo, invece, la figura nota dell’imprenditore, Felice Vigilante, che investe sull’attività del pastaio, per aumentare il suo capitale. Finanzia la spesa dell’affitto dei locali, posti in piazza Mercato a Napoli, l’acquisto della strumentazione e quello delle materie prime, mentre, un suo parente, Aniello Vigilante, si occupa del restante: cioè la gestione del negozio e della produzione della pasta. Anche qui il guadagno sarà spartito al cinquanta per cento. L’imprenditore, Felice Vigilante, aprirà in seguito un’altra bottega di pasta a Napoli, con la stessa procedura.
Altri tipi di società caratterizzano l’attività, come l’associazione societaria tra mugnai, panettieri e vermicellari. Società a volte non permesse dagli statuti della corporazione a cui si era iscritti.
Ad esempio, a Napoli, due vermicellari e un mugnaio si accordano per la fabbricazione della pasta. Il mugnaio, però, si riserva una parte dei locali per la produzione e la vendita del pane. Questa commistione, in realtà, era malvista dall’ordine dei Panettieri e, se venne tollerata, fu solo per l’autorità raggiunta in città dall’Arte dei Vermicellari.