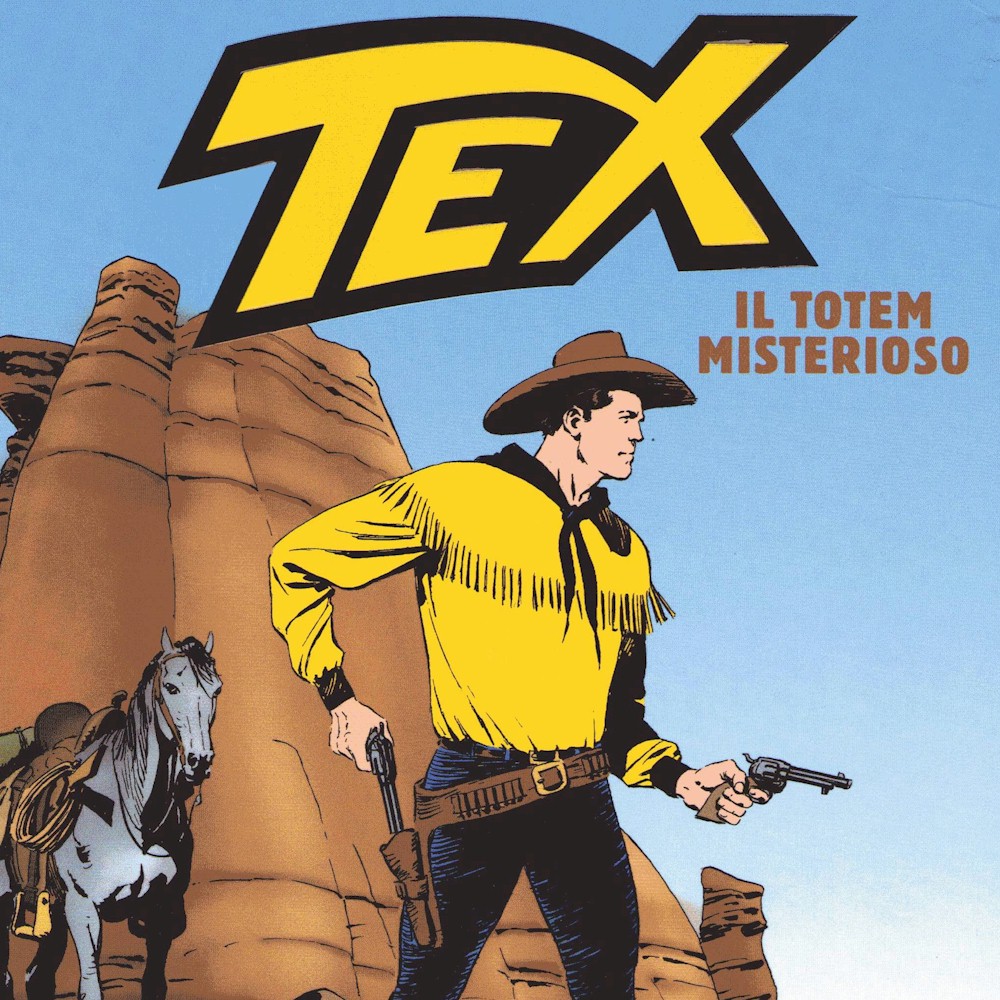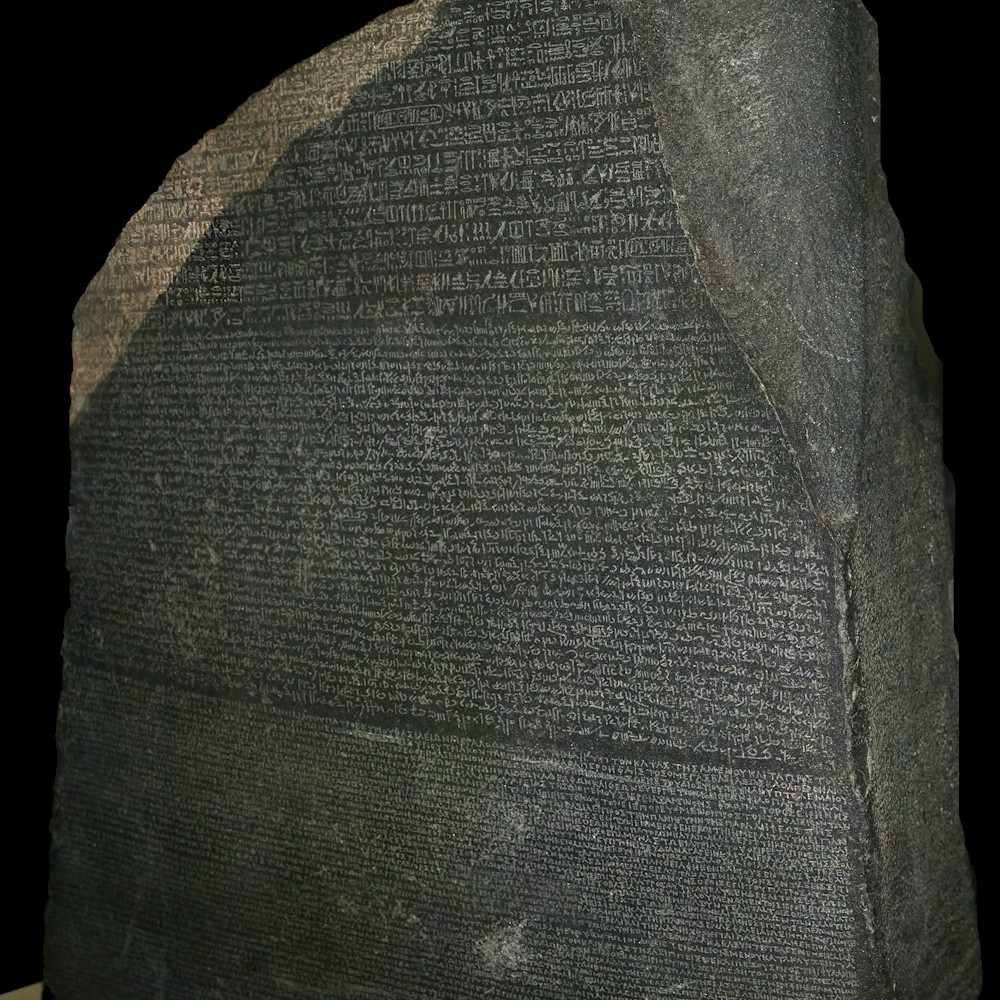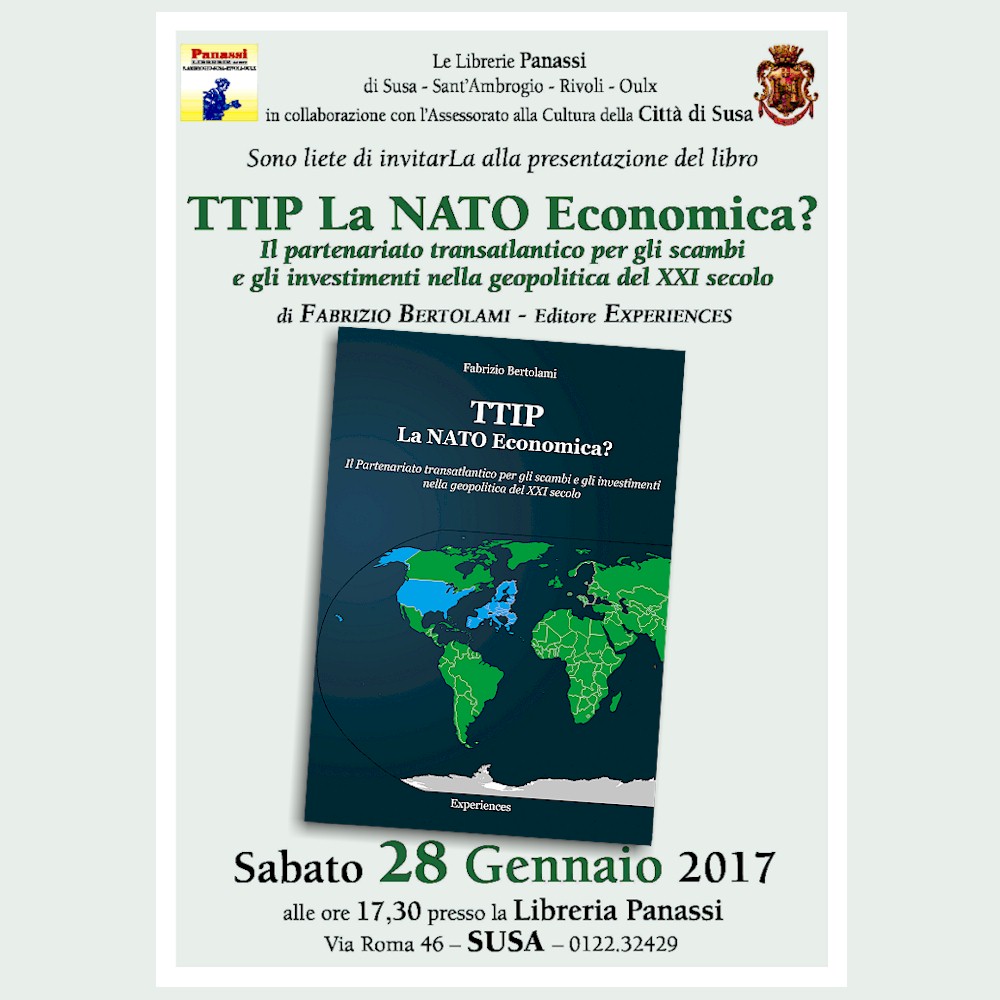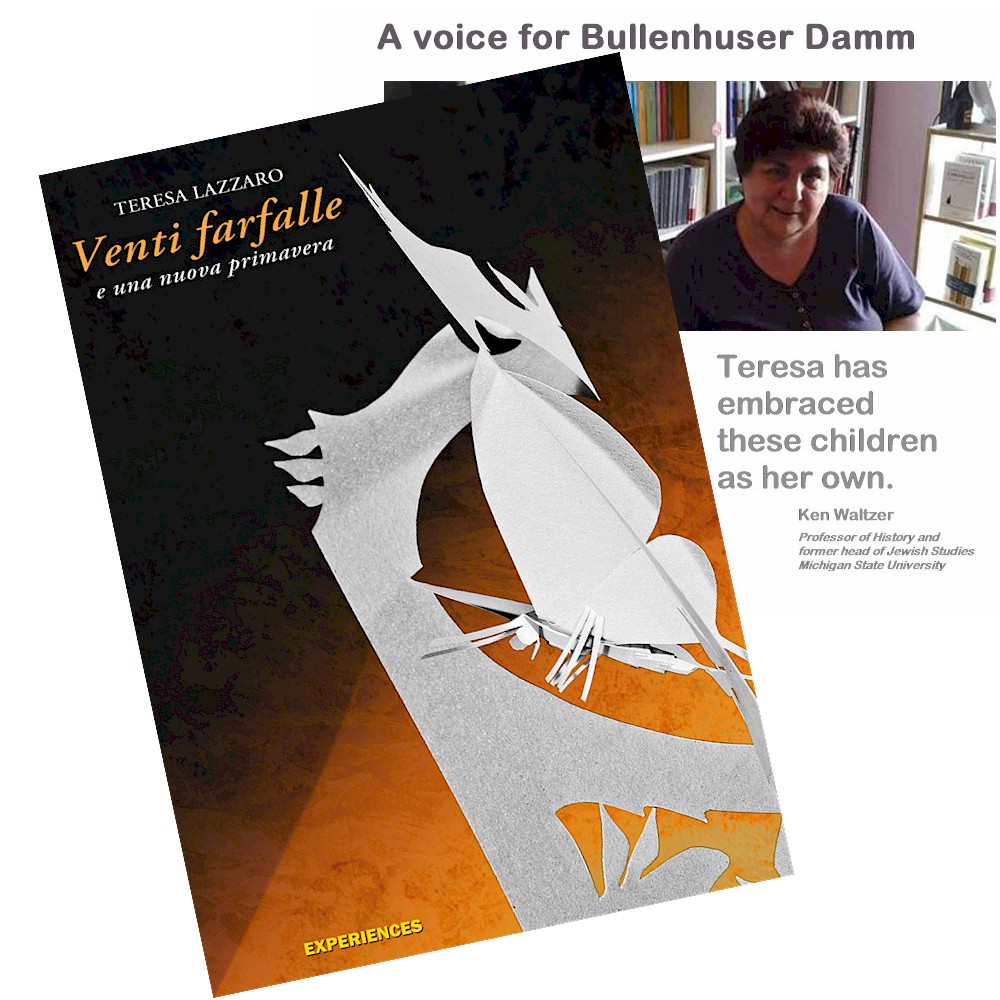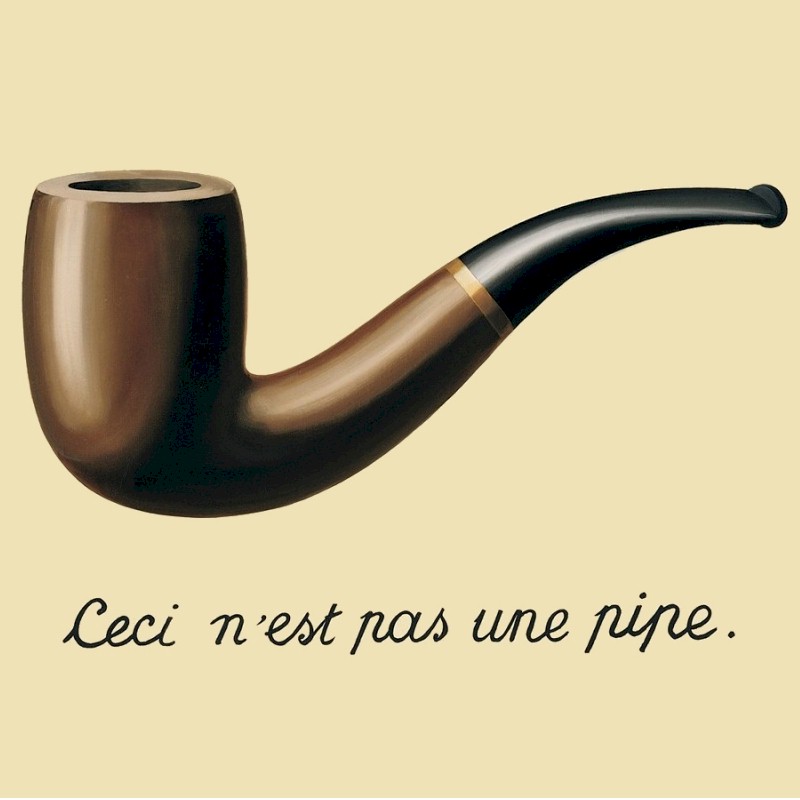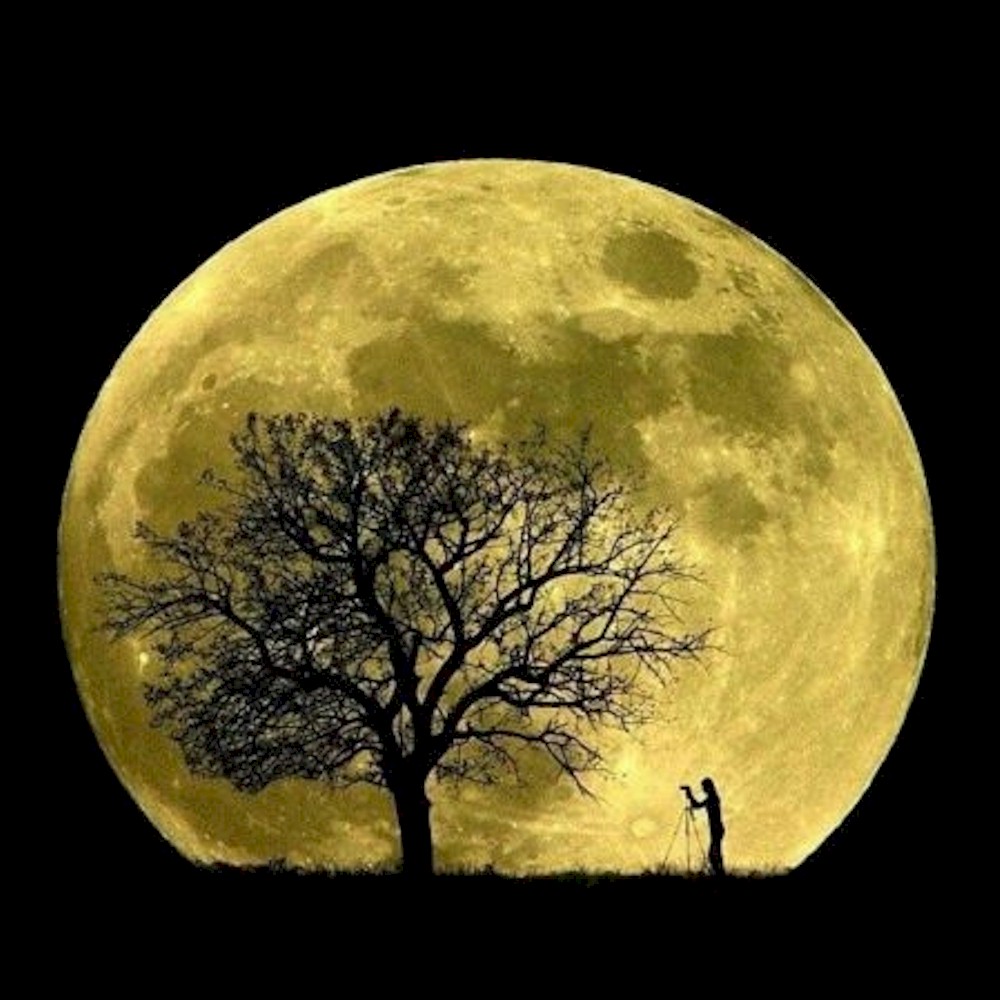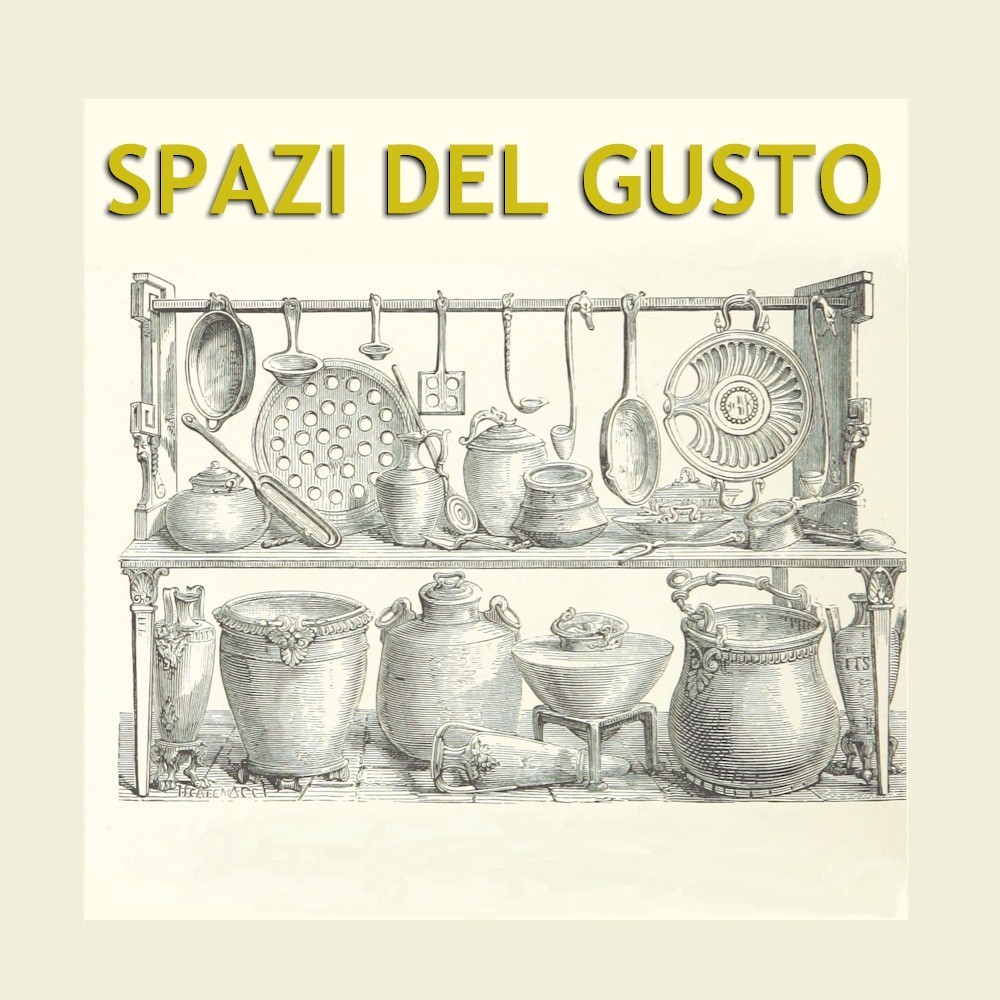Sergio Bonelli Editore, la più importante casa editrice italiana nel campo dei fumetti, fu fondata da Giovanni Luigi Bonelli (detto anche Gian). Questi era il fumettista, che, insieme ad Aurelio Galleppini, diede vita ai fortunati album di Tex Willer. Bonelli, nato a Milano nel 1908, verso la fine degli anni ’20, inizia la sua carriera collaborando con il Corriere dei Piccoli, dove pubblica alcune poesie e tre racconti: Le Tigri dell’Atlantico, Il Crociato Nero e I Fratelli del Silenzio. Subito dopo, negli anni ’30, lavora per diverse case editrici, anche di fumetti. Collabora con la Società Anonima Editrice Vecchi (S.A.E.V.) di Lotario Vecchi e per la Casa Editrice Nerbini. Quest’ultima gestisce le due testate per ragazzi: L’Audace e L’Avventuroso. Per esse scrive sceneggiature (come quella di Rintintin). Nel 1940, Bonelli fa “il grande salto” acquisendo i diritti dell’Audace e dando vita alla sua casa editrice. Prima con il nome della moglie Tea, poi del figlio Sergio e, successivamente, del nipote Davide. Oggi è conosciuta come Sergio Bonelli Editore.
Nel secondo dopoguerra l’Italia comincia la sua ricostruzione. Bonelli dà vita nel 1948 a due nuovi fumetti: Il Giustiziere del West (con disegni di Giorgio Scudellari) e la Pattuglia dei Senza Paura (con disegni di Guido Zamperoni e Franco Donatelli). Contemporaneamente, con il fumettista Aurelio Galleppini (pseudonimo Galep), crea altri personaggi e storie: Occhio Cupo (in formato ad albo) e Tex Willer. Invero, il successo del secondo personaggio sorprende, avendo puntato di più sul primo. Gian Luigi Bonelli è un uomo vulcanico ed instancabile. La sua casa editrice non si ferma a Tex, anche se di enorme successo, ma dà vita (su sceneggiature sue) a moltissimi personaggi per fumetti, come: Plutos nel 1949 (disegni di Leone Cimpellin), Yuma Kid nel 1954 (disegni di Mario Uggeri), Davy Crockettnel nel 1956 (disegni di Renzo Calegari e Carlo Porciani), e Hondo nel 1957 (disegni di Franco Bignotti).
Come romanziere scrive anche un libro Il massacro di Goldena (nel 1951), dove il protagonista è lo stesso Tex Willer. In seguito, come scrittore e sceneggiatore, redige testi per personaggi ideati da Guido Nolitta (nom de plume) o su ideazione del figlio Sergio, quali Un Ragazzo nel Far West, Zagor e l’episodio conclusivo di Il Giudice Bean. Nel 1991, Bonelli scrive la sua ultima storia della serie di Tex (con disegni di Guglielmo Letteri), già in gran parte passata a Claudio Nizzi. Riserva per sé soltanto la supervisione delle storie, cosa che farà fino alla morte, avvenuta nel 2001.
L’attività di Gian Luigi Bonelli, come scrittore e sceneggiatore, ha particolari riferimenti e modalità. I suoi autori preferiti erano proprio quelli del romanzo avventuroso d’appendice di fine Ottocento e primi del Novecento. Tra questi i grandi Alexandre Dumas, Jack London, ed Emilio Salgari. Infatti, egli si definirà sempre un “romanziere prestato al fumetto”. Con modernità Bonelli trasferiva i suoi copioni ai disegnatori attraverso “sceneggiature disegnate”. Erano veri e propri storyboard. Elaborava, cioè, testi accompagnati da schizzi della scena che occorreva disegnare e con il taglio dell’inquadratura da considerare per ogni singola scena. Un “plus” abbastanza significativo.