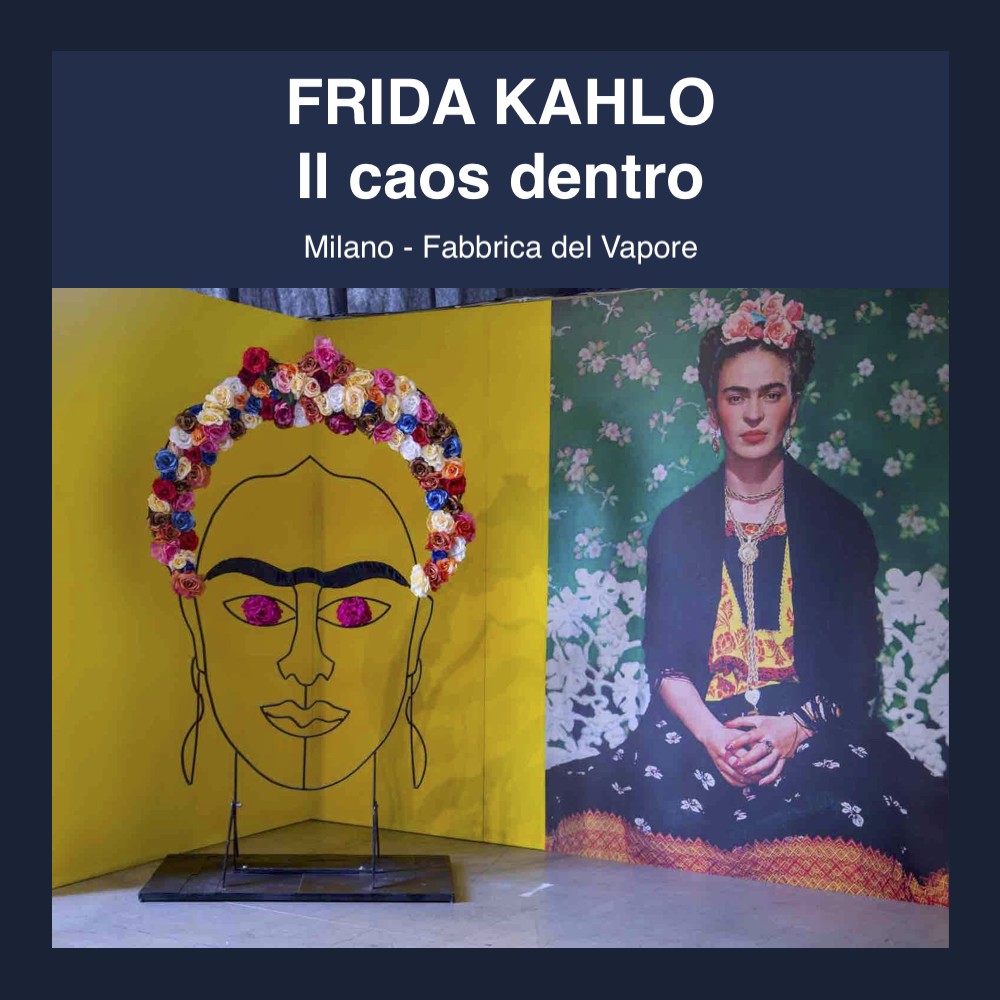di Sergio Bertolami
20 – Il ruolo di Bing a sostegno delle arti applicate
Ho parlato di Arthur Lasenby Liberty e non posso trascurare Siegfried Bing. A cercare due notizie su di lui, troverete che era un mercante di nascita tedesca, un editore ed anche un mecenate. Proveniva da una ricca famiglia ebrea di Amburgo. Suo padre era da principio un decoratore di ceramiche, poi divenne anche produttore. Suo figlio, Marcel Bing, un talentuoso disegnatore di gioielli in stile Art Nouveau. Troverete anche che il grande successo di Bing fu aprire un negozio di artigianato orientale a Parigi alla fine degli anni Settanta del XIX secolo, che trasformò nel 1895, battezzandolo Art Nouveau. Con questo nome identificò una corrente artistica che oggi tutti conoscono. Pochi sanno, però, che dal momento della sua morte, a settembre del 1905, un velo oscurò ciò che era noto a molti fino a quel momento. Si tornò a parlare di lui solo quando negli anni Sessanta del Novecento un rinnovato interesse portò di nuovo all’attenzione le arti decorative e, con queste, soprattutto l’Art Nouveau. Questo protagonista eccellente era talmente uscito di scena, che qualcuno, leggendo “S. Bing”, confuse persino il suo nome di battesimo Siegfried con Samuel. Mi piacerebbe soffermarmi a lungo sulla sua figura; come, ad esempio, avrei preferito non essermi limitato a qualche accenno su Paul Cassirer e suo cugino Bruno Cassirer, i quali come ricorderete promossero, con la propria galleria d’arte e la propria casa editrice, la Secessione di Berlino. Bing, tedesco come loro, mercante come loro, s’interessò a diffondere, invece, la sensibilità per un Oriente fino ad allora sconosciuto nella sua vera essenza. Dette vita alla fine del 1880 a un periodico mensile, Le Japon artistique, e organizzò una serie di mostre sull’arte giapponese, con ceramiche e stampe ukiyo-e. Chi, al suo tempo, parlava di Siegfried Bing lo descriveva come un apprezzato esteta; il suo atteggiamento rifletteva eleganza, cultura, capacità di appassionare ad esotici oggetti di qualità.
Julius Meier-Graefe, il noto critico tedesco – che quale amichevole concorrente tentò la strada del commercio, aprendo anche lui a Parigi La Maison Moderne, una galleria che esponeva opere Art Nouveau – scriveva di Bing: «Tutti pensavano alla sua figura delicata, con una mente da intellettuale parigino. Parlava e scriveva un francese classico, evitando tutte quelle frasi fiorite da boulevard. Aveva i modi educati di un marchese dei vecchi tempi, che trascorreva i momenti di libertà a caccia di bon mot nella sua biblioteca. Difficilmente gli si sarebbe attribuita l’eccezionale energia di un ricercatore, né tanto meno quella di un commerciante. Eppure, Bing era entrambe le cose. Ecco perché una parte sostanziale dell’inizio della conquista intellettuale del Giappone è dovuta a lui». Bing in verità era un uomo d’affari, ma colto e raffinato come pochi, soave e persuasivo verso i suoi clienti. Aveva compreso come per avere successo occorresse, anziché seguire l’opinione pubblica, allontanarsene quanto più possibile. L’arte giapponese fu lo stimolo creativo, oltre che commerciale, per Bing, ma anche per lo stesso Julius Meier-Graefe oppure – giusto per citarne uno solo – per Henri Vever, il più famoso gioielliere degli inizi del Novecento, che aveva un negozio proprio di fronte a quello di Bing. Utilizzando volantini che invitavano alle mostre, allestendo ambientazioni in stile che esponevano le preziose collezioni, diffondendo cataloghi ricchi di immagini, e tanti altri mezzi promozionali, come le pubbliche conferenze alla Japan Society di Londra di cui era socio, Siegfried Bing rese tangibile ai suoi contemporanei il nuovo gusto estetico che si stava diffondendo in Occidente. All’epoca in cui tutto questo si materializzò Bing aveva pochi concorrenti disposti ad investire la propria reputazione e una considerevole fortuna nella ricerca pioneristica di nuove forme d’arte. A Londra abbiamo seguito le “avventure” commerciali di William Morris o di Arthur Lasenby Liberty, ma fu il negozio di Bing a fare sprizzare il movimento Art Nouveau in ambito internazionale.
Naturalmente – come vale sempre per i visionari e i precursori – l’attività di Bing fu derisa dalla stampa francese, che chiedeva il motivo per cui non esibisse la produzione artistica europea anziché proporre l’arte esotica. Ma Bing era convinto, sapeva cosa fare, giacché nel commercio era cresciuto. Suo padre Jacob era comproprietario, con Samuel Joseph Renner, della Bing Gebrüder, un’azienda fondata ad Amburgo per importare porcellana e vetro francesi e che rimarrà attiva fino al 1888. I soci si erano divise le responsabilità: Renner operava ad Amburgo e Jacob a Parigi, a partire pressappoco dal 1850; per cui ben presto, finiti gli studi, i figli Siegfried, Michael e più tardi Auguste, raggiunsero la famiglia a Parigi ed entrarono in azienda. Nel 1854, Jacob acquistò una modesta manifattura a St. Genou, un piccolo centro della Valle della Loira, per la produzione di oggetti in porcellana, spinto dal rapido aumento del commercio import-export di articoli pregiati. Con l’acquisizione, arrivò anche un brevetto per la cottura della porcellana dura in un forno a carbone, innovazione particolarmente efficiente per i tempi, aumentando la produzione dell’azienda. Quando però nel 1863 le spese superarono le entrate, la manifattura fu venduta. Il venticinquenne Siegfried Bing rilevò gli interessi di famiglia e acquisì azioni della Leullier fils una nuova manifattura di porcellana operante nel mercato locale. Avrebbe rifornito il negozio di famiglia in rue Martel a Parigi, fiorente nella vendita di porcellane e vetri artistici ad una clientela benestante. Padre e fratelli continuarono a gestire il punto vendita, mentre Siegfried, con questo suo ingresso nella manifattura Leullier, intraprese la sua ascesa. La produzione industriale incrementò e si distinse, così da essere premiata alle Esposizioni per l’eccellenza artistica di alcune delle sue creazioni. Erano quelli gli anni del regime bonapartista di Napoleone III, la Francia competeva con altre nazioni europee, in particolar modo con l’Inghilterra, nella fabbricazione di articoli di lusso, rinomati per le qualità estetiche e l’alto valore commerciale. Leullier fils produceva e decorava servizi in porcellana, ma realizzava anche lampadari e altri complementi d’arredamento per impreziosire le abitazioni di una borghesia rampante. Un set da tavola vinse persino una medaglia all’Esposizione Universale di Parigi del 1867. A maggio 1868 Jacob Bing morì, ma come da calendario a luglio Siegfried sposò Johanna Baer, una cugina di terzo grado, di famiglia ricca, colta e ben consolidata ad Amburgo. La coppia si trasferì a Parigi, al 31 di rue de Dunkerque, in prossimità degli uffici Leullier.

Tuttavia, la stagione propizia era al volgere. Le nubi avverse delle crisi finanziarie del Secondo Impero e soprattutto la guerra franco-prussiana (1870-1871) avrebbero potuto rovesciare le fortune di Bing, per via della sua origine tedesca e degli stretti legami familiari con la Germania. Tuttavia, grazie all’abilità d’imprenditore, nonostante le avversità riuscì a rafforzare la propria immagine. Dopo avere trascorso a Bruxelles il periodo del pesante assedio prussiano di Parigi, Bing rientrando nella capitale dopo la resa trovò la Leullier in scompiglio. La maggior parte dei suoi dipendenti arruolati nell’esercito e il commercio delle arti decorative completamente crollato. Con una città prostrata dai lutti e dalla fame, caseggiati distrutti dai cannoneggiamenti, le persone erano preoccupate della sussistenza piuttosto che del lusso. Come se non bastasse la tragedia colpì la famiglia Bing. Il fratello di Siegfried, Michael, morì a febbraio del 1873 e il terzogenito della coppia, nato a maggio, morì due mesi dopo. Come può accadere nei momenti di crisi, c’è chi si lascia abbattere e chi invece trova la forza morale di affrontare e capovolgere la realtà. Bing, per primo, s’impegnò a mantenere attiva la manifattura di porcellana, evitando licenziamenti e stabilendo relazioni con diversi importatori stranieri. Quindi, richiese ed ottenne la cittadinanza francese. Era un passo dovuto. Non doveva essere facile per un imprenditore tedesco riavviare l’attività commerciale in una città straziata dalla guerra contro i prussiani. Nella sua domanda di naturalizzazione del 1876 si presentava come un candidato devoto alla Francia quale paese di adozione; di nascita tedesca, ma residente in terra francese da ventidue anni ininterrotti; senza alcun coinvolgimento in politica, ma interessato soltanto agli affari e alla famiglia, senza interessi diretti nel suo paese d’origine. Nonostante tutto, la Bing Gebrüder era ancora attiva e alla morte di Michael l’intera gestione ricadde su Siegfried, l’unico della famiglia Bing a trovarsi stabilmente in Francia.

È precisamente in questi anni che Siegfried Bing cominciò ad interessarsi di arte orientale e a collezionare oggetti ceramici di raffinata fattura. Dal momento che era pur sempre un uomo d’affari, con una forte propensione per le arti decorative, si può dire che seppe fiutare il mercato che lo indirizzava quasi naturalmente a soddisfare la mania dei parigini per le curiosità giapponesi. Questo, almeno, è quanto si legge riguardo ad un uomo particolarmente riservato. Scrive Gabriel P. Weisberg, il suo maggiore biografo: «Sempre discreto, Bing era piuttosto ossessivo riguardo alla decisione di nascondere la propria identità; solo poche persone conoscevano le sue collezioni private, e ancor meno sapevano qualcosa della sua vita personale. Per lui, l’opera d’arte che difendeva – fosse giapponese o, più tardi, una sua versione Art Nouveau – era la sola cosa più importante; il suo ego, e la vita, dovevano essere sublimati, addirittura eliminati». Ci sono, tuttavia, alcuni fatti particolari che vanno presi in considerazione. A partire dal 1870 il cognato di Bing, Martin Michael Bair, ricoprì per due mandati (1870-74 e 1877-81) l’incarico di console a Tokyo. La sua posizione gli permetteva di intrattenere rapporti con l’alta società giapponese e apprezzare le migliori raccolte d’arte private. Da buon collezionista, acquistò articoli selezionati, non solo per sé stesso, ma anche per Bing. Nella sua qualità favorì lo sviluppo di relazioni commerciali, come nel caso della Ahrens and Company, società di import-export, che aveva uffici a Yokohama, Tokyo e Londra. Fatto sta che nel 1874 Siegfried Bing era già diventato un collezionista abbastanza conosciuto da essere invitato a unirsi alla Società dell’Asia orientale di Tokyo. Nel marzo del 1876 organizzò, inoltre, la sua prima esposizione pubblica all’Hotel Drouot, la più grande casa d’aste parigina, nota per le belle arti, l’antiquariato e le antichità. La vendita gli fruttò oltre 11.000 franchi, e questo suggerisce che all’epoca avesse già raccolto una buona collezione di oggetti esotici da proporre alla sua platea di acquirenti. «Questa vendita – annota Gabriel P. Weisberg – presentò anche il primo record del suo pubblico coinvolgimento in questo mercato».
La mania viscerale dei parigini per l’arte giapponese trovò ampio sfogo due anni dopo, in occasione dell’Esposizione Universale di Parigi del 1878. L’enorme padiglione giapponese ospitò, nel corso dell’evento, campioni e dimostrazioni pratiche riguardanti l’arte e l’industria. I numerosi visitatori furono avvinti dagli aspetti della vita e della cultura del Sol Levante, resi espliciti da una dovizia di notizie su ogni luogo specifico e su ogni tecnica adottata dagli artisti e dagli artigiani, che fosse ceramica o bronzo. Siegfried Bing, naturalmente, non si lasciò sfuggire l’occasione, perché programmò l’apertura del suo nuovo negozio, al 19 di rue Chauchat, in coincidenza con l’apertura dell’Esposizione e del suo ricercatissimo padiglione giapponese. Non è necessario rimarcare che ebbe un grande successo, tanto da ripagare l’investimento iniziale e permettergli nel giro di quattro anni di acquistare definitivamente i locali. Era giunto ormai il tempo per Siegfried Bing di stabilire legami diretti con i giapponesi e organizzare il suo primo viaggio in Estremo Oriente, che immancabilmente ebbe luogo nel 1880.
IMMAGINE DI APERTURA – L’orologio al Musée D’Orsay – Foto di Guy Dugas da Pixabay