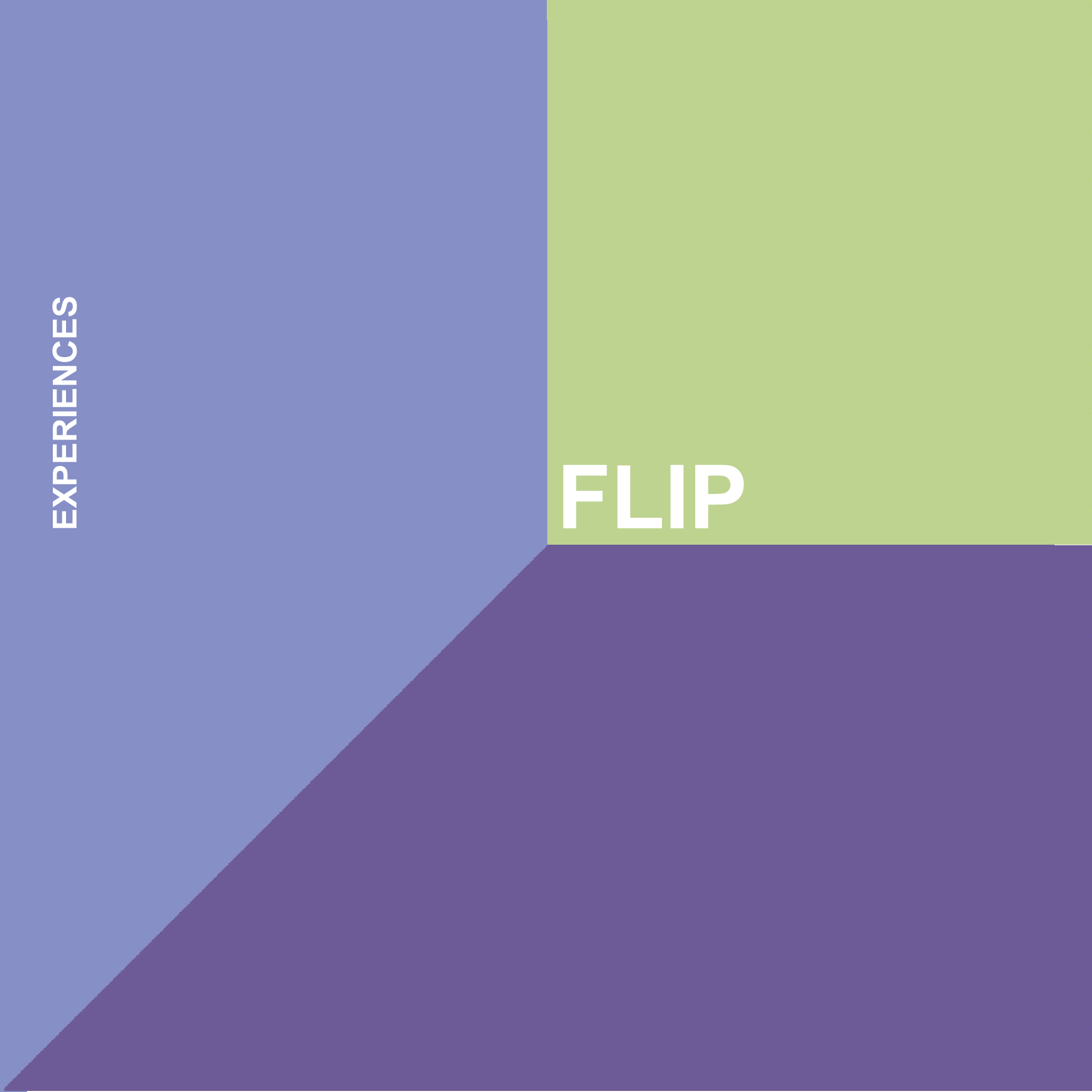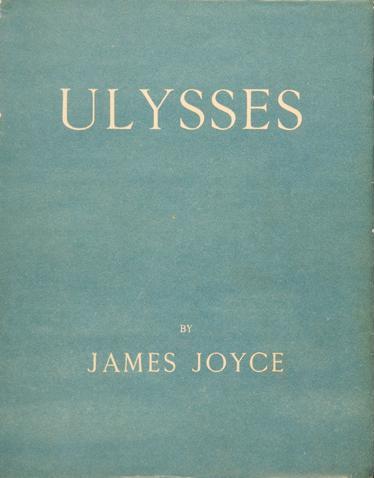Il 19 giugno del 1885 la Statua della Libertà, la scultura colossale ideata e realizzata da Auguste Bartholdi con l’ausilio dell’ingegnere Gustave Eiffel, che ne ha progettato la struttura reticolare interna in acciaio, sbarca a New York. La fregata Isère è accolta dai colpi augurali dell’artiglieria e dagli applausi di una traboccante folla festante che assiepa il molo. È solo il primo carico dell’opera costruita a Parigi, che giunge in America sezionata. Dalla capitale ha viaggiato su rotaia fino al porto di Rouen, poi imbarcata sull’Isère ha attraversato l’Atlantico. A bordo la coppia Bartholdi e la coppia Gaget, in rappresentanza delle officine Gaget e Gauthier che hanno materialmente realizzato l’ambizioso progetto. Un articolo pubblicato su Le Figaro l’8 luglio 1885, intitolato “Figaro in America”, restituisce ai parigini il clima di entusiasmo all’arrivo della statua di Bartholdi. La folla applaude e intona il ritornello della Marsigliese. Le vie sono decorate ovunque col tricolore francese. Bartholdi è l’eroe del giorno. Gli abitanti non sanno più come esprimere la loro gioia da quando hanno saputo che saranno sbarcate trecento casse contenenti i primi pezzi della famosa statua, già battezzata “La Libertà che illumina il mondo”. La voce che si rincorre di bocca in bocca è una sola: quando la statua apparirà completata sull’isola di Bedloe, e la sua torcia risplenderà nel porto di New York, l’effetto sarà magico.
Per vederla così, scrive il corrispondente da New York, ci vorrà un po’ di pazienza; e questo lo fa stare male. Per montare la statua occorrerà, infatti, costruire un piedistallo degno del lavoro artistico. Sebbene il finanziamento della statua e le spese di viaggio siano a carico dei francesi, l’astronomico costo dell’assemblaggio dovrà essere sopportato dagli americani. Occorre anzitutto finanziare l’immenso piedistallo, per il quale non sono stati raccolti in tempo i fondi necessari. I giornali additano il governo degli Stati Uniti, che non vuole impegnarsi. Ma, in realtà, il progetto franco-americano è un’opera privata. Le Figaro del 7 aprile 1885 spiega ai suoi lettori che il Congresso ha accettato il dono della statua con riferimento alla legge del 22 febbraio 1877, che prevede soltanto «le spese per l’inaugurazione e il mantenimento del monumento in una destinazione ben precisa», che è quella di faro elettrico. Gli americani hanno costituito un fondo, sostenuto dai giornali, per finanziare l’opera, che si prevede di completare in due o tre anni. Di fronte all’iniziale riluttanza è, infatti, il magnate Joseph Pulitzer a lanciare una grande campagna di abbonamenti dalle colonne del suo quotidiano “The World”. Sollecita l’orgoglio nazionale.
Per il momento, comunque, l’attenzione è tutta rivolta ai festeggiamenti. Ufficiali ed equipaggio dell’Isère, conserveranno un ricordo eccellente dell’accoglienza riservata loro. Dall’arrivo a New York, è un susseguirsi di banchetti, sfilate, presentazioni. Con un pizzico di polemica il corrispondente del quotidiano parigino informa che proprio nel momento in cui la fregata Isère era in procinto di attraccare in porto, il console generale francese a New York, Monsieur Lefaivre, è dovuto partire; ma fortunatamente è stato sostituito dall’eccellente console francese a Chicago, Monsieur Bruwaert. Ora bisognerà attendere che dall’Isère le trecento enormi casse, nelle quali hanno viaggiato impacchettati i pezzi della gigantesca statua, siano scaricati. Rimarranno smantellati e conservati sull’isola di Bedloe fino al completamento dei lavori. Nel frattempo, i festeggiamenti si trasferiscono a Washington dove gli uomini dell’Isère renderanno omaggio al Presidente della Repubblica Grover Cleveland (1837-1908). Da allora, la Statua della Libertà è il simbolo universale dell’emancipazione dall’oppressione, rappresentata dalle catene spezzate della schiavitù che si trovano ai suoi piedi. Nel 1927, il monumento è stato dichiarato monumento nazionale dagli Stati Uniti e dal 1984 è stato inserito dall’UNESCO nel patrimonio dell’umanità. Il suo faro di civiltà ha continuato ad accogliere milioni di immigrati, come già avveniva dall’inizio del secolo XIX, contribuendo all’essenza democratica e multietnica del popolo statunitense.
LEGGI L’ARTICOLO SU LE FIGARO: 17 juin 1885, la Statue de la Liberté débarque à New York
LEGGI LA SCHEDA NELLA WORLD HERITAGE LIST: Statue of Liberty
LA STATUA DELLA LIBERTÀ (Statue of Liberty), inaugurata nel 1886, è un monumento simbolo di New York e degli interi Stati Uniti d’America, uno dei monumenti più importanti e conosciuti al mondo. Situata all’entrata del porto sul fiume Hudson al centro della baia di Manhattan, sulla rocciosa Liberty Island. Il nome dell’opera è La Libertà che illumina il mondo (Liberty Enlightening the World in inglese, La Liberté éclairant le monde in francese). Fu realizzata dal francese Frédéric Auguste Bartholdi, con la collaborazione di Gustave Eiffel, che ne progettò gli interni; la statua è costituita da una struttura reticolare interna in acciaio e all’esterno rivestita da 300 fogli di rame sagomati e rivettati insieme, poggia su un basamento granitico grigio-rosa che si è a lungo pensato fosse di provenienza sarda[1], benché recenti ricerche abbiano smentito la provenienza della roccia dall’isola della Maddalena e l’abbiano ricondotta alla cava di Stony Creecy nel Connecticut. (Da Wikipedia, l’enciclopedia libera).