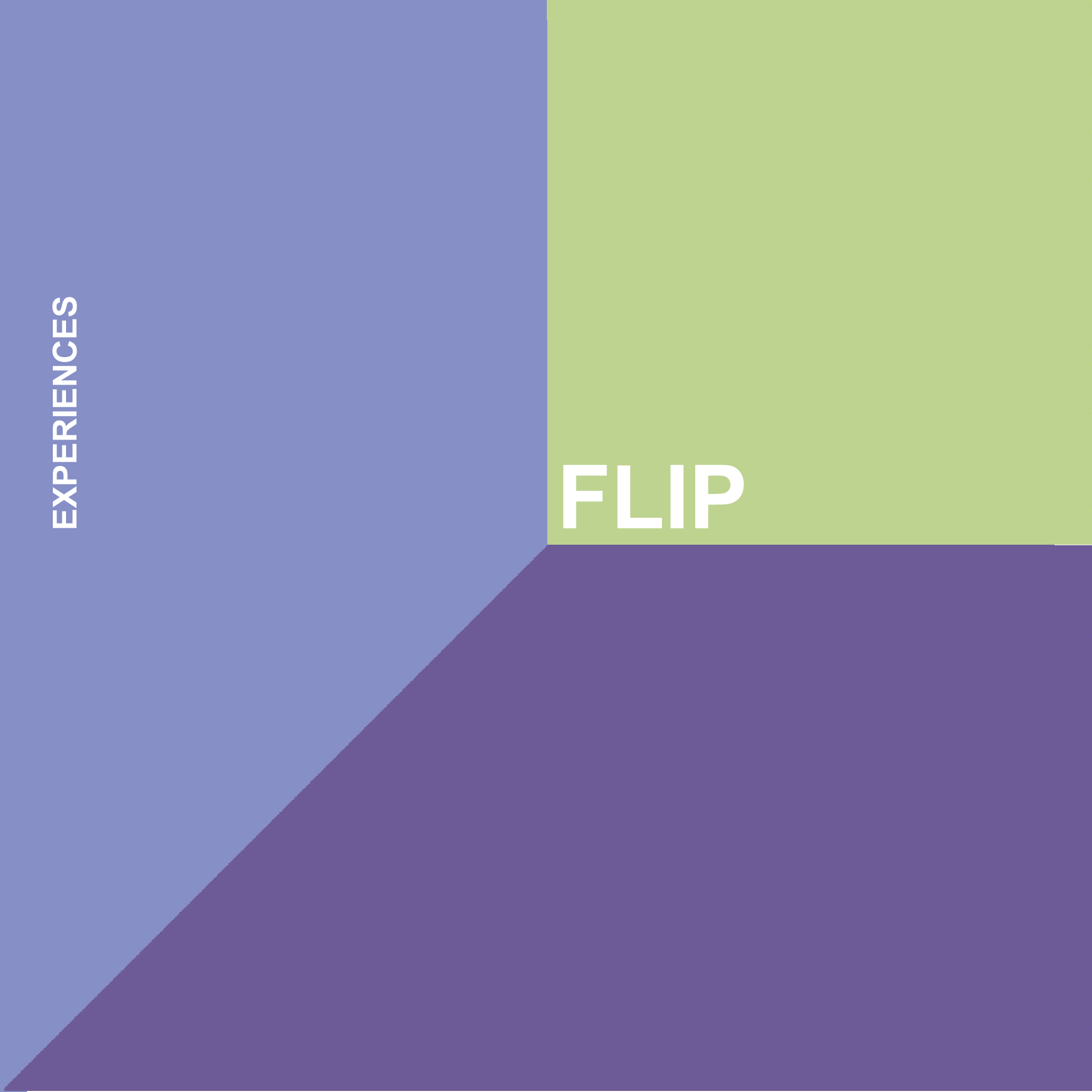La pasta, nel periodo medievale, era cotta principalmente nel brodo, che poteva essere di cappone o di carne. Sembra che in periodo quaresimale fosse cotta direttamente in acqua. Esistono documenti che ci parlano di pasta cotta nel latte. Si evidenziano, infatti, i “vermicelli cum lacte”. La pasta si immergeva, anche allora, quando l’acqua era in fase di ebollizione. Ma è sui tempi di cottura che i dati non tornano. Alcuni manoscritti parlano di un’ora di cottura, altri di due ore. È d’obbligo diffidare di queste informazioni. Infatti, per quanto riguarda la pasta ripiena i dati cambiano. Martino consiglia di bollirli per il tempo necessario per dire due paternostri (altri quattro). I ravioli vanno cotti, comunque, lentamente, affinché non si rompano. La rapidità era consigliata per i ravioli “ignudi”. Il testo di Martino, con i dati riferiti, ci conferma la sua abilità e, soprattutto, il controllo sapiente di tutte le fasi di lavorazione di una buona pasta ripiena.
I dati, se confermati, proverebbero l’ipotesi che, al tempo, la pasta veniva gustata molto cotta, cioè “fondente”, per eliminare l’amido che conteneva. Un proverbio del tempo, infatti, recitava: “grosso come l’acqua dei maccheroni”. L’acqua di cottura, era senza sale, molta per quantità, torbida e collosa. A questo si aggiunge che all’epoca, grosso significava sciocco. Per cui il proverbio indicava una persona sciocca, che si lasciava abbindolare facilmente. Sembra che il significato del proverbio sia confermato nella Lettera in proverbi del Vignali, del 1557.
È comunque assodato che i tempi di cottura della pasta fossero lunghissimi. Il cuoco Martino suggeriva di cuocerla circa mezz’ora ”perché ogni pasta volle essere ben cotta”.
Questo accadeva, non solo per un problema di gusto, ma soprattutto, in campo medico. Si riteneva infatti che la pasta poco cotta procurasse costipazioni o la calcolosi renale. Un medico del XIII secolo, Arnaldi di Villanova, consigliava di “farla cuocere a lungo e servirla con molto latte di mandorle”. Tale modalità tecnica (della pasta scotta) rimase nell’usanza per alcuni secoli, per poi variare. Nei trattati di cucina del Rinascimento, la cottura non è precisata, ma dai testi si suppone sia la stessa del periodo medievale. Ma già Scappi, successivamente, consiglia mezz’ora (dimezzando i tempi) per una minestra di maccheroni alla romanesca. Terminata verrà posta sul piatto in tre strati, conditi con formaggio grattugiato, zucchero e cannella (quindi un gusto dolce). Dopo di ché, la pietanza andava stufata lentamente con il calore basso della cenere, per un’altra mezz’ora. Questa tecnica era utilizzata anche, nel XVII secolo, dai cuochi francesi.
La pasta “fondente”, cioè molto scotta, riportata anche da Romoli, inizia a variare con il XVII secolo, con una progressiva diminuzione dei tempi di cottura, allora così lunghi. Giovanni del Turco, musicista fiorentino, iniziò a rivedere le ricette del maestro Scappi. Parlando di cottura, il musicista, una volta cotta “a punto” la pasta, suggerisce di fermare l’ebollizione dell’acqua della pentola, con l’aggiunta di acqua fredda, per far rinvenire i maccheroni e renderli più corposi. Naturalmente, raccolse molte critiche dai grandi cuochi del tempo. La cottura della pasta, alla fine del XVII secolo, diventò una fase da migliorare. Gli chef si misero al lavoro, variando le modalità della cottura. Antonio Latini confeziona i suoi tagliolini di monica, cioè fatti nei conventi dalle suore. Sono cotti nel brodo, ma per breve tempo, essendo molto sottili. Nel Cuoco piemontese, libro del 1766, le tagliatelle fresche, invece, devono passare dall’acqua bollente velocemente all’acqua fredda. Condite con burro e formaggio grattugiato, indi gratinate al forno. Anche un altro cuoco, Francesco Chapusot, divide la cottura in due fasi. Per primo, le tagliatelle devono cuocere in acqua bollente, per 10 minuti circa, poi condite e, infine, mantecate sulla brace, per altri 10 minuti.