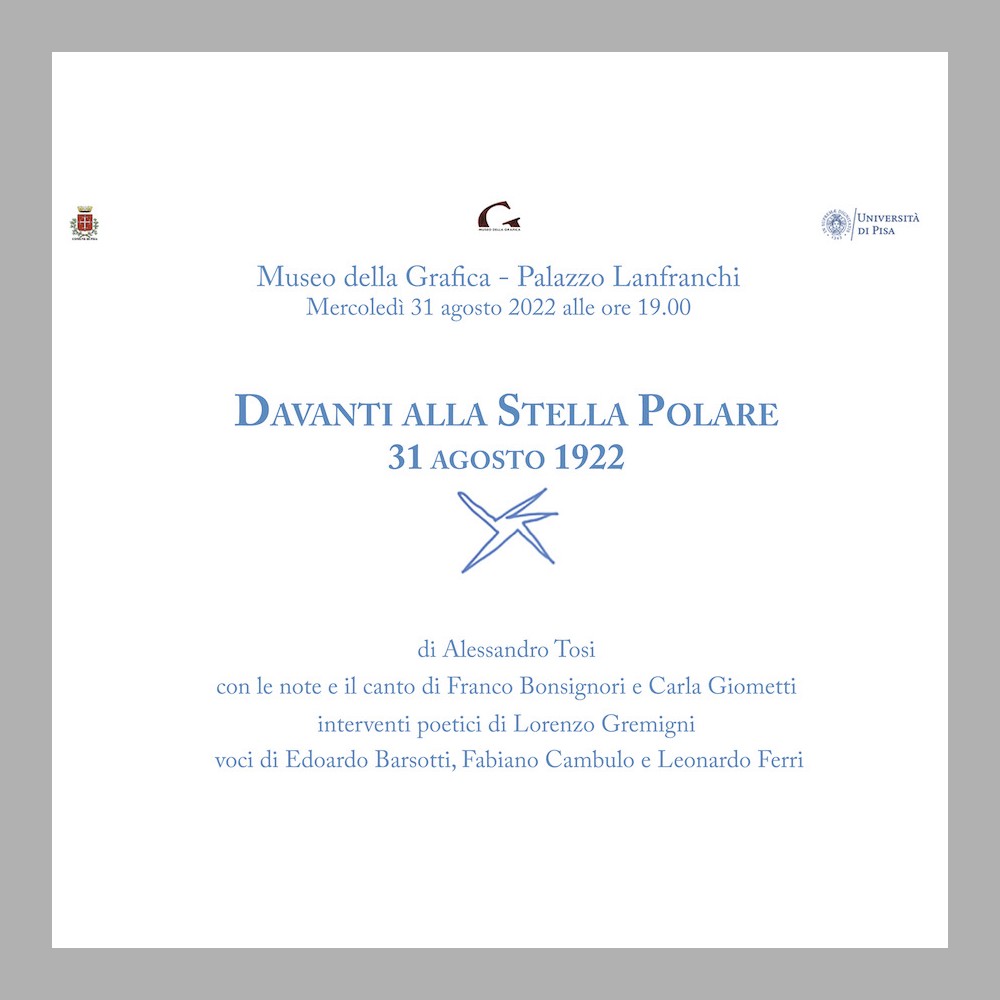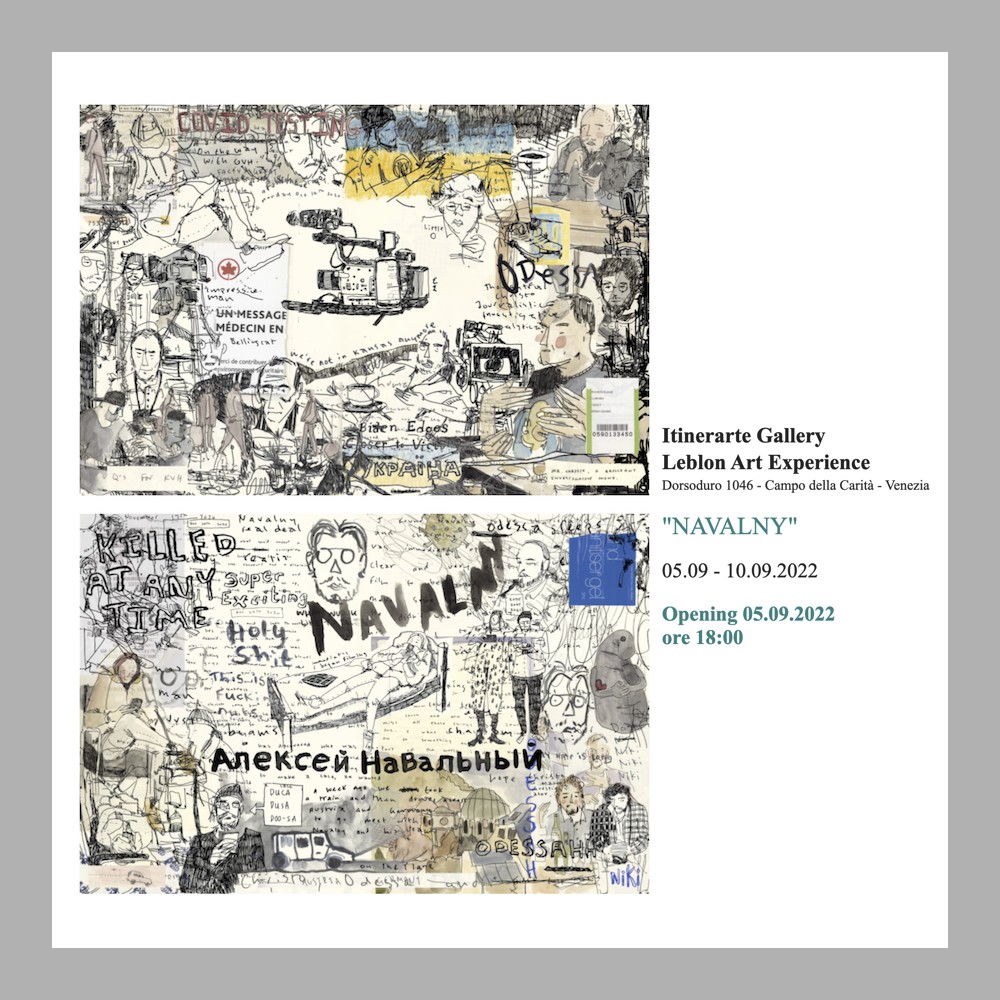Parte terza: La vigna
Storia segreta
Per questa strada passava mio padre. Passava di notte perch’era lunga e voleva arrivare di buon’ora. Faceva a piedi la collina, poi tutta la valle e poi le altre colline, finché sbucavano insieme il sole in faccia e lui sull’ultima cresta. La strada saliva alle nuvole, che si rompevano nel sole sopra il fumo della pianura. Io le ho viste queste nuvole: luccicavano ancora come oro; mio padre disse, ai suoi tempi, che quand’erano basse e infuocate gli promettevano una buona giornata. Allora sui mercati correvano pezze d’oro.
Ancor oggi i passanti vanno verso la pianura piegati innanzi col mantello sulla bocca. Non si guardano intorno, neanche se il tempo è sereno. Le ombre cadono dietro, sulla strada, e li seguono adagio. La collina li segue, col suo orizzonte uguale. Io conosco quest’orizzonte, ciascuno degli alberi piccoli che incorona le creste. So che cosa si vede da sotto quegli alberi.
Mio padre a prima luce non scendeva in pianura. Girava per coste e cascine a cominciare il mercato. Parlava nei cortili con gente assonnata. Facevano colazione. Bevevano un bicchiere taciturni sulla porta. Mio padre conosceva tutti quanti e sapeva le stalle di tutta la strada; sapeva le disgrazie, i bisogni, le donne. Parlava poco. Quando incontrava nei cortili altri sensali, stava zitto e lasciava che dicessero.
Anni e anni fa – era vedovo, e noialtri, bambini – qualcuno gli aveva detto di smetterla e attaccare il biroccino. Ma era inverno e lui diceva che il cavallo avrebbe patito su per quelle stradette. Col mantello sugli occhi e il berretto di pelo, partiva nella nebbia e saliva alla Bicocca due vallate lontano. Ci stava la Sandiana, ch’era la figlia di un suo amico, giovane e disperata da quando si vedeva sola in quelle vigne. Mio padre aveva in mente di portarsela in casa e farsi fare ancora un figlio. Ma lei passava le giornate addosso al fuoco, in una stanza come un pollaio, e non faceva che ripetere ch’era sola e che aveva paura. Poi si seppe che un sensale di fuori le aveva parlato di vendere e andarsene a vivere tranquilla in città. Mio padre sospettava qualcosa e pestò molta neve per venirne in chiaro, finché un giorno alla Bicocca trovò quell’altro che si scaldava i piedi al fuoco. Ma ancora non capiva chi poteva comprare la terra: sapeva l’idea di tutti là intorno. La donna diceva di no; mio padre tornò verso sera e trovò i figli del sensale che caricavano la roba. Allora capí di esser vecchio. La Sandiana andò a stare vicino al mercato.
Non parlava di queste cose con noi. Si sapevano dalla gente e dai sospiri che cacciava in quegli anni. Adesso, le volte che scendeva in città, passava a farsi il sangue cattivo là sotto. Era in un cortiletto basso, coperto di vite vergine, dove il rumore del mercato arrivava appena. Il sensale, venduta la terra, era tornato ai suoi paesi. La Sandiana aspettava, seduta alla stufa come una gatta. Per un pezzo mio padre le mandò un piatto caldo. Quell’inverno lo passò all’osteria. Veniva a sedersi, guardava il va e vieni, il fumo, i sensali, e pareva che ascoltasse i discorsi. Lasciava che gli affari li facessero gli altri. Pensava ancora a quella vigna.
La Sandiana per tutto l’inverno non uscí dal cortile. Senza terra, sapeva di non valere più niente; e, sul patto, era incinta. Si sfogava con la donna che le portava da mangiare, e diceva che i vecchi sono peggio dei giovani. Mandò a dire a mio padre che si voleva ammazzare. Mio padre lasciò che passasse l’inverno; poi riprese a battere le colline. A marzo gli dissero che s’era sgravata.
Allora venne a cercarla, e le propose di portarsela in casa. Dicono che la Sandiana, dimagrita, piangesse; ma so che mio padre dovette tagliar corto e dirle che veniva da noi per far la donna dove non ce n’erano, e non la padrona. Ma neanche la serva. Non eravamo signori.
Così diede una stanza alla Sandiana e al bambino, e lui continuò a dormir solo. L’idea di fare quel figlio era sfumata con la vigna. Neanche nell’estate, che la Sandiana rifiorí come una sposa e allattava, mio padre cambiò. Partiva col buio, e la Sandiana si levava a preparargli la roba. Tra loro parlavano appena. Noialtri ragazzi, messi su dalla serva, tendevamo l’orecchio per sentire qualcosa. La Sandiana piaceva anche a noi. Ci accudiva e aiutava.
Verso sera, d’estate, andavamo con lei per le campagne. Sapevamo la strada per dove tornava mio padre, e bastava che la tenessimo d’occhio dall’alto. Noi portavamo la Sandiana a vedere i nostri posti, e lei sapeva dirci il nome dei campanili e dei paesi più lontani. Ci descriveva quel che lassú da quei boschi si vedeva in pianura, e quel che faceva la gente nelle casupole isolate. Ci parlava di suo padre e di quando alla Bicocca erano in tanti, fratelli e sorelle, e la sera giravano con le lanterne a chiudere stalle e cantine. Raccontava di quando d’inverno i suoi nonni sentivano il lupo raspare alla porta e continuavano a vegliare e intrecciare cavagni. Prendevamo i sentieri attraverso le vigne, e chi primo arrivava, gridava e agitava le braccia sul cielo. Correva anche lei.
Quell’anno ero cresciuto, e nell’inverno avrei dovuto andare a scuola in città. La Sandiana mi diceva che ci sarei stato bene e avrei scordato il paese. Mi sarei vergognato di casa e di noialtri. Io capivo che aveva ragione, eppure, anche adesso che l’estate finiva, guardavo le strade, le nuvole, le uve, per stamparmi ogni cosa dentro e vantarmene poi. Avrei voluto anch’io esser nato alla Bicocca coi suoi vecchi e aver conosciuto i fratelli e provato quelle notti che venivano i lupi. Di questo avrei voluto vantarmi, e ascoltando la Sandiana sapevo che me ne sarei vantato. Così era fin da allora: godevo non le cose che facevo ma quelle che sentivo dagli altri. Non sembravo mio padre.
La casa della Sandiana era in mano a due vecchi, mezzadri di un signore che l’aveva ricomprata e che nessuno conosceva. Andavamo sovente su quella collina e di là si vedevano i pini, neri dietro la casa, alti in mezzo alle vigne come campanili, pieni d’uccelli che volavano. La Sandiana ci portò una volta fin nel cortile; c’era un cane che la riconobbe e le corse addosso saltando. Allora uscí la vecchia, e si parlarono e girarono insieme nella casa e sull’aia. Noi aspettammo nel cortile, sotto il pagliaio, e tiravamo dei sassi nel pino più grosso. Io guardavo il sentiero che dai beni portava al pozzo. Non ero mai stato in un cortile più vuoto, sembrava abbandonato: anche il cane che mugolava di sopra con le donne non l’avevo mai visto: non la voce di un cane ma più fiera. Pensavo a quei tempi che i fratelli della Sandiana giravano i boschi. Il bosco era nero, profondo, sull’altra sponda della collina. Quando tornò con la Sandiana e si lamentavano insieme, la vecchia ci disse che voleva darci qualcosa – una cotogna – ma non ne trovò. La Sandiana rideva, contenta.
Il cane voleva venire con noi; lo legarono al filo. Per tornare passammo da un altro sentiero, e per tutta la strada la Sandiana non parlò: disse soltanto di non dire a mio padre ch’eravamo saliti lassú, perché era troppo lontano. Ma quella sera mi chiese se sapevo che mio padre ci fosse venuto quell’estate. Le risposi che avrebbe dovuto domandarlo alla vecchia, e lei allora stette zitta.
Un mattino trovammo mio padre in cucina. Non era domenica, ma tutto aveva l’aria insolita. Tornò la Sandiana dal cortile con una faccia agitata e i capelli negli occhi. Il bambino piangeva e mandarono la serva a calmarlo. Mio padre comandava e scherzava. Non era ancora il giorno ch’io dovessi partire, e non capivo il perché dell’agitazione, ma poi lo seppi da una parola della serva. La Bicocca era nostra; mio padre l’aveva comprata.
Partirono sul biroccino lui e la Sandiana. La serva quel giorno fu cattiva e ci disse, come fossimo uomini, che ormai la padrona era l’altra e la Bicocca era sua e di suo figlio. Aspettammo tutto il giorno che tornassero. Io speravo che almeno girare nel bosco la Sandiana mi avrebbe lasciato, e per meritarmelo accudii il bambino che – la serva diceva – era ormai mio fratello. Pensavo più di tutto a quei fratelli morti, e godevo a sapere che sarebbero stati anche i miei. Quella sera la serva disse a mio padre che bisognava far festa e andò a prendere il vino.
Tanti anni eran passati e dovevano ancora passare, nell’inverno andai in città e cambiai vita; ci tornai l’anno dopo, divenni un altro; venivo in paese per le vacanze e Così mi sembrò di esser stato ragazzo soltanto d’estate. La Sandiana era sempre la stessa; il bambino era morto; Così il tempo in casa nostra non passò quasi più. Tutti gli anni l’estate fu come quando non andavo ancor via, un’unica estate che durò sempre.
Tutti gli anni io guardavo le nuvole, le uve e le piante per vantarmene in città, ma, non so come, pensavo a tutt’altro laggiú e non ne parlavo. Doveva aver ragione la Sandiana che mi chiedeva sempre se i compagni mi avevano canzonato e se sarei tornato ancora nella vigna. Ma nella vigna io ci tornavo felice e le chiedevo se veniva anche lei. Il giorno stesso che rientravo a casa facevo il giro delle strade e dei sentieri, e quei mattini mi svegliavo contento se era sole e più contento se pioveva, perché non c’è che l’acqua fresca per metter voglia di girare la campagna. La Sandiana rideva se tornavo bagnato e infangato e mi diceva che sarebbe venuta anche lei – una volta.
Non venne, ma una sera ci prese il temporale sulla strada, e noialtri ragazzi avevamo paura del tuono, la Sandiana del lampo. A me il lampo piaceva, quella luce violetta improvvisa che inondava come un’acqua, ma la Sandiana raccontò ch’era di zolfo e che uccideva con la scossa. — Se non è niente, – le dicevo, – si vede una luce che passa. — Tu non sai, – mi rispose, – dove tocca ammazza. Mamma mia —. Io allora fiutavo nell’aria bagnata e sentii finalmente l’odore del lampo: un odore nuovo, come d’un fiore mai veduto, schiacciato tra le nuvole e l’acqua. — Senti? — le dissi; ma la Sandiana si premeva con la mano sulle orecchie, sotto il portico dov’eravamo rifugiati. Il profumo ci durò fino a casa: era fresco, pungeva dentro il naso come quando si tuffa la faccia nel catino. La Sandiana diceva che quello era vento passato sui boschi, ma non l’avevo mai sentito prima: era davvero l’odore del lampo. — Chi sa dove è caduto, — disse.
Ma non volle venire a cercarlo. Doveva esser caduto nei boschi, sapeva troppo di selvatico. Ora capivo perché tante cose strane si raccontano dei boschi, perché ci sono tante piante, tanti fiori mai veduti, e rumori di bestie che si nascondono nei rovi. Forse il lampo diventa una pietra, una lucertola, uno strato di fiorellini, e bisogna sentirlo all’odore. Di terra bruciata ce n’era sí, ma la terra bruciata non sa quel profumo d’acqua. La Sandiana mi rispondeva e diceva di no. Nel bosco della Bicocca c’era uno spacco dentro il tufo. La Sandiana diceva ch’era stato un terremoto prima ancora che noialtri nascessimo. Nessuno se non qualche biscia poteva passarci. Ma io avevo visto una volta lassú un bel fiore lilla e chi sa che il suo odore non fosse lo stesso del lampo. Capivo che il tuono facesse gli spacchi ma il temporale cadeva dal cielo e qualcosa di bello doveva portare. — Macché, – disse la Sandiana, – tutto quello che nasce, è fatto di terra; acqua e radici sono in terra; dentro il grano che mangi e il vino d’uva c’è tutto il buono della terra —. Io non avevo mai pensato che la terra servisse a fare il grano e a mantenerci, tanto più adesso che studiavo. Se anche avevamo la Bicocca, non eravamo contadini. Ma quando mangiavo le frutta, capivo.
Le frutta, secondo il terreno, hanno molti sapori. Si riconoscono come fossero gente. Ce n’è delle magre, delle sane, delle cattive, delle aspre. Qualcuna è come le ragazze. Ci sono fichi e uva luglienga alla Bicocca che sanno ancora di Sandiana. Io ne ho mangiate di ogni sorta, e specialmente la selvatica, le prugnole e le nespole acerbe.
Specialmente le prugnole mi facevano gola. Ancora adesso lascio tutto per le prugnole. Le sento a distanza: fanno siepi spinose, verdissime lungo le forre, in mezzo ai rovi. Alla fine d’agosto i rami ingrossano di chicchi azzurri, più scuri del cielo, agglomerati e sodi. Hanno un sapore brusco e asperrimo che non piace a nessuno eppure non mancano di una punta di dolce. Con novembre son tutte cadute.
Che le prugnole sappiano di succhi selvatici, si capisce anche dai luoghi dove crescono. Io le trovavo sempre all’orlo delle vigne, dove il coltivo finisce e più nulla matura se non l’arido del terreno scoperto. Allora non pensavo a queste cose; avrei solamente voluto che mio padre, la Sandiana e tutti quanti mangiassero prugnole. Degli altri non so; la Sandiana diceva che le mordevano la lingua. — Per questo mi piacciono, – dicevo io, – loro sí che si sente che crescono nella campagna. Nessuno le tocca eppure vengono. Se la campagna fosse sola farebbe ancora delle prugnole.
La Sandiana rideva e diceva: — Sapessi… — Sapessi cosa? Fin che un giorno mi disse che di là dai suoi boschi dopo un’altra vallata, alla Madonna della Rovere la costa era tutta una prugnola. — Ci andiamo? – Era troppo lontano. – Ma nessuno le coglie? — chiedevo.
A questo ci pensavo sempre. Non soltanto non bastavo a scoprire tutte quelle delle nostre strade, ma tante colline c’erano al mondo, tanta campagna sterminata, e dappertutto prugnole, su per le rive, nei fossi, in luoghi impervi, dove nessuno anche volendo arriva mai. Me le vedevo con le foglie ricciute, coi rametti pesanti di frutto, immobili, in attesa di una mano che non sarebbe mai venuta. Oggi ancora mi pare un assurdo tanto spreco di sapori e di succhi che nessuno gusterà. Raccolgono il grano, raccolgono l’uva, e non ce n’è mai abbastanza. Ma la ricchezza della terra si rivela in queste cose selvagge. Nemmeno gli uccelli, selvaggi anche loro, non potevano goderne, perché le spine dei rametti li ferivano negli occhi.
Allora pensavo alle cose, alle bestie, ai sapori, alle nuvole che la Sandiana aveva conosciuto quando stava nei boschi, e capivo che tutto perduto non era, che ci son delle cose che basta che esistano e si gode a saperlo. Anche le prugnole, diceva la Sandiana, non se ne mangia più di due tre alla volta. Ma è un piacere sapere che ce n’è dappertutto.
Già a quel tempo bastava che dicesse un paese, e mi pareva di vederlo. I suoi paesi erano fatti di cascine, di canneti e di raccolti, come i miei. Mi pareva di esserci stato o di poterci andar domani. Qualcuno ne spuntava dietro ai boschi. Eppure se salivo in biroccino con mio padre partivo come alla scoperta. C’era di mezzo quel selvatico che lei non sapeva ma io mettevo dappertutto.
Una strada e un canneto sono cose comuni, per lo meno da noi, ma avvistati Così in lontananza sotto una cresta e sapendo che dietro ci sono altre creste altri canneti e per quanto si passi tra loro ne restano sempre dove noi non andremo e qualcuno c’è stato e noi no – ecco questo pensavo ascoltando la Sandiana. Invidiavo mio padre ch’era stato in tanti luoghi e aveva fatto quelle strade e quelle creste giorno e notte. Che fosse fatica lo seppi più tardi. Ora mi accontentavo di guardarlo la sera quando saliva taciturno i tre scalini o aspettava noialtri. In quel momento non pareva più mio padre. Gli si capiva in faccia che veniva da lontano e ch’era stanco – aveva negli occhi anche lui quel selvatico. Era tanto stanco che, se la Sandiana lo chiamava, veniva senza risponderle. Dei paesi tra loro non parlavano mai.
Qualche volta ci portava in biroccino per un tratto, ma poco, perché il cavallo faticava già troppo con lui. Andammo sempre più lontano a piedi. Solamente al principio e alla fine dell’estate facevo con lui lo stradone della città e lui guidava, io pensavo a quei giorni che laggiú c’era stata la Sandiana, e mi pareva tanto tempo perché allora la città non l’avevo mai veduta. Gli chiedevo s’era vero che da giovane ci scappava di nascosto, e lui brusco, scherzando, diceva che ci andavano i vecchi soltanto, a vedere la festa, e tornavano a piedi la notte mentre loro ragazzi contavano le botte e guardavano i riflessi in lontananza. — Adesso hanno troppi palazzi, – diceva, – e si vergognano di noi delle campagne. Si divertono al chiuso. Non vale più la pena di venirci —. Nel fresco dell’alba stavo attento per accorgermi dove finiva lo stradone e cominciavano i palazzi e c’era sempre come un fumo dorato e nebbioso che sembrava un’altr’aria e uno c’entrava a poco a poco e, una volta arrivato, pareva impossibile che ci fossero ancora dei paesi e delle colline. Lontano, chi sa dove, c’era il mare. Lo dicevo a mio padre, e lui rideva, brusco.
Adesso che il tempo è passato e quelle estati le ricordo, so che cosa volevo dalla Madonna della Rovere. Una siepe di prugnole mi chiudeva l’orizzonte, e l’orizzonte sono nuvole, cose lontane, strade, che basta sapere che esistono. La Madonna della Rovere è sempre esistita, e dappertutto, sulle coste, sulle creste dei paesi, ci sono chiese e masse d’alberi impiccolite nella distanza. Dentro, la luce è colorata, il cielo tace; e donne come la Sandiana ci stanno in ginocchio e si segnano, qualcuna c’è sempre. Se una vetrata della volta è schiusa, si sente un soffio di cielo più caldo, qualcosa di vivo, che sono le piante, i sapori, le nuvole.
Queste chiese di cresta sono tutte Così. Ce n’è sempre qualcuna più lontana, mai vista. Nel porticato di ciascuna è tutto il cielo e vi si sentono le prugnole e i canneti che il cammino non basta a raggiungere. Tanto vale fermarsi a due passi e sapere che tutta la terra è un gran bosco che non potremo mai far nostro davvero come un frutto. Anzi, le cose che ci crescono a due passi hanno il loro sapore da quelle selvatiche, e se il campo e la vigna ci nutrono è perché affiora alle radici una forza nascosta. Mio padre direbbe che al mondo tutto viene dal basso. Io non so né sapevo di questo, ma la Madonna della Rovere era come il santuario delle cose nascoste e lontane che devono esistere.
Quando anni fa morí mio padre, trovai nel mio dolore un senso di calma che non mi aspettavo eppure avevo sempre saputo. Andai in chiesa e al cimitero; rividi le donne col velo sul capo e i quadretti della Via crucis, sentii l’odore dell’incenso e di terra scavata. Più abbattuta di me, la Sandiana pregò sulla tomba; poi ritornammo a casa insieme e lei ci preparò la cena. Da molto tempo non tornavo, e il cortile mi parve più piccolo. Parlammo di mio padre e della Bicocca, della vendemmia e della morte, poi a notte avanzata rimasi solo alla finestra.
In quei giorni ripensai molte cose che avevo dimenticato. Pensai che mio padre ora esisteva come qualcosa di selvatico e non aveva più bisogno di girare giorno e notte per dirmelo. La chiesa, com’è giusto, l’aveva inghiottito, ma la chiesa anche lei non va di là dall’orizzonte e mio padre sotterra non era cambiato. Da corpo di sangue era fatto radice, una radice delle mille che tagliata la pianta perdurano in terra. Queste radici esistono, la campagna ne è piena. I finestroni colorati della chiesa non cambiano niente, e anzi fanno pensare che nulla muta neanche fuori sotto il cielo, e che quanto è lontano o sepolto continua a vivere tranquillo in quella luce. Ora in tutte le cose sentivo mio padre; la sua assenza pungente e monotona condiva ogni vista e ogni voce della campagna. Non riuscivo a richiuderlo dentro la bara nella tomba stretta: come in tutti i paesi di queste colline ci son chiese e cappelle, Così lui mi accompagnava dappertutto, mi precedeva sulle creste, mi voleva ragazzo. Nei luoghi più suoi mi fermavo per lui; lo sentivo ragazzo. Guardavo dalla parte dell’alba la strada e la città nascosta in fondo dove – quanto tempo fa? – lui era entrato un mattino, col suo passo campagnolo e raccolto.
Parlavamo di lui. La Sandiana bambina l’aveva veduto ballare e sapeva la voce che aveva a quei tempi. Diceva che invece di aiutare in campagna, lui già allora era sempre per strade e comprava i cavalli. Comprava e vendeva, ma più che il commercio gli piaceva girare. Lui sí che i paesi li aveva veduti. Nostra madre l’aveva trovata in città e sposata senza dirlo a nessuno, poi tornato in paese e rifatta la pace aveva dato un grosso pranzo di nozze. La prima delle mie sorelle era nata due giorni dopo quel pranzo.
Allora mio padre era allegro e manesco. La Sandiana diceva che a quarant’anni si mise coi suoi fratelli e andava in giro con loro scherzando come un giovanotto. Si vedevano sempre alla Bicocca ma lei non pensava che l’avrebbe sposato. Ci veniva mia madre a cercarlo quando stavano fuori la notte. Mia madre era giovane, sempre spaventata, e sembrava una figliola accanto a lui. Chi avrebbe pensato che doveva morire la prima. La Sandiana scordava mio padre e parlava di donne, di loro.
Io tacevo e rivedevo la città nella nebbia. Non era questo che cercavo di lui. Le donne l’avevano fatto mio padre, ma c’era qualcosa di più antico di questo, di più segreto e sepolto per sempre. Voglio dire, un ragazzo. Come me anche mio padre era entrato in città, non per chiudersi in scuola ma per fare fortuna. C’era entrato selvatico e non era cambiato. Mi chiedevo che cosa l’aveva cacciato laggiú, quale rabbia, quale istinto, lui che pure era nato in un campo. La città sonnolenta gli era parsa superba alla fine, e non ci s’era mai fermato, ma le sue donne le aveva trovate laggiú, anche l’ultima, anche quella che veniva dalla Bicocca. Forse sapeva tutto questo da principio. Forse anche lui cercava in città l’ignoto, il selvatico.
Qui mi voltavo alla Sandiana e le chiedevo se mio padre non aveva mai pensato di fermarsi in città. Lei sembrava non capire e mi diceva che in quel caso non avrebbe comperato la Bicocca. Invece capiva benissimo: la risposta era quella. A mio padre piaceva venire in città da una terra: il suo lavoro si faceva sopra un’aia, e d’aia in aia la città glielo pagava. Palazzi e mercato per lui volevano ancor dire pezze d’oro, carrate di sacchi e di botti, campagna. Nella città non conosceva veramente se non quelli che venivano dai campi come lui. Con gli altri scherzava. Così era stato da ragazzo e Così era morto.
Adesso era inutile salir quelle creste per essere solo con lui. Mi bastava incontrare un canneto, un fico storto contro il cielo, una terra vangata, per commuovermi e contentarmi. Quel che c’era lontano, di là dalle creste, la città, la pianura fumosa, se ne stava sepolto, nulla più che una chiesa coperta dagli alberi sull’orizzonte.
Invece i gerani che la Sandiana teneva sulla finestra, mi parevano davvero città. Avevano un colore vivacissimo come soltanto i rosolacci, ma dalla forma complicata e dalle foglie si capiva che non crescono in terra. S’avvicinava l’ora che ne avrei veduti molti in pianura, sui terrazzi delle ville. Quando vedevo la Sandiana alla finestra per bagnarli, mi pareva che anche lei fosse qualcosa di mai visto, di scarlatto come loro.
La Sandiana era come una forestiera; quel che faceva lei sembrava sempre nuovo, tanto più adesso che non c’ero che d’estate. Quando andavamo alla Bicocca la seguivo dappertutto, nelle stanze rossastre, sui solai, davanti alle finestre. C’erano contro i muri cassapanche massicce, sempre chiuse, e i pavimenti di mattoni eran coperti di grano, di patate, di meliga. Per traversarli bisognava scalzarsi. La Sandiana girava, toccava e vedeva. — Chi sa che freddo fa d’inverno in queste stanze — dissi una volta. — Non fa freddo dappertutto? — mi disse lei, brusca. Sembrava che fosse la casa di un altro e che lei ci tornasse per impararla sempre meglio. Era felice, si capiva.
— Vedi, tuo padre, – diceva, – ha comperato tutto questo per voialtri.
Non appena arrivava, tirava su l’acqua dal pozzo e la portava in cucina. Se i contadini erano fuori a far fieno o qualcosa, si legava un fazzoletto sul capo e ci andava anche lei. Io salivo i sentieri di punta a cercare le prugnole in fondo alle vigne, e di là vedevo che si muoveva in mezzo al campo. Già allora mi piaceva appiattarmi in quella solitudine, nell’incolto sotto gli ultimi filari, a due passi dal bosco. Poi mi prendeva la paura e ritornavo a rompicollo dal sentiero. Vedendomi correre ridevano tutti.
— Se scappi, – dicevano, – la paura ti acchiappa.
Era qualcosa, la paura, che per tutti esisteva. La Sandiana mi disse che dovevo resistere. — Se stai fermo al tuo posto, la paura si spaventa. Ma se scappi ti vien dietro come il vento di notte —. Le risposi che avevo paura anche al chiaro. — Quand’è chiaro la devi guardare negli occhi. Lei scappa a nascondersi —. Ma l’idea di guardar la paura mi spaventava ancor di più. — Tu l’hai vista? – le chiesi. – Com’è?
— Se l’hai vista anche tu.
— Io no.
La Sandiana rideva. — Stacci attento alla prima occasione. Vedrai com’è fatta.
Questi discorsi mi mettevano in orgasmo. — Non è soltanto la paura, – dicevo. – Quando sto solo nella vigna o sotto il portico, aspetto qualcosa. Mi par sempre che deva succedere. Delle volte ci vado apposta. Se non fosse che scappo vedrei che cos’è.
— E tu fermati, — diceva la Sandiana.
— È una cosa come quando per stirare metti il ferro alla finestra. Sopra la brace si vede il cielo tremare. Hai già visto?
— Sí.
— Tu in campagna non vedi mai niente?
— Ne vedo sí.
— No, tu ridi. A me sembra che dalla terra esca un calore continuo che tien verdi le piante e le fa crescere, e certi giorni mi fa senso camminarci perché dico che magari metto il piede sul vivo e sottoterra se ne accorge. Quando il sole è più forte si sente il rumore della terra che cresce.
A nessun altro confidavo queste cose. Ma la Sandiana diceva che avevo ragione; raccontava che una volta aveva un fiore che si apriva ogni mattina sotto il sole e si muoveva.
— Ce ne sono nei boschi?
— Chi lo sa, – disse la Sandiana. – Nei boschi c’è di tutto.
Nei boschi andavamo qualche volta per funghi, ma bisognava che avesse piovuto, e la Sandiana ne trovava più lei sola che tutti noialtri. Lei sapeva il terreno e ficcava la mano sotto le foglie marce: non si sbagliava mai. Delle volte io passavo, guardavo, non ce n’era nessuno. Veniva lei, sembrava che le fossero cresciuti sotto i piedi. Mi diceva ridendo che i funghi crescono di colpo, dalla sera al mattino, da un’ora all’altra, e che conoscono la mano. Sono come le talpe, si muovono; li fa l’acqua e il calore. Peccato che la strada era lunga, sapevo venirci soltanto con lei. Partivamo da casa al mattino e arrivavamo sulle creste sudati. Passavamo una valle e una costa, perdevamo i sentieri. Quelle notti, nel letto, tutta quanta la collina mi pareva un vivaio caloroso di pioggia e di funghi, che solamente la Sandiana conosceva a palmo a palmo.
— Mio nonno diceva, – mi disse una volta, – che ogni fatica che si fa in campagna, ritorna in forza dentro il sangue nella notte. C’è qualcosa nel terreno, che si respira sudando. E diceva che è meno fatica camminare sui beni che non sulla strada. Era già vecchio e non voleva mai saperne.
— Perché sulla strada?
Chiedevo ma avevo capito. La Sandiana mi guardò se dovesse scherzare.
— Perché. Sulla strada non zappi.
— Ma è terreno anche quello.
— Vallo a chiedere a lui.
Alla Bicocca nella balza di tufo, proprio dietro la casa, c’era uno scavo profondo che faceva cantina, e là dentro tenevano attrezzi, carrette, robe. Mi misi in testa che l’avesse scavato quel nonno. Col tempo la muraglia di roccia s’era fatta grigia, ma nel fondo dov’era più scuro, sudava ancora umidità e c’era un pozzetto. Qui ci cresceva il capelvenere. Ragazze in paese dissero che il capelvenere è una bella pianta, e la Sandiana andò una volta per sbarbarne e farne un vaso. Io le tenevo la candela.
— Qui siamo sotto la collina, — dissi.
— È più fresco che sopra.
Fin che restammo sottoterra io pensavo a suo nonno e dicevo che l’acqua è il sudore delle radici. Lo dicevo tra me perché avevo paura che la Sandiana mi burlasse. Ma non mi tenni che le chiesi se non vengono sotterra anche i gerani. — Sei matto, — gridò. Poi mi chiese perché.
— Si somigliano.
— Come?
— In campagna non vengono.
La Sandiana mi chiese: — Non siamo in campagna?
Allora capii ch’era inutile dirlo e m’accorsi ch’era vero, la campagna non è solamente la terra ma tutto quello che c’è dentro. Mi venne voglia di restarmene là sotto, e che fuori piovesse, crescessero gli alberi, passasse la sera e il mattino. «Qui di notte è già buio, – pensai, – dentro la terra è sempre notte».
Ci tornai qualche volta da solo, ma come dappertutto dov’era silenzio, tendevo l’orecchio perplesso. Dalla soglia spiavo nel buio. Credevo di udire il gorgoglío dell’acqua che sudava dal tufo, inzuppava la volta, scorreva tutta la collina. Pensavo a quel vecchione che camminava solamente sui sentieri. Lui sí che doveva sapere che cosa è campagna. Ma adesso era morto e sepolto, e con un passo ero in cortile sotto il cielo.
Quel che dicevo alla Sandiana accadeva nell’ora che tutti dormono, tra pranzo e merenda, quando il sole brucia e ancora adesso esco a girare. Esco in mezzo alle case, nel riverbero bianco, e penso a quello che pensavo allora. Credo che mi annoiavo e anelavo il momento che la giornata riprendesse, ma è nella noia che toccavo il fondo della giornata e dell’estate. Nulla accadeva, nemmeno una voce, nei cortili e sulle coste, e questo vuoto m’incantava come se il tempo si fermasse nell’aria. Venivo al punto che ogni cosa era possibile e vigeva; solamente, non capivo perché in tanto fervore ogni cosa tacesse. Allora guardavo le formiche in terra, o le piante lontano, minuscole anch’esse sulla grande costa; e le formiche irrequiete e le piante sembravano smarrite anche loro nel tempo. La collina è tutta fatta di cose distanti, e a volte rientrando salivo a osservarla nella finestra dei gerani. Tra i gerani e le creste calcinate nel sole c’era comune la distanza, la ricchezza nascosta. Io guardavo dai fiori alle creste ma senza sapere perché lo facessi; né l’avrei detto alla Sandiana che mi voleva canzonare. Mi serviva piuttosto anche lei da finestra, e molte volte la guardavo come guardavo quei gerani, fioriti in città. Anche lei c’era stata a suo tempo.
La città aveva viuzze raccolte, dove s’aprivano portoni sui giardini improvvisi. Li intravedevo andando a scuola e pensavo che fossero una nuova campagna più segreta e più bella. Sapevo certo che mio padre non li aveva mai guardati e non osavo domandargliene. Ma la Sandiana ch’era stata in quelle viuzze, doveva averli conosciuti; e cercai di riconoscere la sua vite vergine, che d’inverno era rossa più del fuoco. Né mio padre né lei me ne avevano mai detto nulla; da chi l’avessi sentito non so. Ma nei cortili non mettevo piede, m’accontentavo di passare; quando c’era una vite mi chiedevo perché la Sandiana non fosse rimasta, e immaginavo di venirci adesso, di salire le grandi scale solenni, di stare con lei nel palazzo. Qualche volta d’inverno venivano insieme a vedermi la domenica, e avevo il permesso di uscire con loro, con lei; ma dei tempi ch’era stata in città non le sapevo mai parlare. Mi portavano fino al mercato dove mio padre comandava merenda; poi lui si fermava con l’oste discorrendo, noialtri uscivamo a vedere la gente a passeggio. Prendevamo dai portici fino al Castello; c’erano donne ben vestite, signori, soldati, e ragazzi come me ma più ricchi, e tutti andavano adagio, si fermavano un poco, tornavano, facendosi segno e vociando. M’incantavano nel freddo le porte dei caffè piene di fumo e dorate, ma la Sandiana mi tirava per la mano, se mi staccavo s’inquietava, e assisteva tra curiosa e impaziente fin che avessi veduto ogni cosa. Preferivo le volte che aveva da fare e tagliavamo nella folla, correvamo le viuzze deserte dei miei giardini. Faceva freddo, ma potevo sempre dirle quali fiori ci fossero nella bella stagione e le chiedevo chi ci stesse nei palazzi e se non c’era mai salita. Lei mi chiedeva di dov’erano i compagni, e invidiava i più ricchi, ma diceva che i ricchi non stanno mica nei palazzi, ci fa troppo caldo e l’aria è chiusa, vanno invece in campagna dove hanno le ville, nelle montagne e al mare. Così parlavamo del mare; conoscevo diversi che d’estate ci andavano, lei stava a sentire e mi chiedeva se da uomo ci avrei condotti i miei bambini. Ma io non pensavo a bambini, pensavo a me stesso su coste lontane e a lunghi viaggi; passavamo davanti ai portoni e Così i fiori più ricchi e nascosti si confondevano col mare nel mio cuore. Pensavo allora alla finestra dei gerani come a uno sfondo di luoghi marini. La sera rientravo dai compagni carico di frutta, e ne davo ai più degni e mangiavamo ripetendoci le storie più assurde.
Così la ricchezza, ch’era tutta la giornata di mio padre, per me si faceva fantasticheria e perdeva quell’astio con cui la sentivo agognata da tutti. Non capivo quell’astio. Non capivo, a dir vero, cosa fosse ricchezza. Mi pareva qualcosa di esotico che di là dall’orizzonte promettesse stupori, come una luna di settembre ancor nascosta dalle piante. Non capivo i rapporti del grano e dell’uva coi palazzi e la vita in città. La Sandiana che girava la Bicocca misurando i raccolti con occhio cattivo, mi scoraggiava: io cercavo le prugnole. Una volta senza dirmelo fece roncare una riva d’incolto per metterla a grano: arrivai ch’era tutto finito e i cespugli buttati: le diedi dei nomi, minacciai, tirai calci – lei rise. Non capiva le lacrime, e perciò non piansi. Tanto feci che divenne cattiva e lo disse a mio padre, che mi picchiò. Mi canzonarono poi tutta la sera perché non capivo le cose. Io piansi di nascosto, e per vendetta mi vietai per un pezzo di guardar la collina attraverso i gerani. Ma la guardavo dai canneti della strada, dove basta fermarsi e si è soli, e anche qui la lontananza, filtrata dal canneto, pareva nitida e più azzurra, tra fiorita e marina. A salire più in alto – ma ci andavo di rado e non solo – s’intravedeva la pianura; e minuscole chiazze sperdute nel vago, ch’eran case o paesi, parevano vele, arcipelaghi, spume. Eran queste le cose che portavo con me nell’inverno in città; e non le dicevo, le chiudevo orgoglioso nel cuore. Ascoltavo i compagni parlare e vantarsi; io stavo zitto, non perché non godessi a sentirli, ma piuttosto capivo che le cose proprio vere non si riesce a raccontarle. Non soltanto è necessario che chi ascolta le sappia, ma bisognava già saperle quando si sono conosciute, e insomma è impossibile saperle da un altro. Io stesso mi chiedevo quando avevo cominciato a sapere, ma era come se mi avessero chiesto quando avevo conosciuto mio padre. La Sandiana un bel giorno era venuta a star con noi, eppure nemmeno di lei ricordavo che prima non c’era. A quei tempi sapevo soltanto che niente comincia se non l’indomani.